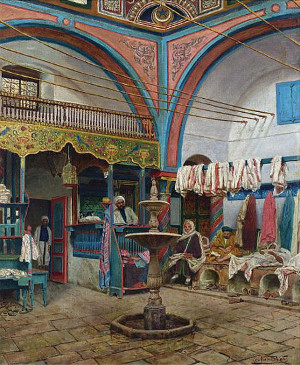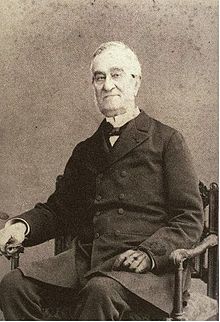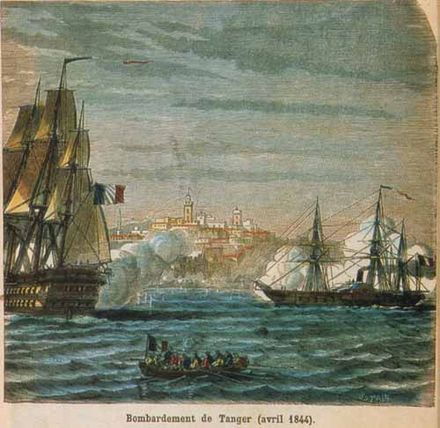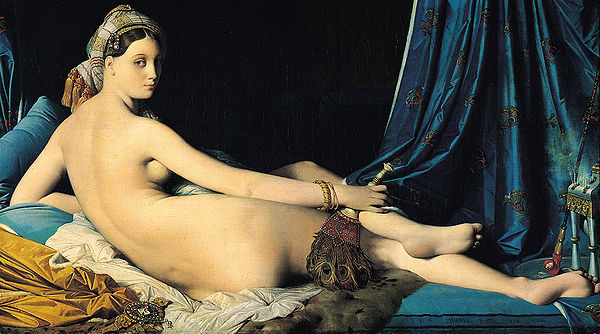L'Eclettico
Orientalismo d’Italia
Un arabesco di intrecci fra arte e storia
L'ECLETTICO - web "aperiodico"
ORIENTALISMO D’ITALIA
Un arabesco di intrecci fra arte e storia
Sogno esotico di un Oriente vagheggiato o puntuale descrizione di terre lontane dall’esperienza quotidiana? Un po’ l’uno ed un poco l’altra: questo è stato l’Orientalismo, almeno nella sua declinazione italiana che abbiamo potuto conoscere visitando la mostra ORIENTALISMO. In viaggio dall’Egitto a Costantinopoli prodotta dalla GAM di via Manzoni a Milano.
Una proposta di sicuro interesse per gli appassionati del genere, ma che hanno apprezzato anche gli amanti della pittura ottocentesca nella sua accezione più generale e chi è semplicemente animato da curiosità, come chi scrive. Per quanto ci riguarda è stata infatti l’occasione di incontrare, per la prima volta in un approfondimento tematicamente omogeneo, un ennesimo tassello dell’incredibile mosaico di stili e correnti artistiche circolate in Europa fra Otto e Novecento che rivelano sempre nuove ramificazioni ad ogni tentativo di approfondirle ed esaurirle compiutamente.
Più precisamente, l’Orientalismo è una corrente pittorica che si affaccia sulla scena artistica in Francia alla fine del Settecento per poi svilupparsi nell’Ottocento soprattutto in Francia ed in Inghilterra.
Interessato a stupire il pubblico rappresentando paesaggi, ambientazioni ed atmosfere tipici del mondo orientale, il movimento nasce nel più ampio contesto di tendenze provenienti dall’esotismo, che hanno influenzato il mondo culturale e artistico dell’Europa, soprattutto fra il Settecento e il Novecento, e come evoluzione del Romanticismo che, dalla prima metà dell’Ottocento, era entrato in relazione dialettica con il Neoclassicismo ed il cui più noto esponente in Italia era stato Francesco Hayez (Venezia, 10 febbraio 1791 – Milano, 12 febbraio 1882).
HAYEZ FILELLENO
Come esempio della sua pittura, anticipando qui quanto si dirà più avanti della Guerra d’indipendenza greca, ne pubblichiamo I profughi di Parga.
Sono due le motivazioni che ispirano al pittore questo soggetto. Anzitutto la Storia, che nel 1819 vede il piccolo paesino greco di Parga, località sulla costa Ionica della Grecia, di fronte a Corfù, all’epoca sotto la protezione inglese, ceduto al nemico ottomano con tutti i suoi abitanti trattati come oggetti. In secondo luogo la Letteratura: un poemetto di Giovanni Berchet pubblicato nel 1823 che, con questo titolo, raccontava il triste fatto di pochi anni prima.
Terminato nel 1831, il dipinto si colloca sulla scia di una delle “correnti” del romanticismo, il filellenismo, che vede i maggiori intellettuali europei schierarsi a favore del popolo greco, insorto “ufficialmente” contro il dominio turco nel 1821, ma che già covava volontà indipendentiste da molto prima. Tema centrale dell’opera è, infatti, l’orgoglio nazionale, il categorico rifiuto di sottostare alla dominazione nemica, le stesse spinte, in sostanza, che avevano portato i profughi di Parga a lasciare la loro cittadina per migrare verso le isole di Cefalonia e Corfù.
 L’Orientalismo raggiunge l’apice della sua massima espressione fra il 1860 e il 1880, poi declina per tornare a rinverdire negli anni ’20 del Novecento per via del ritrovamento della tomba di Tutankamon (il 4 novembre 1922) che ravviva l’interesse per questi soggetti.
L’Orientalismo raggiunge l’apice della sua massima espressione fra il 1860 e il 1880, poi declina per tornare a rinverdire negli anni ’20 del Novecento per via del ritrovamento della tomba di Tutankamon (il 4 novembre 1922) che ravviva l’interesse per questi soggetti.
È di questo periodo (autunno 1921), ad esempio, l’Odalisca in pantaloni rossi di Henri Matisse (Le Cateau-Cambrésis, Francia, 31 dicembre 1869 - Nizza, 3 novembre 1954) vista in Il volto del Novecento (leggi di più >>>).
Diversamente da quanto avviene nel caso di Giapponismo e Chinoiserie, che sono stili (il primo l’abbiamo già conosciuto, ad esempio, in L’Aquilone di Carlo Fornara, visto in Anima Bianca - leggi di più >>> - esempio delle seconde può essere la pagoda cinese nei celeberrimi Kew gardens: i Giardini botanici Reali di Kew, a sud di Londra), i pittori orientalisti di metà Ottocento sono europei che dipingono ciascuno con il proprio stile ma sono accomunati dalla scelta di soggetti riferibili al “Vicino Oriente”.
VICINO O MEDIO ORIENTE?
È curioso osservare che quest’ultimo includeva gli stati affacciati sul mediterraneo Orientale, la Penisola Arabica e la Persia, genericamente individuati come Paesi del Levante. Gli stessi stati che oggi, nelle cronache quotidiane, sono individuati come appartenenti al Medio Oriente. Dunque si tratta di Vicino o di Medio Oriente? Come avviene anche in tanti altri campi, le cose cambiano sempre a seconda del punto di vista dal quale si guardano. In questo, il nostro attuale è purtroppo, ancora una volta, “succube” dell’egemonia culturale anglosassone, senza nemmeno porsi il dubbio di esserlo. Per gli Inglesi, infatti, “Vicino Oriente” era l’Europa di Sud Ovest e “Medio Oriente” l’Egitto e l’Asia di Sud Ovest. A creare a confusione è stato l’uso del vocabolo acriticamente introdotto dalla stampa quotidiana anche in Italia.
IL CLIMA DELL’EPOCA
Già dal XVI al XVIII secolo, in Europa occidentale pittura, musica ed arti applicate furono notevolmente influenzate dalle nuove relazioni, meno conflittuali, che si instaurarono con la Turchia rispetto ai secoli precedenti e che suscitarono un forte interesse per l’arte e la cultura dell’Impero ottomano.
Ad imitazione di esse divenne così di moda realizzare arredi, decorazioni, architetture, moda, abbigliamento, ma anche accessori e gioielli che furono dette Turqueries, o Turcherie.
Un ruolo importante nell’accompagnare questo fenomeno lo ebbero avvenimenti politici e fatti culturali, come la pubblicazione in Francia, nel 1702, della raccolta di novelle orientali: Le Mille e una notte.
 Fra i primi, determinante nell’avvio dell’Orientalismo fu senza dubbio la campagna militare di Napoleone in Egitto del 1798 (a lato in un dipinto di Gérôme), specialmente perché al suo seguito erano presenti scienziati e personalità di rilievo della cultura del tempo che diffusero l’eco al ritorno in patria.
Fra i primi, determinante nell’avvio dell’Orientalismo fu senza dubbio la campagna militare di Napoleone in Egitto del 1798 (a lato in un dipinto di Gérôme), specialmente perché al suo seguito erano presenti scienziati e personalità di rilievo della cultura del tempo che diffusero l’eco al ritorno in patria.
Di notevole interesse è il reportage Voyage dans la haute et basse Egypte, pubblicato nel 1802, di ritorno dall’impresa in terra d’Africa, ed illustrato con le sue incisioni dal diplomatico, incisore e scrittore Dominique Vivant de Denon (Givry, Chalon-sur-Saône, 1747 - Parigi 1825).
 Amico del pittore Jacques-Louis David (Parigi, 30 agosto 1748 - Regione di Bruxelles-Capitale, 29 dicembre 1825), compì missioni a Pietroburgo, in Svizzera, in Italia, aderì alla Rivoluzione e da Napoleone fu designato direttore generale dei musei: incarico che lo portò ad organizzare l’imponente raccolta di capolavori che lui chiamò Museo di Napoleone ed oggi conosciamo come il Louvre.
Amico del pittore Jacques-Louis David (Parigi, 30 agosto 1748 - Regione di Bruxelles-Capitale, 29 dicembre 1825), compì missioni a Pietroburgo, in Svizzera, in Italia, aderì alla Rivoluzione e da Napoleone fu designato direttore generale dei musei: incarico che lo portò ad organizzare l’imponente raccolta di capolavori che lui chiamò Museo di Napoleone ed oggi conosciamo come il Louvre.
LA GUERRA GRECO - TURCA
 Altro episodio politico di rilievo del tempo fu la guerra d’indipendenza Greco-Turca combattuta dal popolo greco per affrancarsi dall’Impero Ottomano. I primi scontri cominciarono nel 1821.
Altro episodio politico di rilievo del tempo fu la guerra d’indipendenza Greco-Turca combattuta dal popolo greco per affrancarsi dall’Impero Ottomano. I primi scontri cominciarono nel 1821.
Ad aprire le ostilità fu la secessione dell’Epiro guidata da Alì Pascià di Tepeleni, un regno semi indipendente collocato fra le odierne Grecia e Albania. Approfittando della distrazione dell’esercito ottomano su quel fronte, Germanos (Dimitsana, 25 marzo 1776 – Nauplio, 30 maggio 1826), metropolita di Patrasso, principale porto nel nord del Peloponneso, fomentò l’insurrezione che divampò generalizzata in tutta la Grecia continentale, grazie all’aperta ribellione di Theodoros Kolokotronis a capo dei Kleftes.
I KLEFTES
Il vocabolo corrisponde letteralmente a “ladri” (Kleftes=banditi, dal greco κλέβω, rubare), ma per il popolo questa parola assunse il significato di “partigiani”.
Questi erano transfughi greci rifugiatisi nelle regioni più impervie della penisola nel XV secolo, quando la Grecia venne strappata dagli ottomani ai bizantini dopo il 1453, quando Costantinopoli fu conquistata dagli Ottomani di Maometto II che la ribattezzò con l’attuale denominazione di Istanbul.
L’episodio è stato dipinto da Fausto Zonaro, che ritroveremo in mostra, in Maometto II entra a Costantinopoli, del 1903, nel quale Zonaro si ritrasse a fianco al sultano nelle vesti di un giannizzero, sulla destra del cavallo.
Poiché con l’avvio della “Turcocrazia” la popolazione maschile abile alla guerra presente sul territorio greco era costretta a servire il sultano ottomano (molti giovani greci vennero reclutati tra le fila dei giannizzeri: i suoi soldati-schiavi), per conservare la propria indipendenza i Kleftes intrapresero la via del banditismo mantenendo sempre sotto pressione gli occupanti con forme di guerriglia ed assalti agli insediamenti isolati.Per contrastare il fenomeno e rafforzare l’autorità del Sultano nelle regioni della Grecia più difficili da controllare, l’Impero Ottomano istituì una milizia irregolare costituita da rumeni cristiani: gli armatoliki, ovvero “uomini d’arme”. Di fatto anche questi erano bande di fuorilegge, che però vennero riconosciute purché appoggiassero il governo centrale nel riscuotere i tributi nei distretti amministrativi di competenza in cui si trovavano ad operare e che da loro presero il nome di armatolìkia.
Il primo di essi fu costituito proprio negli Agrafa, inaccessibili monti della Tessaglia per combattervi i Kleftes. Con i quali tuttavia finirono per fare fronte comune appoggiandone la rivolta contro i Turchi.
La repressione però non tardò ad arrivare. Per rappresaglia fu subito massacrata la popolazione cristiana di Costantinopoli, incluso il Patriarca ecumenico Gregorio V.
 Nel 1822 gli Ottomani ripresero rapidamente il controllo dell’Epiro e tentarono di ristabilire il loro dominio con il terrore. I fatti più sanguinosi ebbero luogo nell’isola di Chio, di fronte a Smirne, sulla costa turca, dove nell’aprile 1822 la popolazione venne pressoché interamente sterminata pur non essendo stata responsabile della ribellione, limitata e portatavi da patrioti venuti da fuori.
Nel 1822 gli Ottomani ripresero rapidamente il controllo dell’Epiro e tentarono di ristabilire il loro dominio con il terrore. I fatti più sanguinosi ebbero luogo nell’isola di Chio, di fronte a Smirne, sulla costa turca, dove nell’aprile 1822 la popolazione venne pressoché interamente sterminata pur non essendo stata responsabile della ribellione, limitata e portatavi da patrioti venuti da fuori.
L’episodio è raffigurato in un celebre dipinto, Il massacro di Scio, del 1824, di Delacroix (Ferdinand Victor Eugène Delacroix, Charenton-Saint-Maurice, 26 aprile 1798 – Parigi, 13 agosto 1863), il principale esponente del Romanticismo francese, a dimostrazione della risonanza che questi fatti suscitarono negli ambienti liberali di tutta Europa.
Da qui, per unirsi ai rivoluzionari, partirono molti illustri intellettuali che nell’impresa lasciarono la vita, come si comprende facilmente osservando i luoghi e le date in cui la persero: corrispondenti alle più cruente battaglie. Fra questi il poeta inglese George Gordon Byron (Dover, Regno Unito, 22 gennaio 1788, - 19 aprile 1824, Missolungi) ed i due più noti italiani: il conte di Pomerolo e signore di Santarosa (Santorre Annibale Derossi, Savigliano, Cuneo, 1783 - 8 maggio 1825, Sfacteria - Navarino) patriota piemontese esule in Inghilterra e Giuseppe Maria Rosaroll-Scorza (Napoli, 16 settembre 1775 – Nauplia, 2 dicembre 1825), già generale dell’esercito delle Due Sicilie.
 Alla controffensiva ottomana tuttavia resistettero a lungo alcune importanti piazzeforti degli insorti: nel Peloponneso e soprattutto a Missolungi, conquistata nel 1822, da Markos Botsaris.
Alla controffensiva ottomana tuttavia resistettero a lungo alcune importanti piazzeforti degli insorti: nel Peloponneso e soprattutto a Missolungi, conquistata nel 1822, da Markos Botsaris.
Ubicata di fronte all’isola di Itaca, sulla sponda settentrionale del Golfo di Patrasso, la città occupava una posizione strategica: sia come porta di accesso al Golfo di Corinto sia per dominare il Peloponneso e la Grecia settentrionale.
La situazione si sbloccò soltanto quando a supporto dell’esercito ottomano arrivarono i rinforzi richiesti al Vicerè d’Egitto. Di origini albanesi e nato nell’odierna Macedonia Greca, Mehmet Ali pascià, che era un vassallo della Sublime Porta, inviando il proprio figlio Ibrahim Pascià alla testa delle sue truppe, fu determinante nella riconquista, nel 1825, di Navarino, porto sulla costa sud occidentale del Peloponneso, e poi anche di Atene.
Anche Missolungi, l’irriducibile roccaforte degli indipendentisti che aveva resistito con successo a ben tre assedi, capitolò nel 1827 fra lo sgomento degli europei Filelleni che rimproveravano l’inerzia dei propri Stati per non aver sostenuto gli eroici difensori della città nella loro sfida per la libertà.
Anche questo fatto d’armi è stato dipinto da Delacroix in “tempo reale” in La Grèce sur les ruines de Missolonghi.
Intanto, nel 1825, Nicola I sale al trono di Russia e rinnova l’impegno per l’indipendenza greca, col “disinteressato” obiettivo di ottenere uno sbocco nel Mediterraneo, indebolire ulteriormente gli osmanici e controllare meglio i Balcani. Cosicché i rivoluzionari possono condurre offensive nel nord con Georgios Karaiskakis, che riconquista Atene nel settembre 1827, e sul mare con i due navarchi, comandanti della flotta militare, Andreas Miaoulis e Georgios Sachtouris.
Tutto ciò porta anche Francia ed Inghilterra ad interessarsi del conflitto e ad inviare, unitamente alla Russia, una flotta che avrebbe dovuto avere il solo scopo di frapporsi alle parti in causa per impedire a quella Turca ulteriori eccidi. Le due squadre navali si incontrano il 20 ottobre 1827 nella rada di Navarino dove è ricoverata la flotta turca.
 Le istruzioni agli Ammiragli (che oggi diremmo “regole d’ingaggio”) non prevedevano azioni offensive contro gli ottomani e gli egiziani, ma in risposta a colpi di moschetto partiti da una lancia turca contro una lancia britannica, l’ammiraglio inglese Sir Edward Codrington (Dodington, 27 aprile 1770 – Londra, 28 aprile 1851) ordinò di aprire il fuoco e lo scontro divenne una battaglia generalizzata.
Le istruzioni agli Ammiragli (che oggi diremmo “regole d’ingaggio”) non prevedevano azioni offensive contro gli ottomani e gli egiziani, ma in risposta a colpi di moschetto partiti da una lancia turca contro una lancia britannica, l’ammiraglio inglese Sir Edward Codrington (Dodington, 27 aprile 1770 – Londra, 28 aprile 1851) ordinò di aprire il fuoco e lo scontro divenne una battaglia generalizzata.
Dopo tre ore di combattimento, tutte le navi egiziane e turche all’ancora nel porto furono affondate e, con esse, pressoché annientato il potenziale della flotta ottomana. La battaglia fu l’ultimo scontro navale della storia in cui le imbarcazioni coinvolte erano tutte a vela.
Sopra, La battaglia navale di Navarino. Dipinto del 1827 del pittore corsaroi Ambroise Louis Garneray.
Sempre grazie alla flotta britannica alla fine dell’anno verrà riconquistata anche Missolungi mentre nel 1828 i Francesi occupano la Morea.
LA MOREA
Il Despotato di Morea o Despotato di Mistrà fu una provincia dell’Impero Bizantino che esistette come tale dal 1308 al 1453, e come stato autonomo dal 1453 al 1460: ultima regione dell’Impero Bizantino ad essere conquistata dall’Impero Ottomano. Il suo territorio variò in dimensioni durante i suoi centocinquant’anni di vita ma rimase per lo più circoscritto alla penisola del Peloponneso, all’epoca chiamata Morea. Questa provincia fu governata dagli eredi dell’imperatore bizantino, la cui ultima dinastia fu quella dei Paleologi, ai quali venne dato il titolo di despoti. La sua capitale era la città fortificata di Mistra, distante cinque chilometri dall’antica Sparta, che divenne il più importante centro di cultura bizantino ed il secondo luogo di potere più importante dell’Impero bizantino.
La fine della guerra e l’autonomia della Grecia saranno sancite, sotto il protettorato di Francia, Gran Bretagna e Russia, con il trattato di Adrianopoli del 1829, poi trasformato in indipendenza con il protocollo di Londra nel 1830.
La Grecia mancava ancora di alcune regioni rimaste in mano ottomana, come Creta, la Tessaglia, la Macedonia, l’Epiro e la Tracia, mentre le regioni dell’Asia Minore e del Ponto con numerose popolazioni greche avranno un destino diverso.
I FRANCESI IN ALGERIA
Un altro fatto d’armi che contribuì ad avvicinare la cultura delle nazioni d’Occidente alle terre d’Oriente, allo stesso tempo costringendo il potere Ottomano ad arretrare il suo ambito d’influenza, fu l’occupazione francese di Algeri del 1830. Le cosiddette Reggenze di Algeri (conquistata nel 1529 da Hayreddin Barbarossa), Tripoli e Tunisi, identificate collettivamente come Stati Barbareschi, pur formalmente vassalle dell’Impero Ottomano, dal XVII secolo si erano viste riconoscere un grado di autonomia che le configurava quasi come stati autonomi. Questo fatto presupponeva però anche un’autonomia economica che sostenevano con la pratica della pirateria, e la conseguente richiesta di riscatti, nei confronti delle marine mercantili d’Europa e poi anche della giovane democrazia degli Stati Uniti (indipendenti dal 4 luglio 1776).
Attività che fu repressa una prima volta dagli USA, con la Prima Guerra Barbaresca del 1804, vinta grazie alla maggiore disponibilità economica, che ne garantiva la supremazia navale in numero di scafi, qualità ed armamento.
Ma l’impegno di europei ed americani nella guerra Anglo-Americana oltre l’Atlantico nel 1812, e nelle Guerre Napoleoniche in Europa, fino al 1815 consentirono agli stati nordafricani, ed in particolare all’Algeria, di godere di nuova libertà: esercitata sia per commerci redditizi, sia per le attività meno legittime.
A porvi fine fu la Seconda Guerra Barbaresca: conclusasi nell’agosto del 1816 con un bombardamento navale punitivo di 9 ore su Algeri, il cui Bey, che aveva ripudiato il trattato appena sottoscritto con gli Stati Uniti, dovette rinunciare a fare schiavi i Cristiani ed ai tributi.
Derivato dal turco antico beg, ossia “signore”, che originò l’arabo بك / bek; e l’ottomano بگ / beg, il vocabolo Bey indica un titolo turco-ottomano, anticamente attribuito ai leader di piccoli-medi gruppi di tribù, che col tempo termine passò ad indicare anche il responsabile fiscale o militare di una circoscrizione amministrativa dell’Impero Turco.
Nel frattempo, mentre il Mediterraneo era completamente controllato dalla British Royal Navy e dalla ricostruita Marina francese, a ridurre il commercio ed i margini di guadagno degi Algerini contribuì anche la Restaurazione francese.
Per di più, la sua impopolarità rese la Francia instabile perciò, allo scopo di distrarre l’opinione pubblica dai problemi interni, il re Carlo X di Borbone decise di intraprendere una politica coloniale.
Ad offrirgli il pretesto per un intervento militare fu il governatore ottomano dell’Algeria, Hussein Dey, che, nel 1827, non ricevendo dal console francese la risposta attesa alla richiesta di saldare un debito risalente al 1799 per rifornimenti alle truppe di Napoleone impegnate nella spedizione in Egitto, adirato lo toccò col suo ventaglio.
Con la scusa di questo incidente diplomatico, conosciuto come “il caso del ventaglio” il Regno di Francia avviò un blocco navale del porto di Algeri che si protrasse per tre anni, danneggiando però più i mercanti francesi che i pirati barbareschi che lo eludevano regolarmente (come succede anche al giorno d'oggi!).
Cosicché arrivò a proposito l’episodio più grave del 1829, quando il Dey rispose dirigendo il fuoco dei suoi cannoni verso una delle navi del blocco sulla quale viaggiava un ambasciatore francese con una proposta di negoziati. Per punire l’“impudenza” del Dey ed impedire ai corsari barbareschi di continuare ad avere in Algeri un porto sicuro, Re Carlo X ordinò un’azione più energica consistente in una spedizione punitiva sulle coste di Algeri con un gran dispiegamento di forze. Una flotta di 103 navi da guerra e 464 navi per il trasporto di quasi 40.000 armati partì da Tolone il 16 maggio 1830 arrivando al completo davanti ad Algeri solo il 14 giugno.
Il 5 luglio, precedute da un bombardamento navale, le truppe francesi entrarono in città dove ebbero facilmente ragione dei suoi difensori conquistando anche la Casbah il 7.
Mentre il Dey venne esiliato a Napoli ed alcuni giannizzeri riconsegnati all’Impero ottomano, il comandante francese, Louis Auguste Victor de Ghaisne, conte di Bourmont, colpì Blida e occupò Bona e Orano ai primi di agosto ed avviò i preparativi per insediare un Consiglio Comunale ed un Comitato governativo per amministrare la città.
Intanto, però, a Parigi c’era stata la Rivoluzione di Luglio, nota anche come Seconda rivoluzione francese o, in francese, Trois Glorieuses, con riferimento ai tre giorni, 27, 28, e 29 luglio, durante i quali si era svolta.
Reagendo ad un tentativo di colpo di mano anti-costituzionale da parte di Carlo X, che aveva emanato le «ordinanze di Saint-Cloud» l’opposizione immediatamente diventò rivoluzione repubblicana. I Parigini scesero per strada in armi, eressero barricate ed affrontarono i soldati del Re in sanguinosi combattimenti che fecero un migliaio di vittime fra insorti e regolari. Per “limitare i danni” i deputati liberali, pur sempre in prevalenza monarchici, riuscirono a prendere il controllo della rivoluzione popolare ed a conservare la monarchia costituzionale, sebbene al prezzo di un cambiamento di dinastia.
Carlo X – ultimo sovrano dei Borbone – fu deposto e con la famiglia abbandonò Parigi lasciando il trono di Francia alla casa d’Orléans, che ne era il ramo cadetto. Gli succedette Luigi Filippo di Borbone-Orléans (Parigi, 6 ottobre 1773 – Claremont House, 26 agosto 1850), già duca d’Orléans e conosciuto durante la Rivoluzione come il cittadino Chartres oppure Égalité fils. Con il nome di Luigi Filippo I fu proclamato «re dei Francesi» e non più «re di Francia» e regnò fino al 1848.
La notizia della Rivoluzione di Luglio arrivò ad Algeri l’11 agosto, prima che vi venisse insediato il nuovo governo. A Bourmont fu chiesto di giurare fedeltà al nuovo Re. Poiché rifiutò il comando passò al generale Bertrand Clausel il 2 settembre, che avviò negoziati con i Bey di Titteri, Orano e Costantina per imporre un protettorato francese.
Nonostante i Francesi avessero sconfitto velocemente le truppe del governatore ottomano, la resistenza dei nativi alla colonizzazione fu intensa e diffusa. Per sradicare l’opposizione popolare fu necessaria una lunga campagna militare di “pacificazione” durata più di quarantacinque anni.
Con l’invasione finiva il dominio ottomano in Algeria, durato diversi secoli, e cominciava il tempo dell’Algeria come colonia francese.
Nel 1848 i territori conquistati attorno alla capitale vennero organizzati in tre dipartimenti, corrispondenti alla moderna Algeria e lo stesso avvenne nel 1881 per la Tunisia. Invece, nel 1835, Tripoli ritornò sotto il controllo dell’Impero Ottomano.
Solo nel 1911, approfittando del suo declino, l’Italia conquistò la Tripolitania e la Cirenaica facendone la propria colonia di Libia.
L'ORIENTE DI INGRES E DELACROIX
Mentre in Grecia e nel Nord Africa si combatteva, l’Oriente nella pittura di una delle principali personalità francesi era invece tutto vagheggiamento di romantiche dolcezze. Stiamo parlando dell’allievo di David, e dunque di un artista dalla decisa formazione classica, Jean-Auguste-Dominique Ingres (Montauban, 29 agosto 1780 - Parigi, 14 gennaio 1867). Ritenuto uno fra i più rilevanti esponenti della pittura neoclassica, viene preso a modello nelle Accademie per rinnovare il ritratto femminile.
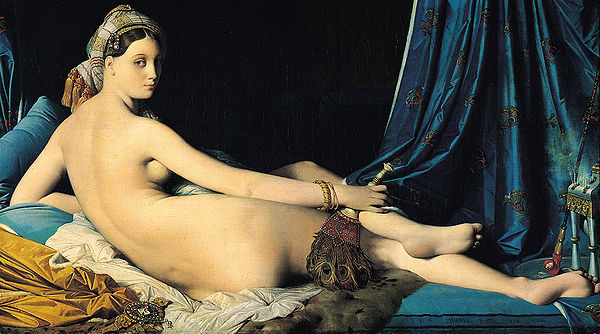 Per restare al nostro tema dell’Orientalismo, il suo contributo in questo senso consiste anche nell’utilizzare il mondo orientale di cui si favoleggiava come contesto nel quale ambientare, dando loro nuova vitalità, pose, rapporti di forme e soggetti tipici dell’arte classica e della pittura, sua e dei maestri che nel corso dei secoli l’hanno preceduto.
Per restare al nostro tema dell’Orientalismo, il suo contributo in questo senso consiste anche nell’utilizzare il mondo orientale di cui si favoleggiava come contesto nel quale ambientare, dando loro nuova vitalità, pose, rapporti di forme e soggetti tipici dell’arte classica e della pittura, sua e dei maestri che nel corso dei secoli l’hanno preceduto.
Ne è chiaro esempio la Grande odalisca, del 1814, nella quale sono numerose le esplicite citazioni di capolavori della storia dell’arte che lasciamo ai lettori il divertimento di indovinare.
Con questo dipinto Ingres si avvicina per la prima volta al Romanticismo inserendo venature romantiche e tocchi di esotismo nella sua pittura neoclassica.
Dà così vita ad un mondo che ha poca attinenza con la realtà di questa figura di donna ma che, evidentemente, riscuotono il favore del pubblico con i loro corpi nei quali rivive la Venere del mito classico, beninteso sottoposta ad uno studio rigoroso nella ricerca di purezza formale.
 Non manca quindi di riproporle in altri quadri, fra i quali ci limitiamo qui a citare l’Odalisca con schiava, del 1839, come si è detto una sorta di contraddizione in termini, se consideriamo il significato più appropriato del vocabolo, sul quale ci soffermeremo nella relativa sezione della mostra, e Bagno turco, del 1862.
Non manca quindi di riproporle in altri quadri, fra i quali ci limitiamo qui a citare l’Odalisca con schiava, del 1839, come si è detto una sorta di contraddizione in termini, se consideriamo il significato più appropriato del vocabolo, sul quale ci soffermeremo nella relativa sezione della mostra, e Bagno turco, del 1862.
Quest’ultima opera risulta sia stata suggerita al pittore delle impressioni che suscitò in lui la lettura di una lettera di Lady Montagu.
Aristocratica scrittrice e poetessa inglese, Lady Mary Wortley Montagu (26 maggio 1689 – 21 agosto 1762) è principalmente ricordata per le sue lettere, specialmente quelle scritte dalla Turchia. Visse infatti ad Istambul al seguito del marito ambasciatore, dal 1716 al 1718, ed alle sue lettere di quel periodo è stata riconosciuta la qualità di essere “il primo vero esempio di lavoro laico svolto da una donna sull’Oriente Musulmano”.
L’autrice, ritratta nel dipinto in primo piano con una corona sul capo, scriveva: « Erano circa duecento bagnanti... i primi sofà furono coperti di cuscini e di ricchi tappeti e quelle donne vi si sistemarono. Erano tutte... nude. Dopo il pasto si finì col caffè e coi profumi... due schiave mi coprirono d’incenso i capelli, il fazzoletto, i vestiti. ».
Più aderente al vero è Donne di Algeri, eseguito da Eugène Delacroix nel 1834 facendo tesoro degli appunti presi nel corso del viaggio in Nord Africa che fece nel 1832, immediatamente dopo che, come si è visto, il Regno dei Francesi si era appropriato di quelle terre.
Esibito al Salon del 1834 il dipinto venne accolto con entusiasmo e, nonostante l’autore non si fosse prefisso di venderlo, non potè rifiutarlo al re Luigi Filippo I che lo acquistò per 2.400 franchi.
Poiché è nella natura umana essere curiosa di ciò che è proibito, anche in quest’opera lo sguardo dell’artista entra in un harem.
L'HAREM
L’etimologia della parola, un adattamento del turco harem ‹harèm›, la fa discendere dall’arabo ḥarīm, che propriamente significa «luogo inviolabile». Presso i musulmani quindi, in analogia con il gineceo dell’antica Grecia, individua la parte della casa o dell’appartamento riservati alle donne e ai bambini e nella quale non è consentito l’accesso agli estranei. In relazione alla pratica della poligamia è anche il termine collettivo che individua l’insieme delle donne che vi abitano.
In questo dipinto, nella cui resa cromatica c’è chi ha visto una sperimentazione che anticipa l’Impressionismo, troviamo tutta una serie di elementi che ne fanno un modello di riferimento per i soggetti analoghi che vedremo in mostra e perciò si è qui ritenuto utile pubblicarlo.
Notiamo innanzitutto le tre donne a colloquio fra loro e la serva di colore che da queste è separata con l’espediente di ritrarla mentre si sta allontanando, l’esibizione di tecnica e fantasia nell’ideare e dipingere i variopinti arabeschi che rendono attraenti sia gli abiti all’orientale delle donne, sia i tessuti i cuscini ed i tappeti che Delacroix accuratamente distribuisce nella stanza, arredi - come specchi ed armadietti decorati – integrati nello sfondo di tappezzerie e pareti a piastrelle in ceramica ed, in primo piano, babbucce apparentemente “abbandonate” in studiato “disordine”.
Infine, a dimostrazione che il fumo era una pratica che accomunava uomini e donne, l’immancabile narghilè.
IL NARGHILÈ
Questo strumento è una sorta di “pipa ad acqua” che ha nella sua parte superiore un braciere dove si mettono i carboni ardenti.
Aspirando dal narghilè il fumatore risucchia dall’esterno l’aria ed alimenta i carboni che bruciano le foglie di tabacco impregnate di melassa che stanno subito sotto di essi, separate solo da una lamina di metallo a forellini.
Il fumo che si produce scende lungo una spirale interna al corpo principale dell’oggetto: un contenitore d’acqua, spesso profumata, grazie alla quale il fumo si raffredda prima di attraversare un lungo tubicino, generalmente flessibile, ed arrivare così alla bocca del fumatore più fresco e depurato rispetto al fumo di pipa.
IL MAROCCO FRA SPAGNA E FRANCIA
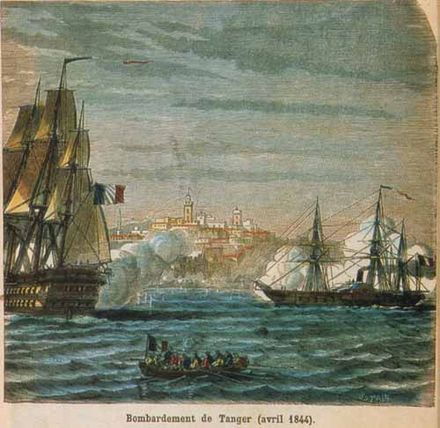 Riprendendo il filo delle vicende storico-politiche che interessano le sponde africana ed asiatica del Mediterraneo, nella seconda metà dell’Ottocento è il Marocco a diventare oggetto della disputa fra le contrapposte ambizioni coloniali degli stati europei.
Riprendendo il filo delle vicende storico-politiche che interessano le sponde africana ed asiatica del Mediterraneo, nella seconda metà dell’Ottocento è il Marocco a diventare oggetto della disputa fra le contrapposte ambizioni coloniali degli stati europei.
Intenzionata ad inseguirvi i resistenti all’occupazione in Algeria che vi si rifugiano, con il bombardamento di Tangeri, ad ovest dello Stretto di Gibilterra, del 6 agosto 1844 la Francia dà l’avvio alla guerra Franco-Marocchina che prosegue bombardando l’isola di Mogador ed occupando, il 16 agosto, il porto di Essaouira, il principale sulla costa Atlantica, che la fronteggia.
La vittoria del Maresciallo Thomas Robert Bugeaud sul fronte orientale a d’Isly il giorno dopo (che gli valse il corrispondente titolo di conte) pone fine al conflitto ed assicura alla Francia il predominio sulla parte del paese formalmente sotto la sovranità del sultano del Marocco, mentre le altre zone restano dominate dalle tribù berbere.
Da parte sua, nel 1859-60 la Spagna conduce la guerra Ispano-Marocchina, per effetto della quale consolida il controllo dei sui porti dopo le battaglie di Gueldras e di Tetuán, piazza che tuttavia cederà alla Gran Bretagna nel 1862.
L’anno dopo, la convergenza di interessi fra Inghilterra e Francia assegna infine a questa il Marocco: come disposto dalla convenzione di Tangeri in opposizione agli interessi della Germania che sosteneva il sultano.
Si era così determinata una situazione di irrisolta aperta conflittualità che restò tale, a maggior ragione, dopo la Guerra Franco-Prussiana del 1870 – 71, disastrosa per i Francesi, e dopo che la conferenza di Madrid del 1880 negò i diritti della Francia sul Marocco.
Fra il 1900 e il 1903, una ribellione contro il Sultano del Marocco Mulay Abdelaziz IV a fine 1902 offrì l’occasione di risolvere stabilmente la questione degli interessi inglesi e francesi nel Paese.
Ne fu premessa la cosiddetta “Entente cordiale” (“Intesa amichevole”): un accordo sottoscritto a Londra l’8 aprile 1904 in cui Francia e Gran Bretagna riconoscevano reciprocamente le rispettive sfere d’influenza coloniale.
Più che altro il trattato sancì l’influenza francese sul Marocco (spartito con la Spagna, alla quale veniva riservata la parte settentrionale) e quella inglese sull’Egitto ponendo fine a secoli di contrasti e conflitti tra le due nazioni ora intenzionate a fronteggiare di comune accordo il riarmo navale della Germania.
La risposta tedesca fu lo sbarco a Tangeri di Guglielmo II nel 1905, al culmine di una crisi che stava per degenerare in una guerra di ben più vaste proporzioni.
Nel 1906 la conferenza di Algeciras pose il Marocco sotto il controllo internazionale ma non risolse il problema della spartizione.
Dopo l’occupazione francese di Udida e di Casablanca e l’incidente di Agadir, con la cannoniera tedesca Panther che entrò minacciosamente nel suo porto il 1º luglio 1911, il 4 novembre 1911 si giunse alla pace promossa da Joseph-Marie Auguste Caillaux (Primo Ministro della Francia dal 27 giugno 1911 al 14 gennaio 1912) che evitò la guerra con la Germania cedendole territori del Congo francese (nell’attuale Camerun).
Quanto al Marocco, le sue regioni settentrionale e meridionale andavano alla Spagna mentra la zona centrale fu affidata alla Francia.
Il 30 marzo 1912, con il trattato di Fez, il Marocco accettava definitivamente il protettorato francese.
SI APRE IL CANALE DI SUEZ
Altro fatto di rilievo avvenuto in nord Africa nella seconda metà dell’Ottocento fu l’apertura del canale di Suez.
Lungo 191 km, questo canale artificiale, che taglia l’omonimo istmo in territorio egiziano, collegando Port Tawkif nel Golfo di Suez del Mar Rosso con Porto Said sul Mediterraneo, venne ipotizzato fin dal XVI secolo dai Veneziani. Nei secoli successivi se ne parlò soprattutto in Francia avviandone la concreta attuazione con Napoleone. Il fallimento della sua spedizione in Egitto fermò il progetto che fu poi ripreso dai sansimonisti (appartenenti al movimento socialista francese della prima metà del XIX secolo che prese il nome dal suo ideatore il conte Henri de Saint-Simon) fino ad ottenere l’assenso del governatore egiziano Muḥammad ̔Ali: a patto che il canale rimanesse all’Egitto e fosse aperto a tutte le nazioni.
Realizzato dal francese Ferdinand-Marie, visconte de Lesseps (1805-94) su progetto dell’italiano Luigi Negrelli (1799-1858), fu attraversato dalla prima nave il 17 febbraio 1867.
L’inaugurazione ufficiale avvenne invece il 17 novembre 1869 alla presenza dell’imperatrice Eugenia.
María Eugenia Ignacia Augustina de Palafox y Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick (Granada, 5 maggio 1826 – Madrid, 11 luglio 1920), diciannovesima contessa di Teba e decima contessa di Montijo e nota come Eugenia de Montijo, fu l’ultima sovrana di Francia ed imperatrice consorte dei Francesi dal 1853 al 1870 in virtù del suo matrimonio con Napoleone III).
La cerimonia fu sfarzosa e per essa Johann Strauss II compose la Egyptischer-Marsch (Marcia egizia).
In realtà per l’occasione il kedivè, o re d’Egitto,
A questo significato del titolo si arrivò per successivi passaggi dall’originario viceré d’Egitto, poi sultano; linguisticamente è la forma parzialmente italianizzata del francese khédive derivato dal turco khedīw a sua volta discendente dal persiano khadīw o khiduw che vuol dire ‘signore’.
Isma'il Pascià aveva chiesto a Giuseppe Verdi di comporre un inno. Non disponibile a scrivere musica d’occasione, il musicista aveva rifiutato ma i contatti proseguirono e, sebbene con successivi rinvii e ritardi per le sopra citate vicende belliche di quegli anni, arrivarono a buon fine con l’Aida: andata in scena con successo in prima assoluta il 24 dicembre 1871 al Teatro khediviale dell’Opera del Cairo diretta da Giovanni Bottesini.
Conosciuto anche come Teatro reale dell’Opera, e primo teatro operistico della capitale d’Egitto, fu commissionato proprio per celebrare l’apertura del Canale di Suez. Progettato dall’architetto italiano Pietro Avoscani era dotato di circa 850 posti a sedere e fu inaugurato il 1º novembre 1869 con un’altra opera di Giuseppe Verdi: Rigoletto. Realizzato prevalentemente in legno fu totalmente distrutto da un devastante incendio il 28 ottobre 1971.
Nel 1882, durante la rivolta di Aḥmad ‛Urabi pasha il canale fu difeso dalle truppe britanniche. Era infatti principalmente utilizzato da mercantili del Regno Unito, che da allora ne detenne il controllo di fatto, nonostante il khedivato fosse, formalmente, uno stato vassallo dell’Impero Ottomano, ormai in irreversibile declino ed incapace di mantenere un effettivo controllo dei suoi territori.
DECLINO E FINE DELL'IMPERO OTTOMANO
Questa situazione portò, nell’estate del 1908, alla rivolta dei Giovani Turchi: un movimento di intellettuali e ufficiali che volevano trasformare l’Impero Ottomano, economicamente molto arretrato, in una moderna monarchia costituzionale e che marciarono col proprio esercito contro Istanbul, costringendo il sultano a concedere la costituzione.
Nello stesso periodo la sovranità ottomana sui territori balcanici si disfaceva: la Bulgaria dichiarava la propria indipendenza e si annetteva la Rumelia orientale (meglio conosciuta come Tracia settentrionale), una serie di rivolte a Creta portarono alla sua annessione alla Grecia, ed infine la Bosnia ed Erzegovina le fu sottratta dall’Impero austro-ungarico.
Per fronteggiare la crisi che lo vedeva delegittimato, il sultano Abdul Hamid II tentò di giocare la carta di una controrivoluzione, ma i Giovani Turchi ebbero il sopravvento nell’aprile 1909: il sultano fu deposto e sostituito dal fratello, Maometto V (1909-1918).
Il nuovo regime ebbe qualche successo nell’opera di modernizzare lo Stato ma fallì nei rapporti con le popolazioni europee ancora soggette all’Impero ma in stato di rivolta permanente. Nel tentativo di attuare un ordinamento amministrativo più centralistico di quello, autoritario ma inefficiente, del vecchio regime, i Giovani Turchi ottennero, al contrario, l’indesiderato effetto di accentuare le spinte indipendentiste e di accelerare la dissoluzione della maggior parte di quanto restava della presenza turca in Europa. Per di più i suoi dirigenti, in primo luogo Talat Pascià, durante la Prima guerra mondiale si macchiarono delle colpe del Genocidio armeno. Il 1923 è l’anno in cui l’Impero Ottomano cessa di esistere e gli subentra la Repubblica di Ataturk.
LA MOSTRA
Il complesso arabesco di intrecci storico-politici di cui abbiamo tentato di delineare gli snodi più importanti è il teatro nel quale recitano la loro parte di artisti i pittori italiani presenti in mostra. Alcuni lo fanno restando in patria, altri viaggiano lungo itinerari le cui tappe imprescindibili sono: Il Cairo, Gerusalemme, Teheran, Istambul, Tunisi. Di importanza rilevante è il fatto che la prima lingua parlata a Istambul è il francese e che i sultani commissionano opere ai pittori europei, francesi ma anche italiani, come vedremo.
I - ALBERTO PASINI, PITTORE VIAGGIATORE
Suddivisa in quattro sezioni, la mostra dedica la prima sala ad Alberto Pasini (Busseto, Parma, 3 settembre 1826 – Cavoretto, Torino, 15 dicembre 1899), pittore che, a riprova della legittimità dell’attributo di viaggiatore, era presente all’apertura del Canale di Suez.
Piemontese d’adozione, per aver esposto le sue opere in numerose rassegne nella capitale Sabauda ed esservisi trasferito a vivere dopo aver girovagato in Europa e Medio Oriente, Alberto Pasini, come si è visto, è concittadino di Giuseppe Verdi.
Dopo gli studi iniziati a 17 anni all’Accademia di Belle Arti di Parma nella sezione paesaggio dal direttore della medesima, l’incisore Paolo Toschi, viene indirizzato alla litografia cosicché tra i suoi primi lavori risulta una serie di trenta litografie sui castelli del ducato di Parma e Piacenza (1850-51). Si sposta poi al nord per prendere parte alla Prima Guerra d’Indipendenza come milite della colonna di Modena. Per breve tempo soggiorna a Torino, nel 1851 si trasferisce a Ginevra e poi a Parigi, dove Toschi l’aveva indirizzato allo studio di Henriquel Dupont, il quale, a sua volta, lo presenta al celebre acquarellista e incisore Eugène Cicéri.
Infine, nel 1854, arriva allo studio parigino di Théodore Chassériau (Provincia di Samaná, Repubblica Dominicana, 20 settembre 1819 - Parigi, 8 ottobre 1856) che ne valorizza la propensione per la pittura ad olio e lo inizia all’Orientalismo (a lato un suo dipinto: Harem).
Nel marzo dell’anno seguente, sostituisce il suo maestro, ammalato, come disegnatore aggregato ad una missione diplomatica del governo francese in Siria, Arabia ed Egitto e con la quale, fra il 1868 ed il 1873 arriva in Persia (Iran) e poi in Turchia.
Durante il viaggio realizza una sessantina di studi e molti disegni, che saranno la base delle opere del genere verista di stampo esotico e faranno la sua fortuna, prima in Francia e poi in Italia, come dimostrano le molte onorificenze che ricevette. A Parigi la Medaglia d’Onore per la pittura, lo Scià di Persia gli conferì il titolo di “Ufficiale del Leone e del Sole”, Napoleone III lo decorò della Legion d’Onore nel 1878, ed il Re d’Italia dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. In Turchia torna per un viaggio successivo fermandosi alla corte del sultano dove vive fino al 1899, anno della morte.
 L’abilità ed i trascorsi di incisore di Pasini si comprendono e stupiscono ancora noi, come lo facevano con i suoi contemporanei, nei suoi dipinti in mostra, che costituiscono un piccolo racconto di vita quotidiana nelle terre del Levante.
L’abilità ed i trascorsi di incisore di Pasini si comprendono e stupiscono ancora noi, come lo facevano con i suoi contemporanei, nei suoi dipinti in mostra, che costituiscono un piccolo racconto di vita quotidiana nelle terre del Levante.
È sempre una pittura in plein air e di esterni, in ambienti urbani o fuori città.
Anche se mai lo si vede, la presenza del Sultano è naturalmente un elemento pervasivo della società che ritrae. E Pasini ce la lascia intuire nel suo primo dipinto in esposizione, In attesa del sultano (1890-95).
Davanti al suo palazzo la Guardia a cavallo lo attende e Pasini ce la “fotografa” accuratamente restituendocela in tutti i suoi più minuti dettagli. Le armi: dalla sciabola sguainata del capo manipolo alle picche della truppa. Gli abiti: i fez di lana rossa, le larghe kefiah che ricadono sulle spalle o il turbante avvolto attorno al capo, e poi le fasce in vita e variopinte giubbe e mantelli. Vere e proprie miniature sono le gualdrappe e, soprattutto, i finimenti dei cavalli. Infine l’artista non manca nemmeno di ritrarre le severe espressioni dei visi incorniciati da folte barbe.
Con questa stessa strepitosa tecnica sono rese anche le decorazioni ottomane e le scritte in arabo, che non siamo in grado di dire se siano state fedelmente riprodotte sull’edificio. Viceversa, la pavimentazione in primo piano ci ricorda i segni, quasi da pittura astratta, degli sfondi sui quali Giovanni Boldini (Ferrara, 31 dicembre 1842 - Parigi, 11 luglio 1931) ambientava i suoi eleganti personaggi parigini.
 Si intrecciano con quello dell'incombente Sultano il tema delle carovane e quello del paesaggio aperto. In Berberi in marcia (1866) i carri-tenda del sultano percorrono una valle i cui contrafforti rocciosi fanno pensare ai rilievi iraniani. Cosa che rivela un errore nel titolo del dipinto: come abbiamo imparato nell’approfondita introduzione storica le tribù berbere sono infatti popolazioni nomadi del nord Africa.
Si intrecciano con quello dell'incombente Sultano il tema delle carovane e quello del paesaggio aperto. In Berberi in marcia (1866) i carri-tenda del sultano percorrono una valle i cui contrafforti rocciosi fanno pensare ai rilievi iraniani. Cosa che rivela un errore nel titolo del dipinto: come abbiamo imparato nell’approfondita introduzione storica le tribù berbere sono infatti popolazioni nomadi del nord Africa.
 Non si presta ad equivoci, invece, La scorta del sultano (1867), la cui tenda, a quanto si riesce a vedere, sembra essere direttamente montata su una coppia di dromedari. La precedono, la seguono e ne vigilano i lati i cavalieri della scorta, sempre dipinti con la tipica grafia lenticolare che Pasini adopera per raccontarci usi e costumi dei luoghi che è andato a vedere per noi e di cui ci riporta curatissimi particolari, come i fiocchi sulla punta delle picche dei cavalieri ed i rilucenti bagliori metallici delle briglie dei cavalli.
Non si presta ad equivoci, invece, La scorta del sultano (1867), la cui tenda, a quanto si riesce a vedere, sembra essere direttamente montata su una coppia di dromedari. La precedono, la seguono e ne vigilano i lati i cavalieri della scorta, sempre dipinti con la tipica grafia lenticolare che Pasini adopera per raccontarci usi e costumi dei luoghi che è andato a vedere per noi e di cui ci riporta curatissimi particolari, come i fiocchi sulla punta delle picche dei cavalieri ed i rilucenti bagliori metallici delle briglie dei cavalli.
È curioso il dettaglio di quelli in prima fila, che qui, come anche in altre opere, sono tutti dipinti con lo stesso atteggiamento: tutti infatti hanno alzata allo stesso modo la zampa anteriore sinistra, come se fossero cavalli addomesticati di un circo mentre svolgono un esercizio per divertire il pubblico.
 Il piacere di dipingere scene esotiche in un ambiente naturale aperto, di cui può restituirci tutti gli effetti della luce sulle sue diverse componenti, cielo, montagne e superfici d’acqua, lo troviamo in Falconieri (1889). L’antico gesto di lancio del falcone, pratica che risale al tempo dei Sumeri e dell’epopea dell’eroe semidio Gilgamesh (2.600 – 2.500 a.C.), qui è ambientato sulla riva di un lago dal quale, con lo sparo dei loro fucili, quattro cavalieri hanno appena fatto alzare uno stormo di uccelli: fra il verde della vegetazione igrofila puntualmente resa in primo piano e quello più tenue dei rilievi che gli fanno corona.
Il piacere di dipingere scene esotiche in un ambiente naturale aperto, di cui può restituirci tutti gli effetti della luce sulle sue diverse componenti, cielo, montagne e superfici d’acqua, lo troviamo in Falconieri (1889). L’antico gesto di lancio del falcone, pratica che risale al tempo dei Sumeri e dell’epopea dell’eroe semidio Gilgamesh (2.600 – 2.500 a.C.), qui è ambientato sulla riva di un lago dal quale, con lo sparo dei loro fucili, quattro cavalieri hanno appena fatto alzare uno stormo di uccelli: fra il verde della vegetazione igrofila puntualmente resa in primo piano e quello più tenue dei rilievi che gli fanno corona.
Il tutto sotto le sempre scenografiche nubi: cumulonembi sviluppati in verticale e dipinti con un gusto per la verosimiglianza che arriva a mostrarcene le differenze fra la parte grigia carica di pioggia verso terra (dove proiettano anche la loro ombra al suolo) e la parte superiore illuminata dal sole.
 In Acque dolci d’Europa (1869) tende che coprono piccole cucine mobili appoggiate su banchetti in legno, la vera origine dello street food (!), davanti alla quinta verde degli alberi sopra i quali svettano le cupole di moschee e minareti sullo sfondo, sono il teatro al centro del quale c’è chi intreccia ceste e chi ne offre la frutta che contengono ai passanti, fra i quali donne quasi completamente, ma non integralmente, velate, sotto lo sguardo attento delle guardie a cavallo.
In Acque dolci d’Europa (1869) tende che coprono piccole cucine mobili appoggiate su banchetti in legno, la vera origine dello street food (!), davanti alla quinta verde degli alberi sopra i quali svettano le cupole di moschee e minareti sullo sfondo, sono il teatro al centro del quale c’è chi intreccia ceste e chi ne offre la frutta che contengono ai passanti, fra i quali donne quasi completamente, ma non integralmente, velate, sotto lo sguardo attento delle guardie a cavallo.
 Siamo a Istambul, in un luogo molto preciso e particolare: la zona delle fontane pubbliche, dalle eleganti e monumentali architetture, sullo stretto del Bosforo che divide la città. Un luogo nel quale il venerdì pomeriggio, giorno sacro di festa per i musulmani, era uso (e forse lo è ancora oggi) passeggiare: d’estate sulla sponda asiatica e d’inverno su quella europea.
Siamo a Istambul, in un luogo molto preciso e particolare: la zona delle fontane pubbliche, dalle eleganti e monumentali architetture, sullo stretto del Bosforo che divide la città. Un luogo nel quale il venerdì pomeriggio, giorno sacro di festa per i musulmani, era uso (e forse lo è ancora oggi) passeggiare: d’estate sulla sponda asiatica e d’inverno su quella europea.
Un altro tema comune non solo in Pasini ma anche in altri artisti, come vediamo nella versione di questo luogo, più elegante e meno popolare, dipinta da Hermann Corrodi: artista che incontreremo di nuovo… in Egitto!
Un più libero filo conduttore che ci pare di trovare nei soggetti di Alberto Pasini, è il suo dipingere sempre gruppi di persone davanti a “qualcosa”. Specialmente in ambito urbano, nelle sagome degli edifici che inquadrano e dettano le proporzioni della composizione c’è sempre una porta che fa intuire un interno “altrove” dal quale ci si aspetta che dovrà arrivare qualcosa o qualcuno. Una porta che, caso raro, manca invece in Scena araba (1873), dove un folto gruppo di persone si raduna in una piazzetta racchiusa fra il muro di cinta di un giardino e la parete cieca di un grande edificio che lascia in noi l’impressione di uno schizzo architettonico.
 Proprio all’angolo fra i due, all’ombra (si fa per dire) di un albero dalla parte aerea mezza rinsecchita, attorno a venditori di ortaggi seduti a terra assieme alla loro merce, per lo più cocomeri che, naturalmente, rotolano per la via, si stringono donne e uomini. Fra le prime, sempre completamente velate, a guardarle con attenzione spuntano colorati ombrellini parasole, per noi qui del tutto inattesi; peraltro senza alcun buon motivo per il nostro stupore! Più spostato verso l’osservatore, un un venditore di cibo di strada propone la sua merce su un vassoio circolando fra i presenti, fra i quali cavalieri appartenenti a corpi militari diversi, caratterizzati da alto turbante e divisa elegante l’uno, e lunghi pastrani e pelosi colbacchi in testa gli altri, tutti scesi di sella a passeggiare sul grigio bruno della polvere che ricopre la strada.
Proprio all’angolo fra i due, all’ombra (si fa per dire) di un albero dalla parte aerea mezza rinsecchita, attorno a venditori di ortaggi seduti a terra assieme alla loro merce, per lo più cocomeri che, naturalmente, rotolano per la via, si stringono donne e uomini. Fra le prime, sempre completamente velate, a guardarle con attenzione spuntano colorati ombrellini parasole, per noi qui del tutto inattesi; peraltro senza alcun buon motivo per il nostro stupore! Più spostato verso l’osservatore, un un venditore di cibo di strada propone la sua merce su un vassoio circolando fra i presenti, fra i quali cavalieri appartenenti a corpi militari diversi, caratterizzati da alto turbante e divisa elegante l’uno, e lunghi pastrani e pelosi colbacchi in testa gli altri, tutti scesi di sella a passeggiare sul grigio bruno della polvere che ricopre la strada.
 Di un bianco calcinato sono invece i muri che vediamo in Davanti alla moschea (1875-80). Ma i bianchi di Pasini sono diversi da quelli degli Impressionisti, con i quali pure condivide la pittura en plein air. Perché a lui non interessa la luce ma il dettaglio nella restituzione del disegno. Un disegno che è sempre ben presente perché Pasini documenta ed il suo è l’interesse di un osservatore meticoloso, qui per gli smalti della vernice verde sopra il portale e per i costumi dei circassi caucasici.
Di un bianco calcinato sono invece i muri che vediamo in Davanti alla moschea (1875-80). Ma i bianchi di Pasini sono diversi da quelli degli Impressionisti, con i quali pure condivide la pittura en plein air. Perché a lui non interessa la luce ma il dettaglio nella restituzione del disegno. Un disegno che è sempre ben presente perché Pasini documenta ed il suo è l’interesse di un osservatore meticoloso, qui per gli smalti della vernice verde sopra il portale e per i costumi dei circassi caucasici.
Popolazione di fede musulmana, che detenne il potere sovrano in Egitto durante il sultanato mamelucco (XIII-XVI secolo), nel XIX secolo, per essersi rivoltati contro il potere dello Zar di Russia, furono espulsi dalle terre di origine e vennero accolti nelle varie regioni che ancora costituivano l’Impero Ottomano. Per le loro tradizionali abilità di combattenti arrivarono a costituire anche la guardia pretoriana del Sultano di Istanbul.
 Dove infine ha più argomenti per sbalordire l’osservatore è in Un Kan (1890-95). Il Kan era un dormitorio e luogo di ristoro, ed in questo che dipinge, Pasini si sbizzarrisce a restituircene con esattezza perfino le tende sdrucite dell’ingresso, le assi di legno di terrazzini e finestre aggettanti e gli intonaci scrostati.
Dove infine ha più argomenti per sbalordire l’osservatore è in Un Kan (1890-95). Il Kan era un dormitorio e luogo di ristoro, ed in questo che dipinge, Pasini si sbizzarrisce a restituircene con esattezza perfino le tende sdrucite dell’ingresso, le assi di legno di terrazzini e finestre aggettanti e gli intonaci scrostati.
Fra queste prevalenti architetture degli edifici che riempiono tutta la tela, seppure tutta concentrata in una fascia orizzontale, delimitata inferiormente dalla polvere della piazza, è la vita che prorompe, brulicante di figure e scene di commerci e conversazioni.
È un mercato in cui gruppi di persone trattano su tutto. Da sacchi pieni di non si sa bene cosa ad un cavallo di cui si distinguono tutti i sottilissimi tratti della coda e della criniera. E poi ancora venditori ambulanti di cocomeri, anche aperti per mostrarcene il rosso della polpa all’interno, e di gialli meloni.
Una sola donna è presente, seduta a terra accanto all’immancabile filo di fumo su cui vengono arrostite vivande mentre sulla destra un ballerino nero canta accompagnandosi con il suono di un tamburello a sonagli che agitando e percuote sollevando le braccia.
Sorprendente, al centro del cono visivo definito da tutto l’insieme, è dipinto con certosina precisione perfino un moschetto appeso a bandoliera sulle spalle di un soldato dalla giubba screziata di fucsia e dai calzoni di cui Pasini arriva a mostrarci perfino il dettaglio delle fasce militari abbottonate che li fermano sui polpacci. Naturalmente si tratta di calzoni alla zuava. Ed è il caso di ricordare che presero il nome da quello di un gruppo di tribù berbere della “Grande Cabilia”, la Cabilia occidentale, regione dell’Algeria con capoluogo Tizi Ouzou (in berbero Tizi Uzezzu che significa “Colle delle ginestre”). Queste tribù fornivano soldati alle milizie ottomane ed in arabo erano conosciute come Zwawa.
Guardando questi bellissimi dipinti non è difficile intuire che, anche al tempo in cui sono stati realizzati, l’effetto che facevano sui clienti era lo stesso che fanno su di noi oggi. Non bastasse questo, a commercializzarli era uno dei mercanti d’arte più adeguati a venderli bene, trattandosi di una delle figure principali del mercato collezionistico per tutto l’Ottocento e fino al primo ventennio del Novecento ed al quale devono il successo molti degli artisti attivi in quegli anni: gli Impressionisti primi fra tutti. Per chi non l’avesse già intuito, stiamo parlando proprio di Adolphe Goupil (Parigi, 11 marzo 1806 - Saint-Martin-aux-Chartrains, Calvados, 9 mai 1893), nome che già abbiamo più volte incontrato scrivendo di artisti appartenenti alle più diverse correnti espressive.
GOUPIL
La cosiddetta “Maison Goupil” fu fondata da Adolphe Goupil nel 1829, assieme al mercante di Dresda Henry Rittner (1802-1840) che sposa la sorella di sua moglie nel 1834. In principio l’attività trattava solo incisioni e litografie di capolavori dell’arte antica ed opere contemporanee selezionate al Salon di Parigi (una sintetica panoramica sui Salon è pubblicata in Vista dall'Africa: la mia Europa che dipinge leggi di più >>>).
L’iniziale ragione sociale, “Henry Rittner”, dal 1831 divenne “Rittner & Goupil” e poi “Goupil & Vibert” nel 1840, quando Rittner morì e Goupil si associò con Theodore Vibert (1816-1850). L’ingresso di un nuovo socio, Alfred Mainguet, nel 1846 comportò l’ulteriore modifica in “Goupil, Vibert & Cie”.È a partire da questo decennio che l’attività della Galleria diventa internazionale aprendo nuove sedi: a Londra nel 1841 e, soprattutto, a New York nel 1845. Diretta dal suo primogenito Leon (1830-1855) col determinante supporto di Vibert la galleria negli USA quadruplicò il fatturato in pochi anni (dai 140.000 franchi del 1848 ai 569.000 del 1854) ma dovette superare la difficoltà della morte di entrambi nel breve volgere di un lustro.
Un successo che si spiega anche con il fatto che la Maison comincia a vendere opere d’arte originali e ad adottare strategie per legare a sé gli artisti che le cedono i diritti di riproduzione e vendita dei propri quadri, col reciproco vantaggio di guadagnare entrambi cifre molto più elevate rispetto alle forme di contrattazione preesistenti. Anche quando non detiene i diritti su un artista Goupil riesce comunque spesso a comprarne dei quadri che poi riproduce, con piena legittimità, suscitando le ire del concorrente. Intanto, siamo nel 1850, Adolphe Goupil viene nominato Chevalier de la Legion d’Honneur e cambia di nuovo la ragione sociale della società che, fino a quando ne resterà il titolare, sarà “Goupil & Cie”.
Ancora un decennio e, negli anni ‘60, la Galleria divenne un punto di riferimento per collezionisti e mercanti grazie all’apertura di altre nuove sedi a Berlino, Vienna (1865), Bruxelles (1866) ed oltre nel mondo.
Ancor prima, nel 1861, era sbarcata a L’Aja, in società con il mercante olandese Vincent Van Gogh, lo “zio Cent” del pittore, che a sua volta vi lavorò giovanissimo: a L’Aia dal 1869 al ’73, a Londra nel ’73-’75 e nel 1875-76 a Parigi, per poi licenziarsi definitivamente.
Il fratello Theo, invece, arriverà ad essere direttore della filiale di Montmartre nel 1882.Seppure così ramificata, l’azienda manteneva sempre uno stretto controllo sulle vendite internazionali dalla sede parigina. Da qui partivano dipinti, stampe e fotografie, queste ultime tutte forniture dei laboratori della capitale. I contratti in esclusiva, stipulati con pittori di diversa nazionalità e con differenti stili artistici ma riuniti sotto questo grande progetto unitario, favorirono la produzione e diffusione di soggetti che presto diventarono popolari ed apprezzati da collezionisti, critici e mercanti. Il suo fiuto puntava sia sulla frivolezza femminile sia sui sentimenti forti perciò scene di vita quotidiana e di genere, ambientate in eleganti interni o in ombrosi giardini, scene in costume, pompeiano o settecentesco, vedute urbane e paesaggi animati crearono ed alimentarono un gusto collezionistico di respiro europeo ed internazionale che lascerà il segno anche ben oltre il limite temporale della fine secolo.
Non secondario, in questo senso, fu il ruolo svolto dall’attività iniziale di Goupil che non era mai venuta meno: la riproduzione dei dipinti. Per offrire i capolavori dell’arte ad un pubblico il più ampio possibile con un prodotto di qualità ma che costasse poco. Un quadro famoso era perciò diffuso con diverse tecniche e formati: incisione, fotopittura dall’originale, fotografia, fotoincisione.
Oltre che intelligente imprenditore Goupil aveva anche notevoli capacità diplomatiche e di relazioni. Questo gli permise di avere relazioni di favore con la più importante istituzione espositiva del tempo e prestigiosa vetrina internazionale: il Salon. Qui vennero presentati innumerevoli artisti della sua “scuderia” ma anche per la vendita di altri indipendenti lo stesso Adolphe o la Maison lavorarono come intermediari.
Come se tutto questo già non bastasse, sua figlia Marie sposò nel 1863 il pittore Jean-Léon Gérôme (Vesoul, 11 maggio 1824 - Parigi, 10 gennaio 1904) a sua volta non estraneo ai temi dell’orientalismo, come dimostra il soggetto-scherzo qui a lato: Une plaisanterie del 1882. Sebbene artisticamente contrario al movimento impressionista di Monet e Manet, e continuando da parte sua a riconoscersi nel neoclassicismo francese, il suo ingresso in famiglia ebbe risvolti economicamente favorevoli per tutti. Se da un lato favorì le vendite dei suoi quadri e gli assicurò un successo internazionale grazie alla diffusione planetaria di fotografie e fotoincisioni delle sue opere, dall’altro permise a Goupil di conoscere direttamente moltissimi artisti ed entrare facilmente nei loro ateliers.
All’inizio degli anni ’70, il crescente successo indusse la Maison Goupil ad ingrandirsi affiancando all’originaria sede di Boulevard Montmartre a Parigi l’intero palazzo di rue Chaptal 9 ed altri spazi espositivi e di vendita di fronte all’Opéra. La possibilità per gli artisti di avere spazi prestigiosi dove potersi presentare al pubblico vede lavorare contemporaneamente per la Galleria esponenti di movimenti artistici anche completamente differenti tra loro: Barbizzoniers, Impressionisti, pittori di genere e Pompiers, come erano ironicamente definiti gli accademici alla Bouguereau, il più significativo rappresentante dell’Accademismo.
“Art pompier” era infatti definita, con intenti derisori, la pittura ufficiale e gradita al potere prodotta in Francia nella seconda metà del XIX secolo e che, sebbene eseguita con tecnica magistrale, poteva risultare priva di vera anima. Almeno così la pensavano i suoi detrattori, perché conosciamo personalmente chi, ancora ai nostri giorni, dichiara: “Non mi appassiona l’arte del periodo e non nutro particolare interesse per questi riottosi sperimentatori, a parte quel dio della pittura che fu Bouguereau”!
Incuriosisce, ma resta dubbia, l’origine dell’appellativo francese pompier, in italiano, pompiere. L’ipotesi più divertente la fa discendere dagli elmi di dèi ed eroi classici, simili a caschi di pompieri, onnipresenti nei soggetti di questi artisti. Potrebbe però anche essere riferita agli stessi pompieri incaricati di garantire la sicurezza durante le mostre nei Salons ufficiali, rinviare agli imitatori della pittura pompeiana affiliati al circolo di Charles Gleyre (Chevilly, Svizzera, 2 maggio 1806 - Parigi, 5 maggio 1874) o, infine, indirizzarsi a rappresentazioni pittoriche pompose e retoriche.Fra tutti costoro naturalmente non mancarono gli Italiani, presenti a Parigi in buon numero e rappresentanza tanto qualificata da aver suggerito qualche anno fa l’allestimento di un’intera mostra dedicata agli Italiani di Goupil: Boldini, De Nittis, Mancini… in totale circa un centinaio di artisti, fra i quali più d’uno degli Orientalisti di cui ci stiamo occupando.
Sempre proiettata verso nuovi traguardi, la Goupil inserì nel suo oggetto sociale dal 1872 anche l’attività di realizzazione e deposito brevetti per i vari procedimenti di riproduzione e, nel 1877, il suo fondatore venne insignito del titolo di Officier (secondo gradino delle onorificenze francesi) per aver “contribuito a diffondere in Francia e all’estero l’amore per l’arte e i valori morali della società francese” del Secondo Impero e della Terza Repubblica.
Soltanto nel 1884 Adolphe Goupil, dopo aver tenuto fede per tutta la vita al suo nome (che in francese antico significa volpe), lasciò ai soci la guida dell’azienda che tuttavia, a testimonianza del valore che il marchio aveva raggiunto, lo manterranno nella ragione sociale.
Fu così per l’attività principale, rilevata da Leon Boussod (1826-1896) e Renè Valadon (1848-1921) che vi innestarono nuovi processi di stampa tipografica e la pubblicazione di riviste illustrate aggiornandone la denominazione in “Boussod, Valadon &Cie, Successeurs de Goupil & Cie”. Con questa intestazione la Galleria chiuse definitivamente, nel 1919, dopo aver trattato più di 31.000 opere!
Proseguì invece per un altro biennio la vendita delle riproduzioni da parte della società parallela “Jean Boussod, Manzi, Joyant & Cie, Successeurs de Goupil & Cie”, fondata nel 1897 ed alla quale diede impulso Michel Manzi (1849-1915), che entrò in azienda nel 1884 portandovi innovazioni quali la foto-acquatinta ed un metodo di typogravure per produrre libri illustrati e riviste che gli valse nel 1886 una medaglia d’oro da parte della Società per l’incoraggiamento dell’industria nazionale.
BRONZI
A complemento tridimensionale delle vedute di Pasini la prima sala della mostra espone anche due bronzi.
Nel primo, di Ernesto Bazzaro (Milano, 29 maggio 1859 – Milano, 18 maggio 1937), artefice del monumento a Felice Cavallotti a Milano in via Senato, all’incrocio con via Marina, riconosciamo un’opera che ci era consueta: la Fuga in Egitto.
Almeno così si chiamava in famiglia (ma in buona compagnia anche oggi sulla “rete”) questa donna, in groppa ad un dromedario, che tiene in braccio un bambino: eredità del bisnonno dal buon gusto artistico e nella quale tutti vedevamo Maria nel tentativo di sottrarre il figlio all’ottusa violenza di Erode.
Per questa ottima ragione la scultura campeggiava sulla credenza della sala della zia Osvalda e, nel tempo di Natale, dalle zampe dinoccolate del cammello partiva l’allestimento del Presepio.
Secondo altri il suo titolo è, più genericamente, maternità beduina mentre in mostra scopriamo, invece, che è considerata una parte evocativa di un tutto ed è perciò catalogata In carovana.
Sia come sia, i volti della donna e dell’animale ci guardano quasi sorridenti (specialmente il secondo) da questa forma di metallo che le briglie ondeggianti ed il risvolto sollevato della coperta stesa sulla gobba ci fanno apparire davvero in movimento.
 Considerazione dalla quale crediamo di poter dedurre che in essa sia stato abbandonato il gusto ancora romantico dei primi lavori dell’artista, come nella scultura Sordello da Goito che, nel 1881, gli valse la vittoria nel concorso Luigi Canonica, e sia invece evidente l’influenza che ebbe su di lui il contatto, avvenuto proprio negli stessi anni, con la scapigliatura milanese.
Considerazione dalla quale crediamo di poter dedurre che in essa sia stato abbandonato il gusto ancora romantico dei primi lavori dell’artista, come nella scultura Sordello da Goito che, nel 1881, gli valse la vittoria nel concorso Luigi Canonica, e sia invece evidente l’influenza che ebbe su di lui il contatto, avvenuto proprio negli stessi anni, con la scapigliatura milanese.
In questa corrente artistica, nella quale si era mosso anche Medardo Rosso (leggi di più >>>), è con tutta evidenza immerso in pieno Attilio Prendoni (Milano 1874 – 1942), che di Bazzaro era stato allievo e collaboratore. La scompaginata dinamica del suo Cavaliere arabo che sguaina la spada non può che appartenere alla volontà di far deflagrare il colore di uno Scapigliato: capace di lavorare su una scultura con intento pittorico, come vediamo con ottimi risultati.
 Il terzo bronzo in mostra lo troviamo al centro della seconda, più grande, sala che la accoglie. Il suo autore è Gaetano Orsolini (Montegiorgio, Fermo, 7 marzo 1884 – Torino, 27 luglio 1954), scultore, incisore e medaglista che espone ad una Biennale di Venezia ed è ceramista delle manifatture Lenci di Torino.
Il terzo bronzo in mostra lo troviamo al centro della seconda, più grande, sala che la accoglie. Il suo autore è Gaetano Orsolini (Montegiorgio, Fermo, 7 marzo 1884 – Torino, 27 luglio 1954), scultore, incisore e medaglista che espone ad una Biennale di Venezia ed è ceramista delle manifatture Lenci di Torino.
La sua grande scultura, di proporzioni quasi naturali, La schiava, del 1826, è l’ideale riferimento per introdurre la seconda sezione della mostra: Odalische.
II – ODALISCHE, DONNE IN ABITI ORIENTALI
Giustamente il sottotitolo della sezione è “Donne in abiti orientali”. Opportuna precisazione perché, diversamente da quanto si è sopra visto nella loro visione di Ingres e si vedrà più avanti in altri artisti, le vere odalische erano sempre vestite.
Derivazione dal francese odalisque, a sua volta trasposizione dal turco oḍaliq, in grafia moderna odalik, il vocabolo contiene la radice oḍa, che significa «camera», e perciò individua una «cameriera o domestica».
L’odalisca dunque non era una concubina dell’harem, anche se poteva diventarlo. Cosa che si auguravano alcune famiglie georgiane e caucasiche spingendo le figlie ad entrare nei serragli con questo ruolo, dal quale avrebbero potuto ascendere a quello di concubine o mogli del sultano.
Le odalische, infatti, occupavano il gradino più basso della scala sociale dell’harem e di solito erano schiave donate al sultano per servire non lui ma le sue mogli e concubine: come domestiche personali addette al servizio di tavola e di camera.
Il fatto che oggi, per estensione, la parola evochi un senso di esotica e preziosa bellezza e faccia pensare ad una donna giovane e bella in abiti orientali, o più spesso senza e dall’aspetto provocante, dipende dall’uso improprio che di essa fecero gli scrittori europei applicandola alle schiave concubine dei sultani e dei pascià nell’Impero Ottomano.
Inesattezza risultante da una visione distorta che nell’Ottocento l’Occidente aveva nei confronti di culture diverse dalla propria, come quella islamica.
Visione che, invece, sembra corretta nelle prime due opere della sezione. Ne è autore Fabio Fabbi (Bologna, 18 luglio 1861 - Casalecchio di Reno, Bologna, 24 settembre 1945).
Dopo una formazione accademica a Bologna e Firenze in tutte le arti figurative, che gli valse diversi premi e lo indirizzò ad uno stile eclettico, nel 1886 parte per il primo di numerosi viaggi in Egitto ed altri paesi dei Mediterraneo ai quali si riferisce significativamente la sua produzione artistica. Cosa che fa di lui il rappresentante della corrente pittorica orientalista riconducibile in area emiliana ad Alberto Pasini.
La sua adesione al genere pittoresco fu costante ed associava un bozzettismo rapido e vivace ai temi dell’esotismo e del viaggio. Senza addentrarci in aspetti della sua biografia non direttamente riferibili all’argomento della mostra, ci limitiamo a ricordare che, a ridosso del Novecento, dipinse anche soggetti religiosi: come l’Annunciazione e Cristo deriso presentate accanto al Santone musulmano all’Esposizione dell’arte e dei fiori di Firenze del 1896.
Inoltre fu vignettista, autore di numerose cartoline ed illustrò più di cento volumi. Fra di essi segnaliamo i romanzi d’avventura di Emilio Salgari nei quali, grazie alla duttilità tecnica e cromatica dimostrate nell’uso della tempera e dell’acquerello, seppe profondere un’originale levità narrativa ed una particolare ed aggraziata atmosfera di sogno orientale.
A causa dei titoli approssimativi e dei soggetti ripetitivi, non è facile individuare la collocazione delle sue opere, principalmente appartenenti a collezioni private.
Fra le eccezioni che qui ci interessa citare è Moschea, alla Galleria comunale d’Arte Moderna di Bologna.
Per la documentazione fotografica la fonte più utile è il catalogo della mostra che nel 1981 gli dedicò la galleria bolognese Il 2 di Quadri, che ne possiede varie opere.
Altri soggetti orientali li espose nel 1888 al Circolo degli artisti di Firenze: Un terrazzo ad Alessandria, dal taglio fortemente fotografico, Donna araba, Il vasaio, Vecchio musulmano che furono lodati per la forza del colore e per la spiccata personalità che rivelavano.
Databili alla fine degli anni Ottanta sono anche la decorazione con sei grandi tempere di soggetto orientale del fumoir del villino Sorani a Firenze e L’Egitto: album di ricordi e disegni originali pubblicato da Alinari. Infine, all’Esposizione internazionale di Monaco del 1898 fu premiato anche per il dipinto La vendita di una schiava.
Informazione che ci riporta in mostra dove la sua Odalisca, del 1880, (sopra) che il mercante sveste all’aperto lungo una via per esibirne le qualità al possibile acquirente, sembra corrispondere, più che in altri dipinti, alla reale condizione di schiavitù sopra descritta per questa categoria di donne.
 E chissà se ha un significato particolare, oltre a quello dello stridente contrasto tra chi detiene il potere e chi non dispone nemmeno di sé stesso, il fatto che il compratore sia ricoperto quasi per intero da un mantello bianco, sotto il cui cappuccio fa anche bene a semicelare il volto, visto che la sua attività non gli fa affatto onore.
E chissà se ha un significato particolare, oltre a quello dello stridente contrasto tra chi detiene il potere e chi non dispone nemmeno di sé stesso, il fatto che il compratore sia ricoperto quasi per intero da un mantello bianco, sotto il cui cappuccio fa anche bene a semicelare il volto, visto che la sua attività non gli fa affatto onore.
Osservando poi l’architettura degli edifici alle spalle del gruppo di donne che l’attorniano, il pensiero ci corre alle rappresentazioni della Firenze medievale viste in tanti affreschi da Giotto in poi: chissà se il nostro pensiero ha corso troppo o se un nesso effettivamente c’è!
Un collegamento sicuro è, invece, quello con il dipinto di Fabio Fabbi che in mostra precede quello appena descritto: Harem, opera del 1912. Il teatro in cui la schiava veniva spogliata era infatti costituito da tessuti colorati appesi a pali per fare da fondale e dal tappeto che le evitava di stare a piedi nudi direttamente sulla strada. Per delimitarne ulteriormente lo spazio Fabbi colloca ai lati della donna due ceramiche: un vaso ed un’anfora a becco in stile Liberty appoggiati su due tavolinetti in stile moresco: che troviamo ad esempio nella decorazione delle pareti della saletta dantesca al Poldi Pezzoli o nell’Hotel Excelsior al Lido di Venezia.
Questo stesso modello lo ritroviamo, appunto, di identica fattura in Harem. Perfettamente riconoscibile in primo piano, nonostante sia seminascosto dai variopinti scialli di seta che lo ricoprono.
E visibile per intero anche dall’altro lato della piscina che separa i due gruppi di donne che ne godono il benefico effetto refrigerante trascorrendo il tempo in piacevoli conversazioni o intrecciando ghirlande di fiori: colorati come i ricchi e morbidi tessuti degli abiti e dei foulards che le rivestono ma anche dei cuscini e dei tappeti sui quali si distendono.
 Curioso e particolare è il dettaglio del nastro che prolunga la treccia nera dei capelli della donna che ci volge le spalle, opportunamente a capo scoperto!
Curioso e particolare è il dettaglio del nastro che prolunga la treccia nera dei capelli della donna che ci volge le spalle, opportunamente a capo scoperto!
Dalla ricchezza del loro abbigliamento e dei gioielli che indossano è evidente che queste donne appartengono ad un ceto sociale elevato e se ne nota tutta la distanza rispetto alla serva che, in secondo piano, sta uscendo dall’ombra del portico portando un vassoio di frutta.
Ecco una delle più vere rappresentazioni di un’odalisca fra quelle in mostra. In un contrasto sociale che sembra essere richiamato dall’altrettanto netto contrasto fra l’ombra del cortile interno nel chiuso del quale le donne dell’harem si riparano ed il caldo bruciante del sole all’esterno di esso che si percepisce riflesso sulla parete di fondo, dietro l’aiuola nella quale è radicato il sinuoso tronco di una pianta rampicante.
Non è affatto tale, invece, L’odalisca (1880), di Pasquale Celommi (Montepagano, Roseto degli Abruzzi, Teramo 6 gennaio 1851 – Roseto degli Abruzzi, 9 agosto 1928).
Maestro di vita, per la disciplina nel lavoro e l’austerità di costumi e sentimenti, come lo fu del pennello, ad inizio carriera dipinse principalmente tele di gusto prettamente accademico-classicista o di atmosfera esotica in stile morelliano (di cui parleremo più avanti trattando di Domenico Morelli al quale è riferita la definizione). Vincendo un concorso nel 1873 ebbe la possibilità di frequentare la Scuola libera del nudo istituita presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze, città dove sposò, il 18 agosto 1880, Giuseppina Giusti, l’allora diciassettenne nipote del poeta Giuseppe Giusti con la quale ebbe 11 figli.
Proprio di quest’anno è il dipinto che abbiamo davanti agli occhi e che mostra una pennellata particolarmente pastosa ed un uso di colori scuri e “pieni”, comunque mai squillanti, come era nella maggior parte dei casi per la sua pittura di fine ‘800. Corrisponde all’ultima fase di questo suo stile che, con la maturità, si evolve diventando fortemente verista.
Un cambiamento avviato nel 1881, poco dopo la nascita del suo primogenito Raffaello. A causa della salute precaria del piccolo, Celommi lasciò Firenze e tornò a Roseto dove, a contatto con la propria gente, “poté sciogliersi dalle pastoie onde lo aveva avvinto quell’accademia e studiare da vicino quella natura rustica, che egli aveva tanto amato”, questo si leggeva sulla stampa dell’epoca, ed ancora “tosto ne risentì anche un benefico effetto, perocché i suoi quadri divennero ricercatissimi, le sue figure non più modelli travestiti ma quali si vedono nella vita, e però i suoi quadri ebbero impronta singolare di vitalità e di sentimento vero” cosicché “il successo delle opere fruttò al giovine artista abruzzese le simpatie delle famiglie aristocratiche che facevano a gara per averlo nei loro principeschi ricevimenti”. Una stampa che fino al termine della sua carriera gli fu sempre favorevole arrivando a definirlo “il pittore della luce”.
 Tornando al quadro in mostra, come dimostrato dalla sua biografia, non è affatto un’odalisca la donna che Celommi dipinge seminuda ed adagiata su un divano letto, che a Milano in famiglia si è sempre chiamata, guarda caso, ottomana!
Tornando al quadro in mostra, come dimostrato dalla sua biografia, non è affatto un’odalisca la donna che Celommi dipinge seminuda ed adagiata su un divano letto, che a Milano in famiglia si è sempre chiamata, guarda caso, ottomana!
L’ambientazione orientale è semplicemente una variazione al tema del nudo femminile e questo che dipinge è un cliché, uno stereotipo, perché l’artista un’odalisca vera non l’ha mai vista. Cosa del resto impossibile da farsi per chiunque visto che, come si è già spiegato, l’harem è luogo proibito per gli estranei alla casa.
Come avevano compreso i suoi contemporanei, il tutto è dunque una esposizione della bravura tecnica dell’artista. Nella quinta di pesanti tessuti a colori vivaci che la donna solleva tirando il cordone dorato per mostrarci, sotto le foglie di una palma, il pavimento cosparso di fiori. Nel “muovere” con morbida verosimiglianza il tessuto a riquadri con frange che la copre trasversalmente in vita ed il sottile velo trasparente sul resto del corpo. Ed ancora, nei tre giri di perle del bracciale e nelle piastre d’oro dei gioielli e dell’acconciatura dei capelli, che le scendono lunghi sulle spalle e si spargono sul cuscino.
È felice, e sorride, l’odalisca di Celommi, mentre stringe fra le dita una sigaretta accesa, forse un’incongruenza, visto che ha accanto il narghilè… Chissà!
Si è detto più volte che l’harem era un luogo proibito e tuttavia, chi avesse viaggiato in oriente poteva averne un’idea più esatta. È il caso di Alberto Fabbi (Bologna, 20 settembre 1858 – 21 maggio 1906) fratello maggiore di Fabio e che ancora più di lui soggiornò in oriente fra Bulgaria, Maghreb e Balcani.
Con analogo percorso formativo, compiuti gli studi al corso di pittura dell’accademia di belle arti di Bologna, si trasferì a Firenze assieme a Fabio specializzandosi nel ritratto e nella pittura di soggetto orientale. Ma anche l’attività artistica dei due fratelli si intreccia strettamente: nei primi anni in diretta collaborazione per l’illustrazione di numerosi almanacchi strenna e più tardi in dipinti di maggior impegno compositivo realizzati a quattro mani.
Un legame cementato anche dalla comune curiosità esotica e certificato dal fatto che, alla I e III edizione dell’Esposizione di belle arti della Società Francesco Francia (1896-1897), ai Fabbi fu interamente dedicata una sala in cui esposero quadri di tema orientale.
 Quello che vediamo, Harem, del 1883, ci permette di precisare che gli harem erano anche domestici e non soltanto un’esclusiva imperiale, come sembra però che sia il nostro.
Quello che vediamo, Harem, del 1883, ci permette di precisare che gli harem erano anche domestici e non soltanto un’esclusiva imperiale, come sembra però che sia il nostro.
La ricchezza non ordinaria di questo interno è evidente: la parte alta della parete a mosaico azzurro, il drappo verticale dorato ad arabeschi dietro il servo nero, e quello sospeso al soffitto come fosse un baldacchino a coprire l’angolo dove, su tappeti e cuscini, è distesa la donna di più alto lignaggio circondata da quelle che effettivamente possono essere odalische nel senso giusto del termine: dame di compagnia che la intrattengono; l’una pizzicando uno strumento a corda, la seconda danzando e percuotendo un tamburello mentre la terza, di spalle ai suoi piedi, non è chiaro cosa stia facendo.
Fra pelli di leopardo alla parete, e fiori sparsi sul pavimento, dove si aggirano anche due fagiani argentati, l’atmosfera generale non è però particolarmente vivace e l’aria di tutte è più mesta che annoiata.
Forse questioni di cuore che né bevande né il fumo aiutano a risolvere. Infatti si vedono una brocca ed un narghilé accando alla donna sdraiata che, però, si fa aria con un ventaglio a forma di cuore!
Non siamo in grado di mostrarlo anche qui, però in mostra abbiamo potuto verificare che l’attuale cornice di questo quadro è ancora quella con la quale il committente ha chiesto di sostituire la prima originale, facendovi poi scrivere in arabo il terzo caposaldo della fede musulmana: “Non c’è nessun dio al di là di Allah”.
Chiude il piccolo harem della mostra La favorita del sultano, acquerello del 1881, periodo in cui questa tecnica era tornata in voga, di Girolamo Induno (Milano, 13 dicembre 1825 – Milano, 18 dicembre 1890).
Fratello minore di Domenico (Milano, 14 maggio 1815 – Milano, 5 novembre 1878), al quale deve l’ispirazione per le scene di genere che dipinge, ci è più noto per le sue opere in tema risorgimentale.
Scorrendone rapidamente la biografia si comprende come non sia improprio definirlo letteralmente pittore e patriota. Nel 1849 partecipa alla difesa della Repubblica Romana, venendo anche ferito in modo grave. Non pago dell’esperienza, dal 1854 al 1855 partecipa alla campagna di Crimea come pittore-soldato nel corpo dei bersaglieri di Alessandro La Marmora. Veste per la quale è considerato fra i principali artisti del Risorgimento.
Al ritorno in patria i disegni, studi e resoconti per immagini che ha eseguito sui campi di battaglia gli permettono di dipingere quadri di cui critica e pubblico apprezzano molto i sentimenti che vi esprime. Una visita alle Gallerie d’Italia, di piazza della Scala a Milano, permette di averne un’idea ammirando il celebre La battaglia della Cernaia, commissionato da Vittorio Emanuele II.
Alla fine del decennio 1860 il clima di inquietudine e di instabilità di quel momento storico influenza il suo modo di dipingere indirizzandolo a prediligere soggetti di gusto neosettecentesco, molto richiesti dalla committenza, realizzati con una pennellata quasi virtuosistica.
A questa più tarda stagione dunque appartiene La Favorita, cosa che spiega la malinconia di fondo che ci sembra di cogliervi nonostante il mezzo sorriso ostentato dalla protagonista: dalle babbucce abbandonate in “studiato” disordine per inquadrare la firma del pittore, dai colori sfumati di fiori e foglie della parete vegetale sullo sfondo, dalla rosa gialla che tiene in mano ma, soprattutto, dalla quantità di mozziconi di sigaretta che ha gettato a terra davanti a sè.
III - L’ORIENTE MISTICO, NEL NOME DI DIO
 Già citato in precedenza come maestro di riferimento per Pasquale Celommi (così come lo sarà per altri che incontreremo), è Domenico Morelli (Napoli, 7 luglio 1823 –13 agosto 1901) che, portandoci in una Via di Costantinopoli, ci introduce nella terza sezione della mostra: nella quale è indagato l’aspetto religioso dell’oriente. Il dipinto ci mostra un gruppo di donne come le si può incontrare in pubblico in uno stato in cui è legge civile la religione islamica, ovvero completamente coperte dal niqab, abito completo di velo sulla testa che lascia aperta solo una fessura per gli occhi.
Già citato in precedenza come maestro di riferimento per Pasquale Celommi (così come lo sarà per altri che incontreremo), è Domenico Morelli (Napoli, 7 luglio 1823 –13 agosto 1901) che, portandoci in una Via di Costantinopoli, ci introduce nella terza sezione della mostra: nella quale è indagato l’aspetto religioso dell’oriente. Il dipinto ci mostra un gruppo di donne come le si può incontrare in pubblico in uno stato in cui è legge civile la religione islamica, ovvero completamente coperte dal niqab, abito completo di velo sulla testa che lascia aperta solo una fessura per gli occhi.
Anche Morelli, però, in oriente non c’è mai stato. Invece, come Girolamo Induno, anche lui partecipò attivamente alle vicende politiche nazionali. In gioventù a Roma, dove era andato per studiare, prese parte ai moti del 1848 e provò il carcere, seppure per poco, ma poi arrivò ad essere senatore del Regno d’Italia nella XVI legislatura.
Considerato uno dei più importanti artisti napoletani del XIX secolo, ricevette molti riconoscimenti pubblici e ricoprì incarichi di prestigio. Negli anni sessanta, ormai pittore affermato, fu nominato consulente del museo nazionale di Capodimonte per le nuove acquisizioni così contribuendo alla formazione delle collezioni d’arte. E nel 1868 ottenne la cattedra d’insegnamento all’Accademia di Belle Arti di Napoli (dove aveva cominciato gli studi nel 1836) che infine diresse dal 1899 sino alla morte.
Dopo i primi dipinti improntati all’ideale romantico, con numerosi influssi medievali specialmente ispirati dal poeta inglese Byron, partecipò nel 1855 all’Esposizione Universale di Parigi e, di ritorno, prese parte ai dibattiti dei Macchiaioli sul realismo pittorico.
Il suo stile divenne così gradualmente meno accademico e più libero, soprattutto nell’uso del colore, fondendo verismo e tardo-romanticismo a modelli neoseicenteschi.
Per un decennio poi, dal 1874 al 1883 circa, si inserì nella corrente degli orientalisti italiani dipingendo quadri con soggetti analoghi a quelli in mostra e per i quali fu, in ambito napoletano, un punto di riferimento per altri artisti così come Alberto Pasini lo era per l’Emilia Romagna.
Per rimediare alla mancata conoscenza diretta dei luoghi, Morelli però si documentava, sia sugli aspetti storici sia su quelli religiosi, avendo come riferimento il Positivismo e la volontà di dipingere quello che si vede che evolverà nel Realismo.
Sull’Islam e la figura di Maometto Morelli studiò la storia del contributo arabo alla formazione della cultura spagnola pubblicata in Mahomet and His Successors del 1850, una delle ultime opere di Irving Washington (New York, 3 aprile 1783 – 28 novembre 1859).
Mentre la storia degli Ebrei e della vita di Cristo che lo ispirarono furono quelle presentate dallo storico delle religioni Joseph Ernest Renan (Tréguier, 28 febbraio 1823 – Parigi, 2 ottobre 1892): autore della popolare Vie de Jésus, primo dei sette volumi in cui si sviluppa l’Histoire des Origines du Christianisme.
Terminata quest’opera cominciò la Storia di Israele in cinque volumi, gli ultimi due pubblicati postumi: con diversi limiti come storia di fatti e teorie ma di straordinaria importanza come saggio sull’evoluzione dell’idea religiosa.
Personaggio di spicco, fra gli artisti in mostra, e conosciuto anche oltre l’ambito degli interessati all’Orientalismo, è Pompeo Mariani (Monza, 9 settembre 1857 – Bordighera, Imperia, 25 gennaio 1927), noto anche per essere stato il pittore che fece aspettare la Regina Margherita!
Sua madre, Giulia, era figlia del pittore Giosuè Bianchi e sorella del più famoso Mosè. Nonostante l’arte fosse di casa in famiglia, dopo gli studi ginnasiali a Monza, il giovane Pompeo venne indirizzato ad una più ordinaria carriera bancaria a Milano. Anche qui, però, frequentando gli ambienti culturali del tempo, la Pasticceria Cova e La Scala, ne conosce personalità come Arrigo Boito ed altri e si dedica alla musica ed al disegno di caricature per infine arrivare, nel 1878, a prendere lezioni di pittura in segreto dalla «gloria milanese», come era definito dalla stampa del tempo, Eleuterio Pagliano.
Il definitivo via libera per la sua passione lo ottiene grazie all’intercessione dello zio Mosè che lo spinge a dipingere all’aperto nel Parco di Monza. Ma l’avvio della sua carriera di pittore lo deve al viaggio in Egitto che compie nel 1880 e dal quale riporta lavori che presenta alle esposizioni dell’Accademia di Brera nel 1881 e 1882 suscitando interesse ed anche un buon successo commerciale.
 Del 1881 è Preghiera araba che troviamo in mostra nel quale vediamo, in un contesto orientale con moschee e minareti sullo sfondo, lo stesso atteggiamento che ormai non è più così raro vedere anche spostandosi per Milano, e non soltanto nelle adiacenze dei luoghi espressamente deputati alla preghiera. Nel giro di pochi mesi ci è capitato un paio di volte a mezzogiorno: in un giardinetto seminascosto dalle siepi perimetrali all’inizio di via Melchiorre Gioia, appena nord del sottopasso dei Bastioni di Porta Nuova, e sul più ampio spazio aperto dei prati del Parco Nord.
Del 1881 è Preghiera araba che troviamo in mostra nel quale vediamo, in un contesto orientale con moschee e minareti sullo sfondo, lo stesso atteggiamento che ormai non è più così raro vedere anche spostandosi per Milano, e non soltanto nelle adiacenze dei luoghi espressamente deputati alla preghiera. Nel giro di pochi mesi ci è capitato un paio di volte a mezzogiorno: in un giardinetto seminascosto dalle siepi perimetrali all’inizio di via Melchiorre Gioia, appena nord del sottopasso dei Bastioni di Porta Nuova, e sul più ampio spazio aperto dei prati del Parco Nord.
Le preghiere obbligatorie, in Arabo chiamate “Salat”, sono il secondo dei cinque pilastri della religione Islamica e sono cinque nell’arco della giornata i momenti in cui il fedele musulmano è chiamato alla preghiera. La più importante è quella del Venerdì a mezzogiorno. Gli orari variano con la posizione del sole e sono annunciati dal Muezzin che recita l’adhan (detto anche ezan) dai minareti della moschea.
Nella preghiera il credente si rivolge al Dio senza un intermediario e così facento crea un un legame diretto con Allah.
Anche se sarebbe preferibile farlo insieme a tutti nella moschea, come abbiamo visto un Musulmano può pregare quasi ovunque, purché il luogo sia pulito e adatto all’adorazione.
Occorre conoscere la Qibla, cioè la direzione della Mecca, perché ad essa l’orante si deve rivolgere.
A dire la verità, i due che abbiamo visto, dalla fisionomia non araba ma sub sahariana, non ci pare fossero orientati proprio correttamente. Infine, come si vede nel dipinto, di solito si prega scalzi su un tappeto da preghiera, che ha precise caratteristiche come abbiamo visto nella piccola ma interessante mostra che il Poldi Pezzoli ha dedicato ai suoi tappeti persiani (info su www.museopoldipezzoli.it), ancora aperta fino al 18 settembre e che invitiamo a visitare (assieme al resto del museo, per la cui visita si possono trovare utili spunti fra quanto ne abbiamo scritto in Le Dame dei Pollaiolo, leggi di più >>> e in Sotto il segno di Leonardo. La magnificenza della corte sforzesca nelle collezioni del Museo Poldi Pezzoli, leggi di più >>>).
Chi lo farà vi potrà scoprire di persona come fare a capire se il tappeto dipinto da Pompeo Mariani è un vero tappeto da preghiera oppure no. Avevamo pensato di lasciare ai lettori la curiosità e di pubblicare la soluzione su questa pagina a mostra conclusa, però riteniamo che averne già una conoscenza possa viceversa invogliare maggiormente ad una visita e perciò, eccola qui fin da subito.
Fra i suoi preziosi tappeti che la Casa Museo di via Manzoni ha recentemente esposto in mostra qui ci interessa soffermarci sui due rispettivamente denominati Ghiordes, dall’Anatolia occidentale e datato fra il XVII e il XVIII secolo, e Shirvan, dal Caucaso centro orientale della metà del XIX secolo, e perciò coevo ai dipinti di cui ci stiamo interessando.
Entrambi tessuti in lana, sono inequivocabilmente destinati alla preghiera avendone il classico, relativo, impianto.
Il Ghiordes presenta infatti una nicchia con arco a punta retto da colonne sotto il quale pende la caratteristica lampada con l’acquamanile (prezioso recipiente destinato a contenere l’acqua per lavarsi le mani, foggiato a forma di animale, creatura leggendaria, cavaliere, testa o busto umano) che appare già nei modelli più antichi e riproduce fedelmente le lampade accese al centro degli archi nelle moschee, e che vedremo a breve: appese sopra la porta della moschea dipinta da Roberto Guastalla. Inoltre simboleggia la “luce di Allah”, la luce divina oltre l’arco.
Questo tappeto discende dai modelli della corte ottomana del XVI secolo dai quali il disegno si è sviluppato con una graduale geometrizzazione dell’arco, trasformato in una “V” rovesciata che appoggia sulle caratteristiche spalle.
La nicchia di colore rosso vivo è molto tipica.
L’arco del secondo tappeto ha invece forma pentagonale. Il suo campo è decorato da motivi floreali stilizzati, inseriti in una grata esagonale che poggia su un fondo bianco avorio.
Il bordo principale, rosso, è ornato da motivi di probabile origine zoomorfa.
Questo esemplare appartiene ad un gruppo molto numeroso di tappeti dall’impianto “a preghiera” di probabile derivazione anatolica.
Ricorrente, in questa tipologia, è il motivo del pettine, che qui appare tredici volte ed è un simbolo forse collegabile alla pioggia.
Già presente nell’inventario del Museo del 1879, alla sua apertura, nel 1881, questo tappeto era esposto nel Salone dorato per passare, nei primi decenni del Novecento, nella sala dei lombardi.
[testo tratto dalle didascalie della mostra I tappeti persiani del Poldi Pezzoli, 2017]
 A proposito di rimandi a collezioni permanenti, che sempre ci piace fare da queste pagine elettroniche, altre opere “Orientaliste” di Pompeo Mariani - Deserto (1881-1888), con Sfinge e linee di soldati armati di lancia a dorso di cammello ed armati di moschetto quelli a piedi, e Veduta del Cairo (1881) lungo la riva del Nilo - sono esposte nel bell’allestimento dei vivaci Musei Civici della sua Monza che qui incoraggiamo a visitare. Segnaliamo che vi si potrà ammirare anche una delle copie del bronzo In carovana di Ernesto Bazzaro già citata esposta fra le vedute di Pasini. Invece, tornando su Deserto di Pompeo Mariani, l’osservazione ravvicinata rattrista perché risultano più evidenti le sue portroppo pessime condizioni di conservazione. Sono ampie le lacune in cui emerge addirittura la tela e numerosi i punti in cui il colore si è perso. A risentirne sono soprattutto i monumenti, le rocce e la vegetazione in primo piano, gran parte della linea di soldati più lontana e, dai piccoli ed isolati tocchi di pennello che ne restano, si intuisce che ce n’era un’altra sulle prime dune a sinistra. Prima di andare a consolarsi con le sue marine liguri in una sala successiva, questo limite consente comunque anche al pubblico degli appassionati un’osservazione più da storici dell’arte e che normalmente è consentita solo a chi abbia accesso alle tecnologie scientifiche: specialmente in corrispondenza delle rocce al centro, della colonna caduta sulla destra oltre che della Sfinge e del monumento più laterale (che non si capisce cosa rappresenti) si vedono sulla tela i segni che Pompeo Mariani ha tracciato come schema guida per dipingere questa sua veduta esotica.
A proposito di rimandi a collezioni permanenti, che sempre ci piace fare da queste pagine elettroniche, altre opere “Orientaliste” di Pompeo Mariani - Deserto (1881-1888), con Sfinge e linee di soldati armati di lancia a dorso di cammello ed armati di moschetto quelli a piedi, e Veduta del Cairo (1881) lungo la riva del Nilo - sono esposte nel bell’allestimento dei vivaci Musei Civici della sua Monza che qui incoraggiamo a visitare. Segnaliamo che vi si potrà ammirare anche una delle copie del bronzo In carovana di Ernesto Bazzaro già citata esposta fra le vedute di Pasini. Invece, tornando su Deserto di Pompeo Mariani, l’osservazione ravvicinata rattrista perché risultano più evidenti le sue portroppo pessime condizioni di conservazione. Sono ampie le lacune in cui emerge addirittura la tela e numerosi i punti in cui il colore si è perso. A risentirne sono soprattutto i monumenti, le rocce e la vegetazione in primo piano, gran parte della linea di soldati più lontana e, dai piccoli ed isolati tocchi di pennello che ne restano, si intuisce che ce n’era un’altra sulle prime dune a sinistra. Prima di andare a consolarsi con le sue marine liguri in una sala successiva, questo limite consente comunque anche al pubblico degli appassionati un’osservazione più da storici dell’arte e che normalmente è consentita solo a chi abbia accesso alle tecnologie scientifiche: specialmente in corrispondenza delle rocce al centro, della colonna caduta sulla destra oltre che della Sfinge e del monumento più laterale (che non si capisce cosa rappresenti) si vedono sulla tela i segni che Pompeo Mariani ha tracciato come schema guida per dipingere questa sua veduta esotica.
Altro viaggiatore è Roberto Guastalla (Parma, 15 agosto 1855 – Viarolo, Parma, 3 settembre 1912).
Svolse i primi studi a Napoli, dove il padre Giuseppe, generale dei Carabinieri Reali, si trovava in servizio negli anni della sua giovinezza e, come per i Fabbi, fu l’ammirazione per le opere di Alberto Pasini a farlo accostare all’Orientalismo: che sarà il tema dominante nella sua produzione artistica.
La lunga serie dei suoi viaggi lo vede dal 1886 al 1906 nei paesi del Vicino Oriente e dell’Impero Ottomano, in Egitto e in Marocco.
Nel 1906 attraversa gli stati Balcanici: Croazia, Montenegro, Serbia, Bosnia, Romania ed Ungheria. Infine, nel 1908, dopo aver visitato Sicilia e Tunisia, arriva fino in Namibia.
Come è facile intuire, gli innumerevoli spunti raccolti si traducono, naturalmente, in numerosissimi bozzetti, disegni e tele. E non va dimenticato che è fra i primi ad usare uno strumento nuovo per quei tempi, la fotografia.
 Il mezzo più appropriato per la sua inclinazione di documentarista che ci appare evidente nella puntuale restituzione della decorazione architettonica che sovrasta la Porta della moschea, del 1903: opera in cui siamo di nuovo condotti a guardare dall’esterno questo genere di edificio sacro.
Il mezzo più appropriato per la sua inclinazione di documentarista che ci appare evidente nella puntuale restituzione della decorazione architettonica che sovrasta la Porta della moschea, del 1903: opera in cui siamo di nuovo condotti a guardare dall’esterno questo genere di edificio sacro.
Guastalla ce ne mostra compiutamente i più piccoli dettagli: dal mendicante che chiede l’elemosina davanti ai suoi gradini, alle sagome umane che anche qui, come anche in altri dipinti in mostra, si intravedono come ombre all’interno buio delle finestre o delle porte degli edifici, alle scrostature delle sue pietre… che la fanno sembrare il progetto di un antenato orientale dello svizzero Mario Botta!
C’è chi ha definito il suo stile oleografico, ovvero poco originale, convenzionale, stereotipato e di non rilevante valore artistico. Giudizio, a parer nostro, forse eccessivamente severo.
In chiusura della sezione ritroviamo Domenico Morelli con uno fra i suoi dipinti più celebri: La Figlia di Giairo o Talita cumi che, nella lingua aramaica parlata da Gesù di Nazareth, significa: “fanciulla sorgi”.
Quest’opera di grandi dimensioni risale al 1874, anno che, come già si è visto, segna l’avvio dell’interesse di Morelli per l’Orientalismo, anche se in questo caso ci troviamo forse in una transitoria via di mezzo, dato il soggetto evangelico. Ricorre infatti nei Vangeli sinottici: raccontato da Matteo, Marco e Luca in tre versioni ciascuna delle quali evidenzia particolari che Morelli riassume tutti nel suo dipinto e che perciò a nostra volta qui ricapitoliamo.
Siamo nel nord di Israele, non lontani dal confine con Libano e Siria, a Cafarnao, villaggio sulla costa nord-occidentale del Lago di Tiberiade (conosciuto anche come “Mare di Galilea”) in cui sfocia il fiume Giordano. Gesù, sulla riva del lago, è circondato dalla folla quando Giàiro, uno dei capi della locale sinagoga, lo raggiunge e, gettandosi ai suoi piedi, lo prega con insistenza di recarsi a casa sua, perché ha un’unica figlia, di circa dodici anni, ammalata e che sta per morire: «La mia figlioletta è agli estremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva».
Mentre si stanno incamminando arriva uno di casa che gli dice: «Tua figlia è morta, Perché disturbi ancora il Maestro?». Ma Gesù, avendo udito, lo rassicura: «Non temere, soltanto abbi fede e sarà salvata» e si avvia, senza permettere a nessuno di seguirlo fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo.
Giunti alla casa vede trambusto: i flautisti e tutta la gente che piange e urla forte. Entrato, dice a quelli che stanno facendo il lamento su di lei: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme».
Viene deriso perché sapevano bene che era morta. Ma lui, cacciati tutti fuori tranne il padre e la madre e quelli che lo accompagnavano, entra dove era la bambina. Le prende la mano e le dice ad alta voce: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». Subito la vita ritorna in lei che si alza all’istante e si mette a camminare fra lo stupore generale. Ai genitori sbalorditi ordina di darle da mangiare raccomandando con insistenza di non raccontare a nessuno l’accaduto.
 Morelli dipinge il momento che precede il miracolo. Ci porta dentro la stanza, dove sembra di essere nella zona riservata ai fedeli di una sinagoga ed al cui centro tutta l’attenzione dell’osservatore è calamitata dalle donne inginocchiate che si disperano straziandosi il viso con le dita, agitando le braccia, portando le mani ai capelli o gettandosi a terra davanti al corpo della fanciulla, avvolto da un lenzuolo bianchissimo e tutto sommato marginale rispetto alla composizione.
Morelli dipinge il momento che precede il miracolo. Ci porta dentro la stanza, dove sembra di essere nella zona riservata ai fedeli di una sinagoga ed al cui centro tutta l’attenzione dell’osservatore è calamitata dalle donne inginocchiate che si disperano straziandosi il viso con le dita, agitando le braccia, portando le mani ai capelli o gettandosi a terra davanti al corpo della fanciulla, avvolto da un lenzuolo bianchissimo e tutto sommato marginale rispetto alla composizione.
Lo si nota, così come il suo volto che risalta sul cuscino arancione, solo per contrasto con il lungo tappeto colorato che attraversa il pavimento e conduce a lei il nostro sguardo.
Accovacciati lungo una parete, i suonatori di cimbali e gli auleti, con i flauti a una e due canne, rendono omaggio alla defunta… almeno apparentemente senza particolare trasporto ed, anzi, un po’ annoiati!
Fra gli accorsi che si affacciano in prima fila per assistere alla scena dalla luce della porta, visto che Gesù li ha tenuti fuori, c’è chi si dispera aggrappandosi con la mano allo stipite, altri, con le braccia incrociate, attendono gli eventi.
Giairo piange, piegato in due e coprendosi la faccia con le mani mentre sua moglie si rivolge a Gesù come se gli chiedesse il motivo del suo apparente distacco.
In piedi fra i due, diritto, fermo e solenne nella sua tunica rosso fuoco, Gesù resta imperturbabile e, a dire il vero (ci sia perdonata l’irriverenza!), ci sembra quasi che se la stia forse ridendo un poco, già sapendo che resusciterà la bambina. Naturalmente è fuori discussione l’ipotesi che l’artista abbia volutamente suscitare nell’osservatore questa sensazione!
Due curiosità attirano invece la nostra attenzione sulla parete di fondo.
La prima è una scritta in ebraico antico tratta dalla Torah, il testo sacro ebraico corrispondente al Pentateuco: i primi cinque libri della Bibbia cristiana. Letta al contrario rispetto a come siamo abituati noi (e cioè da destra a sinistra), rappresenta le cinque parole che li identificano e che elenchiamo di seguito (fra parentesi le ulteriori suddivisioni del testo ebraico):
Bereshit - Genesi (Bereshit, Noah, Lechlechà, Vaierà, Haiiè, Sarà, Toledot, Vaiezè, Vaishlach, Vaieshev, Mikez, Vaigash, Vaichì)
Shemot - Esodo (Shemot, Vaerà, Bo, Beshallach, Itrò, Mishpatim, Terumà, Tezavvè, Kitissà, Vaiakel, Pekudè)
Vaikrà - Levitico (Vaikrà, Zav, Sheminì, Tazria, Mezorà, Acharèmot, Kedoshim, Emor, Bear Sinai, Behukotai)
Bemidbar - Numeri (Bemidbar, Nasò, Beaalotecha, Shelach, Kòrach, Hukàt, Balàk, Pinechas, Mattot, Masè)
Devarim - Deuteronomio (Devarim, Vaetchannan, Ekev, Reè, Shofetim, Kitezè, Kitavò, Nizavim, Vaielech, Haazinu, Vezothaberachà).
Chiarita la traduzione, siamo invece totalmente all’oscuro, e perciò desiderosi di colmare la lacuna grazie ad eventuali lettori più acculturati, del significato che possono avere i fori aperti nella parete subito sotto la scritta. Troppo rigorosamente posizionati secondo precise geometrie, in gran parte corrispondenti a vertici di pentagoni, per essere casuali e privi di significato.
Il lettore Lino Sanfilippo ci vede il pentagono proprio come simbolo del Pentateuco. Cinque fori che si ripetono salvo cambiamenti di forma, o aggiunta di un punto interno, a sostenere le parole di Gesù: non sono venuto a cambiare la legge ma a perfezionarla.
Di questo dipinto, sempre nel 1874, Morelli realizzò un’altra versione appositamente dipinta per Giuseppe Verdi. Ma il musicista non aveva fatto i conti con la determinazione che abbiamo conosciuto di Goupil: che si innamorò a prima vista di quest’opera e… gliela “soffiò”!
IV - CARTOLINE DI VIAGGIO DALL’EGITTO A COSTANTINOPOLI
Arrivati alla sezione delle Cartoline di viaggio, per farcene spedire da Costantinopoli (al tempo però ormai divenuta Istambul) non c’è chi ne sia più adeguato conoscitore di Fausto Zonaro (Masi, Padova, 18 settembre 1854 – Sanremo, Imperia, 19 luglio 1929).
Vi arriva nel 1891 insieme ad Elisabetta Pante, sua ex allieva a Venezia ed ora sua compagna di vita, con la quale decide di avventurarsi in Oriente. È la svolta nella sua carriera.
Poco alla volta riesce ad introdursi negli ambienti aristocratici dai quali ottiene commissioni sempre più importanti e che lo appoggiano nella sua ascesa sociale che raggiunge il culmine con la nomina a “pittore di corte” del Sultano Abdul-Hamid II nel 1896. Amante dell’arte, a dispetto del fatto di essere conosciuto come “Il sanguinario”, quest’ultimo compra immediatamente il quadro Il reggimento imperiale di Ertugrul sul ponte di Galata che gli era stato mostrato dall’ambasciatore russo, per il quale Zonaro aveva realizzato alcuni dipinti.
All’acquisto segue l’ordine di altre opere, in particolare un ciclo sull’epopea del suo predecessore Maometto II, del quale in apertura abbiamo già visto l’ingresso a Costantinopoli e qui accanto ne vediamo l’assedio.
Ultimo pittore della corte imperiale di Costantinopoli, Fausto Zonaro, che spesso vediamo ritratto con il fez in testa, rimane nella Città d’Oro fino al 1909, anno in cui rientra in Italia quando il suo mecenate è spodestato dai Giovani Turchi. Si stabilisce allora a Sanremo dove è accolto con grande entusiasmo e continua a dipingere fino alla morte piccole vedute della Riviera Ligure e della vicina Costa Azzurra. Ma una clientela anche orientale contina a commissionargli ritratti e soggetti d’oriente, che non ha difficoltà a soddisfare grazie agli innumerevoli disegni riportati in patria dall’esperienza in Turchia. Dove molte delle sue opere sono tuttora conservate nei più importanti musei di Istanbul, fra i quali il Topkapi, il Palazzo Imperiale di Dolmabahçe e il Museo Militare.
 Il titolo del suo primo quadro in mostra Bayram, del 1898, in turco significa festa.
Il titolo del suo primo quadro in mostra Bayram, del 1898, in turco significa festa.
Più precisamente la festa che vediamo è un momento del cosiddetto Bayram piccolo, una delle due principali feste religiose islamiche che ha luogo al termine del Ramadan ed è più conosciuta con la denominazione araba di ‛īd al-fiṭr: “festa della rottura del digiuno”.
L’altra, il Bayram maggiore, che per importanza corrisponde al nostro Natale (nel sentire popolare, perché la più importante festa Cristiana è in realtà la Pasqua di Resurrezione), è la “festa dei sacrifizî rituali” che ricorda il sacrificio di Ismaele, il figlio che Abramo aveva ripudiato assieme a sua madre, la schiava egiziana Agar, e dal quale discende il popolo arabo (mentre quello ebraico discende da Isacco il figlio di Sara, la moglie legittima del patriarca).
Ma al di là del motivo religioso della festa, in questo dipinto c’è il racconto della polvere sollevata dai tre uomini che ballano, al suono della grancassa e della tromba, in un angolo fra le tende dei mercanti. A dimostrazione che anche allora, come in molte delle nostre odierne feste patronali, la spiritualità viene meno e le feste religiose si riducono a fiere commerciali.
C’è il racconto della polvere che si toglie dalla gola bevendo dai bicchieri sul vassoio sopra la seggiola impagliata accanto ai musicisti.
C’è il racconto della polvere discesa dalla scarpata in terra che incombe su di loro ed in mezzo alla quale si aggirano cani e bambini.
 Tutt’altro ambiente troviamo in Alture di Uskudar del 1890 circa. Una veduta che ci dà l’occasione di ricordare che Zonaro ne dipinge di Istambul più di quante Canaletto ne abbia dipinte di Venezia!
Tutt’altro ambiente troviamo in Alture di Uskudar del 1890 circa. Una veduta che ci dà l’occasione di ricordare che Zonaro ne dipinge di Istambul più di quante Canaletto ne abbia dipinte di Venezia!
Se non fosse per il fatto che sullo sfondo c’è il Bosforo e si riconoscono una moschea e due sottili minareti, sembra di trovarsi nei parchi di Parigi dove due giovani, in abiti eleganti, passano il tempo conversando sedute sui prati fioriti.
Anche la tecnica col quale il quadro è dipinto ci fa osare l’azzardata considerazione che sembra quasi di trovarsi di fronte ad una veduta di un pittore Impressionista, o forse, più correttamente, Macchiaiolo visto che le forme non vi si dissolvono ma restano ben riconoscibili. Nonostante l’epoca storica sia corrispondente, non si può tuttavia parlare in senso pieno di Macchiaioli (salva un'eccezione) nemmeno per gli altri artisti in mostra che pure, come vedremo, dimostrano affinità evidenti e sorprendenti con questa corrente italiana che anticipa l’Impressionismo e non le è affatto qualitativamente inferiore; essendo risultata penalizzata nel favore di critica e pubblico solo per il fatto di essere geograficamente collocata in una nazione, l’Italia, che allora era “periferia” d’Europa rispetto a Parigi: il centro culturale del continente dove si stabiliva quel che era di moda e che quindi poteva avere successo.
A proposito di relazioni fra centro e periferie, rispetto ai percorsi di altri artisti già incontrati, o che incontreremo, lo fa al contrario Italo Nunes Vas (Tunisi, 2 marzo 1860 – Firenze, 1932): arrivato in giovane età a Firenze dalla natale Tunisia (ma da genitori italiani, che evidentemente ci tennero a precisarne la nazionalità nel nome proprio) e successivamente trasferitosi a Napoli dove fu tra gli allievi di Domenico Morelli.
Molto presente nelle esposizioni nazionali, da Firenze a Genova, da Milano a Venezia e fino all’Accademia Garibaldi a Taganrog, città portuale della Russia sul Mar d’Azov, a nord del Mar Nero al confine con l’Ucraina.
I soggiorni temporanei a Tunisi, nel 1883 e nel 1890, furono occasione per studi dal vero, poi rielaborati in studio, che consolidarono la sua predilezione per i quadri di genere e la figura, era un abile ritrattista, dando credibilità ai suoi molti dipinti di soggetti tunisini ed orientali in generale; trattati con finezza e facendo uso dei toni evocativi cari alla sensibilità del tempo.
Ne sono esempio Bazar dei sarti, Bazar delle stoffe, Nel caffè, Tunisi, Testa di giovinetta tunisina, e Nell’Hammam Tunisia, del 1890 c.a., che vediamo in mostra e nel quale campeggia in alto il marchio ottomano della stella sopra la mezzaluna.
Curiosamente questo stemma ha origini cristiane essendo la stella un omaggio alla vergine Maria aggiunto, dopo il 330 d.C. quando Costantinopoli divenne cristiana, alla luna crescente: simbolo di Artemide e simbolo dell’inespugnabilità della città fin dai tempi di Bisanzio. Grazie alla luce di una luna crescente che un vento improvviso liberò tempestivamente dalle nubi che la coprivano, i suoi difensori respinsero con successo, nel IV secolo a.C., l’assedio alle sue mura portato da Filippo II di Macedonia, che stava per averne ragione ed invece fu costretto a desistere per le gravi perdite subite dal suo esercito.
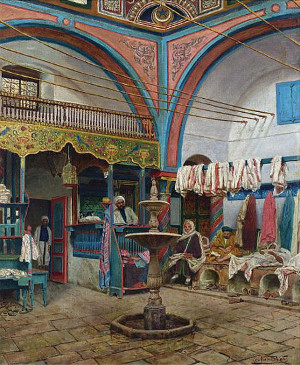
L'HAMMAM
L’Hammam, detto anche Bagno turco, era un complesso termale che i musulmani ereditarono dai bizantini e mantennero per effettuarvi i riti di purificazione del corpo indispensabili per adempiere all’obbligo canonico della preghiera giornaliera. Naturalmente, come già avveniva in ambito romano antico e bizantino, l’hammam acquisì presto la funzione sociale di luogo ideale per incontrarsi, trascorrere piacevolmente il tempo prendendosi cura di sé ed anche per concludere affari vantaggiosi. La considerazione di cui godeva questo luogo è testimoniata dal fatto che già in Le mille e una notte (raccolta di novelle risalenti al X secolo d.C.) la protagonista Sherazade dice all’insonne re indiano che “Una città non è completa se non ha il suo hammam”. L’obbligo della separazione dei sessi fece stabilire orari diversi (ed equamente ripartiti) per l’accesso di uomini e donne.
Il dipinto ci mostra il turno maschile con i tre clienti che, deposte le calzature a terra davanti a sé ed appesi gli abiti alle proprie spalle, sono, naturalmente, ben coperti (diversamente da quanto si è visto in Ingres) dalle tuniche tutte uguali fornite dall’inserviente che ne tiene in buon numero piegate sul bancone dietro al quale attende di servire un altro cliente in arrivo.
Risulta che nelle terme trovassero stabile impiego numerosi addetti, e fra questi gli incaricati delle caldaie dove si riscaldava l’acqua che, tramite tubazioni, veniva immessa nelle sale ed il cui vapore fuoriusciva dalle particolari strutture, riprodotte anche nel dipinto, sulle quali si accomodavano, sdraiati o seduti i clienti.
Lasciando la Tunisia e scavalcando la Libia, le cartoline successive arrivano dall’Egitto: con primo mittente il pittore, illustratore ed incisore Cesare Biseo (Roma, 18 aprile 1843 – 25 gennaio 1909).
Allievo del padre Gian Battista, e dopo aver frequentato le Accademie romane di San Luca e di Francia (in Villa Medici), su invito del viceré d’Egitto affrescò il Palazzo del Governo ad Alessandria ed il teatro del Cairo di cui si è già scritto. Nel 1875 andò in Marocco con una missione diplomatica italiana di cui facevano parte anche il pittore Stefano Ussi, anch’egli orientalista, e l’autore di Cuore, Edmondo de Amicis, di cui i due illustrarono il libro Marocco del 1879. Il suo libro successivo, Costantinopoli, del 1882, fu invece illustrato dal solo Biseo.
È classificato come pittore orientalista “di grande spessore emotivo e di grande ricchezza cromatica” anche per l’influenza che ebbe su di lui la conoscenza a Roma del pittore spagnolo dal nome italianizzato Mariano Fortuny (Reus, 11 giugno 1838 – Roma, 21 novembre 1874), celebre per i dipinti che illustrarono la guerra Ispano-Marocchina ed in particolare la determinante battaglia di Tetuán e che dall’Africa tornò in Europa con negli occhi, e nel pennello, la carica vivacità dei suoi colori.
 Quanto, e se, questa classificazione sia giusta i visitatori l’hanno potuto giudicare da soli in La cittadella del Cairo, del 1883. In primo piano, inginocchiato e bardato, è un dromedario che attende il suo conducente. Subito dietro ritroviamo la stessa donna del bronzo di Bazzaro: anche questa seduta sulla portantina col bambino in braccio e le ginocchia piegate nella posa che consente di cavalcare l’animale. Intanto sta arrivando un terzo cammelliere: la carovana è quasi pronta a partire.
Quanto, e se, questa classificazione sia giusta i visitatori l’hanno potuto giudicare da soli in La cittadella del Cairo, del 1883. In primo piano, inginocchiato e bardato, è un dromedario che attende il suo conducente. Subito dietro ritroviamo la stessa donna del bronzo di Bazzaro: anche questa seduta sulla portantina col bambino in braccio e le ginocchia piegate nella posa che consente di cavalcare l’animale. Intanto sta arrivando un terzo cammelliere: la carovana è quasi pronta a partire.
Al centro uomini assonnati, come i due cani stesi sulla sabbia lì vicino, oziano seduti accanto ad un suonatore di flauto che attira l’attenzione… di una capra!
Più indietro si acquistano arance mentre un asino viene sellato e due soldati vigilano che l’ordine sia rispettato dall’alto dei propri cavalli.
 La folla di persone in secondo piano diventa più indistinta anche se Biseo vi inserisce ancora qualche particolare come un ambulante che porta sulla testa un grande vassoio completo di forme di pane e donne con l’ombrellino parasole si notano in mezzo alla distesa di tende sulla sinistra: ognuna delle quali è dipinta con un’unica pennellata.
La folla di persone in secondo piano diventa più indistinta anche se Biseo vi inserisce ancora qualche particolare come un ambulante che porta sulla testa un grande vassoio completo di forme di pane e donne con l’ombrellino parasole si notano in mezzo alla distesa di tende sulla sinistra: ognuna delle quali è dipinta con un’unica pennellata.
Un rustico muro a secco protegge un giardino in cui cresce l’unico albero presente e segna il confine con i retrostanti edifici in muratura. Sulla sinistra si ammassano una sull’altra le abitazioni popolari fra le quali svetta il bianco di un palazzo non meglio identificato.
Invece il volume verde dell’albero sopra descritto collega il primo piano alla cittadella i cui edifici intonacati in bianco spuntano da sopra le alte mura e su tutto svettano, riconoscibilissime anche per noi, le cupole della grande moschea Mohamed Ali, con i suoi due sottili ed inconfondibili minareti e le sue sei torricelle che li accompagnano.
Altro orientalista romano, sebbene “d’importazione”, è Hermann David Salomon Corrodi (Frascati, 23 luglio 1844 – Roma, 30 gennaio 1905), figlio dell’artista preferito dallo zar Nicola I di Russia: il pittore svizzero Salomon Corrodi.
Come suo fratello Arnold, venne avviato dal padre alla pittura ed a dipingere secondo natura, dando attenzione agli effetti della luce ed al gioco dei colori. Proseguì gli studi a Ginevra, dove gli fu maestro Alexandre Calame, per completarli, infine, all’Accademia di San Luca a Roma, di cui il padre era membro onorario, oltre che docente.
Hermann Corrodi viaggiò moltissimo in tutta Europa insieme a suo fratello col quale condivideva l’attività e l’atelier. In questo modo conobbero molte persone dell’alta società che garantirono loro contatti con le corti e con importanti committenti. A Parigi, nel 1872, conobbero Meissonier e Gérôme, a Londra furono ospiti di Alma-Tadema (conosciuto in Vista dall'Africa: la mia Europa che dipinge, leggi di più >>>) per passare poi a Monaco, Capri e Vienna.
Abbattuto dal dolore per la morte di Arnold, nel 1874, per due anni abbandonò la pittura. Che riprese nel 1876, quando si sposò e ricominciò a dipingere e viaggiare visitando Istanbul, Siria, Egitto, Montenegro e Corsica.
Queste nuove esperienze arricchirono la sua arte, incentrata sugli esterni di paesaggi e vedute attente alla descrizione della natura, anche di vedute orientali che lo fecero apprezzare soprattutto come pittore orientalista che aveva fra i suoi acquirenti anche Guglielmo II e la famiglia reale inglese.
Un catalogo completo della sua attività artistica è difficile da realizzare perché gran parte delle sue opere sono perdute o in collezioni private.
Quanto sia preponderante il suo interesse è evidente nel placido Paesaggio con figure sul Nilo in cui è dipinto tutto quello che ci si aspetta di vedere in Egitto.
In lontananza, sulla sinistra, quasi un perdimento leonardesco, stanno le solide sagome delle piramidi.
Sulla destra alti speroni rocciosi sovrastano il sentiero sulla duna, segnato da un “colonnato” di palme col tipico ciuffo di foglie in cima ad un tronco spoglio.
Sentiero che arriva fino alla riva del Nilo e che alcune donne hanno percorso e percorrono, con la brocca di coccio in equilibrio sulla testa, per attingervi l’acqua.
Il tutto dà però l’impressione di essere soltanto un “contorno” per ciò che interessa veramente il pittore: la “grande” natura morta centrale costituita dalla macchia verde della vegetazione che quasi “esplode” come un fuoco d’artificio ed è dipinta con una nitidezza che le altre parti del dipinto non hanno e che permette di riconoscere (ma a chi già le conosca!) le singole specie presenti: noi ci accontentiamo dei cespugli di fichi d’India!
 Scena analoga, ma con priorità data alla larghezza, anziché disposta in verticale come la precedente, e perciò con orizzonte più aperto, la dipinge ancora Pompeo Mariani, in Il Nilo a Ghesirah, del 1881.
Scena analoga, ma con priorità data alla larghezza, anziché disposta in verticale come la precedente, e perciò con orizzonte più aperto, la dipinge ancora Pompeo Mariani, in Il Nilo a Ghesirah, del 1881.
Ancora vediamo donne che attingono acqua al fiume, qui maestoso e presentato in tutta la sua largezza al punto che, con un titolo diverso e consapevoli del fatto che non si va ad attingere con le brocche l’acqua salata, non faticheremmo a crederlo un’insenatura del mare.
Un’ambivalenza supportata anche dalla presenza delle vele che lo solcano come potrebbero solcare il mare Ligure, tanto dipinto dall’artista, se non fosse che sulla lingua di terra in lontananza non si vedono i terrazzamenti che strappano terra da coltivare alle curve di livello ma rocce brulle e piramidi.
A dare un carattere più personale e meno generico all’opera, rendendola secondo noi più interessante delle “cartoline”, che veramente sono tali, di Corrodi, oltre alla pennellata più sfatta e meno puntualmente descrittiva, sono l’inserimento dell’abbeverata del bue che scende in acqua assieme alle donne e, soprattutto, la bambinetta in bianco, con la cresta di capelli crespi su una testa rasata come quella dei ragazzi di oggi, ritratta di profilo in primo piano sul margine inferiore del dipinto.
Si fa ancora più vago e “disordinato” il segno del piccolo Mercato arabo/Bazar di verdure che della realtà non ci offre più una riproduzione didascalica ma l’impressione costruita dalle macchie di colore delle singole pennellate che la compongono. Che possono da sole dipingere un volto privo di lineamenti, un arto, un copricapo… Che possa essere stato ancora l’Egitto ad ispirarlo lo deduciamo dalla biografia del suo autore Uberto dell’Orto (Milano, 6 gennaio 1848 – Milano, 29 novembre 1895).
Nato in un’agiata famiglia borghese resta presto orfano di entrambi i genitori e viene cresciuto dagli zii materni, insieme al fratello Enrico.
Riesce bene negli studi che corona con la laurea in ingegneria conseguita nel 1871 all’università di Bologna.
Nel frattempo però, i ripetuti soggiorni nell’idilliaca quiete della Bergamasca durante le vacanze estive gli ispirano il gusto per il paesaggio e lo appassionano al disegno di scorci rurali o elementi naturali come foglie, tronchi, acque, paesaggi, spesso riportati in timide gradazioni chiaroscurali.
Decide allora di assecondare questa inclinazione tornando alla scuola del suo docente al Ginnasio di Brera Giovanni Battista Lelli (Milano, 21 giugno 1827 - 13 aprile 1887) patriota nelle file Garibaldine e tra i primi “paesisti” milanesi a dare centralità al metodo di lavoro en plein air, a contatto diretto con i soggetti, e ad adottare un metodo d’insegnamento che prevedeva lunghi soggiorni estivi in zone montane o collinari.
Prosegue la sua formazione con Eleuterio Pagliano (anch’egli rappresentato con una sua opera ai Civici di Monza), come Pompeo Mariani, ed all’Accademia di Brera e nel 1880 apre uno studio artistico a Milano alternando il lavoro in studio a lunghi viaggi in località marine o montane di cui dipinge i paesaggi naturali, con una maggiore predilezione per i secondi.
Desideroso di trasporre in questi i colori vivaci e sgargianti del Mediterraneo si recò in Sicilia, a Napoli ed all’isola di Capri, spingendosi fino in Egitto nel 1881. Nell'occasione in compagnia di Mosè Bianchi e del pittore impressionista Sallustio Fornara (Milano, 9 dicembre 1852 - Cernobbio, Como, 17 luglio 1922).
 Abbandonati i connotati bozzettistici, la sua pittura ormai presenta una «robustezza compositiva» ed una «raffinatezza cromatica» grazie alle quali, come si è detto a proposito del suo Mercato arabo, si discosta dalla fedele riproduzione del paesaggio, preferendo che la tela restituisca a chi la guarda le sensazioni e le emozioni che l’osservazione del paesaggio aveva generato nell’artista. Pur tenendosi a distanza da Impressionisti e Divisionisti, il suo stile contiene «vibrazioni luminose» con le quali «semplifica i volumi e riduce moltissimo gli effetti chiaroscurali». Per queste ragioni Dell’Orto è a buon diritto ricordato come uno dei maggiori rappresentanti del Naturalismo lombardo del secondo Ottocento che, a partire da Mosè Bianchi, costituirono una corrente moderatamente ma autenticamente verista che andò ad affiancarsi, seppure in tono minore sul piano della qualità artistica, alle contemporanee esperienze napoletane e toscane» (Alessandra Pino Adami). E si capisce perché la sua pittura gli valse successo e riconoscimenti internazionali. Un anno dopo la sua morte alla Permanente si raccolsero 154 suoi dipinti di illustre proprietà come Vittorio Emanuele II, il ministero della pubblica istruzione e famiglie aristocratiche lombarde.
Abbandonati i connotati bozzettistici, la sua pittura ormai presenta una «robustezza compositiva» ed una «raffinatezza cromatica» grazie alle quali, come si è detto a proposito del suo Mercato arabo, si discosta dalla fedele riproduzione del paesaggio, preferendo che la tela restituisca a chi la guarda le sensazioni e le emozioni che l’osservazione del paesaggio aveva generato nell’artista. Pur tenendosi a distanza da Impressionisti e Divisionisti, il suo stile contiene «vibrazioni luminose» con le quali «semplifica i volumi e riduce moltissimo gli effetti chiaroscurali». Per queste ragioni Dell’Orto è a buon diritto ricordato come uno dei maggiori rappresentanti del Naturalismo lombardo del secondo Ottocento che, a partire da Mosè Bianchi, costituirono una corrente moderatamente ma autenticamente verista che andò ad affiancarsi, seppure in tono minore sul piano della qualità artistica, alle contemporanee esperienze napoletane e toscane» (Alessandra Pino Adami). E si capisce perché la sua pittura gli valse successo e riconoscimenti internazionali. Un anno dopo la sua morte alla Permanente si raccolsero 154 suoi dipinti di illustre proprietà come Vittorio Emanuele II, il ministero della pubblica istruzione e famiglie aristocratiche lombarde.
 Dal mercato “Egiziano” di Dell’Orto si scende al Mercato di Gerusalemme di Giuseppe Gheduzzi (Crespellano, Bologna, 12 maggio 1889 – Torino, 21 maggio 1957). C’è movimento sulla sua scalinata, ogni figura con mantello, presentata di spalle, è una macchia di colore. L’arabo che ci guarda in faccia, invece, la discende sollevandosi la veste per non inciampare come le conduttrici del Festival di Sanremo.
Dal mercato “Egiziano” di Dell’Orto si scende al Mercato di Gerusalemme di Giuseppe Gheduzzi (Crespellano, Bologna, 12 maggio 1889 – Torino, 21 maggio 1957). C’è movimento sulla sua scalinata, ogni figura con mantello, presentata di spalle, è una macchia di colore. L’arabo che ci guarda in faccia, invece, la discende sollevandosi la veste per non inciampare come le conduttrici del Festival di Sanremo.
È la fresca visione orientalista che fece la fortuna di questo pittore che, primogenito di una famiglia di artisti, si reca giovanissimo a Torino col padre Ugo e con lui, assieme ai fratelli Cesare, Mario e Augusto, lavora alla realizzazione di scenografie per il Teatro Regio prima di dedicarsi alla pittura, arte in cui si distinguerà come originale paesista che ebbe come acquirente anche la Casa Reale di Savoia.
 Tragica, ed emblematicamente rappresentata dalla sua opera più conosciuta - ed anch'essa ambientata in Egitto, seppure antico e per questo non ascrivibile all'orientalismo - Il sacrificio della Vergine al Nilo, del 1865, (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna), è stata invece la vita di Federico Faruffini (Sesto San Giovanni, 1833 – Perugia, 1869) che più volte tentò il suicidio fino a riuscire nell’intento al terzo tentativo.
Tragica, ed emblematicamente rappresentata dalla sua opera più conosciuta - ed anch'essa ambientata in Egitto, seppure antico e per questo non ascrivibile all'orientalismo - Il sacrificio della Vergine al Nilo, del 1865, (Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna), è stata invece la vita di Federico Faruffini (Sesto San Giovanni, 1833 – Perugia, 1869) che più volte tentò il suicidio fino a riuscire nell’intento al terzo tentativo.
Amico di Tranquillo Cremona (Pavia, 10 aprile 1837 – Milano, 10 giugno 1878), iniziatore della Scapigliatura in pittura, è proprio ai modi degli Scapigliati lombardi che la sua opera traghetta la pittura lombarda a partire dalla ricchezza cromatica del Piccio, Giovanni Carnovali (Montegrino Valtravaglia, Varese, 29 settembre 1804 – Coltaro, Parma, 5 luglio 1873) dal quale fu influenzato in avvio di carriera.
Recatosi a Roma nel 1856 vi rimase fino all’inizio del 1858, richiamato al nord dalla prima commissione ufficiale: la pala con l’Immacolata Concezione per il Duomo di Pavia. Interessato a soggetti storici, religiosi o tratti dai romanzi, nei suoi dipinti di questi anni gli storici dell’arte riconoscono nuovi colori ed un’originale impostazione compositiva, che vengono attribuite al contatto avvenuto a Roma con Domenico Morelli, che già abbiamo visto aver lasciato il suo segno in diversi degli orientalisti in mostra.
 Possiamo provare a vedere queste ascendenze anche noi nelle dorate screziature sericee del suo Costume turco, datato all’incirca al 1859 e quindi proprio di questo periodo.
Possiamo provare a vedere queste ascendenze anche noi nelle dorate screziature sericee del suo Costume turco, datato all’incirca al 1859 e quindi proprio di questo periodo.
Un dipinto nel cui titolo si nasconde (o si manifesta) la verità di ciò che vediamo. Non ci troviamo più l’intento documentaristico di Pasini perché il vestito del personaggio che lo indossa, e ci volta le spalle perché possiamo ammirarne meglio il tessuto, non è un abito orientale originale - Faruffini non è mai stato in oriente - ma, ancora una volta, l’idea che se ne ha in Europa. In questa occasione mediata dai costumi di scena delle opere liriche. Un ruolo nel quale ebbe molta importanza il teatro alla Scala di Milano dove si rappresentavano melodrammi tragici o opere buffe con ambientazioni esotiche come le rossiniane Semiramide e L’Italiana in Algeri. Questa per di più ispirata da una vicenda vera: la storia di Antonietta Frapolli, signora milanese rapita dai corsari nel 1805, portata nell’harem del Bey di Algeri Mustafà-ibn-Ibrahim e poi ritornata in Italia.
Ultima annotazione sul dipinto, a vederlo, essendo a conoscenza della fine dell’artista, ha su di noi l’effetto di un lugubre presagio il severo monogramma che Faruffini usa come firma, accostando in direzioni opposte le sue iniziali, e che notiamo in evidenza sulla striscia gialla di muro che delimita il lato destro del dipinto, nello stesso colore delle calzature e delle decorazioni longitudinali del vestito.
 Ancora a Morelli, davvero un caposcuola, almeno per gli artisti presentati in questa mostra, guarda Ernesto Giroux (Napoli 1851-1888) che del colore fa lo stesso uso del maestro napoletano.
Ancora a Morelli, davvero un caposcuola, almeno per gli artisti presentati in questa mostra, guarda Ernesto Giroux (Napoli 1851-1888) che del colore fa lo stesso uso del maestro napoletano.
Noi possiamo vederlo in La vendita del cavallo, del 1882, vivace scenetta in cui tre adulti osservano l’animale bardato e sellato a festa per fare una migliore figura con l’acquirente.
Che però dimostra di non lasciarsi confondere le idee dalla messa in scena e si inginocchia fino a terra per esaminarne con attenzione le caratteristiche. È presente anche un ragazzino, in piedi ma che si piega in due per partecipare alla trattativa curioso dei commenti degli adulti. Rispetto ai quali ha il berretto di foggia un po’ diversa, chissà se per una consuetudine legata all’età o solo per il gusto del pittore di mostrarcene diverse tipologie. Perché, nell’insieme, con Giroux ci sembra di ritrovare uno stile che si avvicina all’interesse descrittivo che abbiamo conosciuto in Pasini.
Ambientazione ed intenti molto diversi rispetto al quadro che gli è accostato, Morettine fabbricanti di tappeti, di Leonardo Bazzaro (Milano, 13 dicembre 1853 – 2 novembre 1937), fratello maggiore dello scultore Ernesto incontrato in apertura con il bronzo In Carovana. Ma anche Leonardo non ci è sconosciuto. In una precedente occasione, sempre la GAM Manzoni ne aveva esposte le Baite abbandonate, segnate sulla tela con pesanti spatolate di colore (Anima Bianca, leggi di più >>>).
Dimostrando già in gioventù una spiccata passione e propensione per il disegno e le arti figurative, in questa sua naturale inclinazione Leonardo Bazzaro viene assecondato dai genitori, appassionati d’arte, che lo affidano alle lezioni private del pittore Gaetano Fasanotti, loro cliente e titolare della cattedra di paesaggio all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove anche lui infine entrerà, nonostante la famiglia avesse desiderato avviarlo ad attività commerciali.
Allievo poi di Giuseppe Bertini (benemerito curatore di Brera e del Poldi Pezzoli), sceglie come modelli Giuseppe Bisi e Giovanni Migliara e si specializza nella pittura di interni e palazzi del ‘700, nei quali dimostra soluzioni autonome nell’uso della luce, del colore e nelle vedute prospettiche, con una pennellata veloce ed irrequieta ma alla quale non mancava la tecnica. Fatto che gli valse il soprannome “Il piccolo Velazquez” attribuitogli dai colleghi.
Dopo il debutto pubblico nel 1873, il dipinto “Dopo il duello”, del 1875, gli vale il “Premio Fumagalli” e, soprattutto, l’interesse della Goupil & Cie che gli commissiona parecchie opere. Un legame che, come abbiamo visto, ha fatto la fortuna di molti ma che Leonardo Bazzaro rompe nel 1878: il suo amore per la montagna e la riviera di Chioggia nella laguna di Venezia lo inducono ad abbandonare la pittura di interni ed a dedicarsi completamente al paesaggio dipinto dal vero all’aria aperta.
Per farlo al meglio, dal 1894 si trasferisce a vivere nel Verbano: ad Alpino, sulle pendici del Mottarone, dove soggiornerà per oltre quarant’anni con la moglie Corona Douglas Scotti dipingendone la vita popolare in toni sempre più personali. Il successo di critica e pubblico che ottiene in Italia ed all’estero lo fa entrare a pieno titolo nel novero dei più importanti rappresentanti della “scuola naturalistica” lombarda accanto a nomi come Uberto Dell’Orto, Filippo Carcano ed Eugenio Gignous.
 In questa pur essenziale panoramica biografica abbiamo qualche difficoltà a collocare l’opera in mostra dalla cornice piatta e decorata. Forse il soggetto, non consueto fra i temi degli Orientalisti, almeno per quanto ne abbiamo potuto conoscere in mostra, denota la sua particolare sensibilità per i temi sociali, in questo caso riferiti al lavoro dei bambini: problema attuale anche in occidente e che Bazzaro trasla in altro contesto. Un’altra ipotesi per la scelta può essere messa in relazione col fatto che, nel 1891, nel cortile principale del Castello Sforzesco di Milano, si era svolta un’esposizione egiziana costituita da quadri viventi con la presenza di beduini ed animali esotici. Un avvenimento che non poteva lasciare indifferenti gli artisti.
In questa pur essenziale panoramica biografica abbiamo qualche difficoltà a collocare l’opera in mostra dalla cornice piatta e decorata. Forse il soggetto, non consueto fra i temi degli Orientalisti, almeno per quanto ne abbiamo potuto conoscere in mostra, denota la sua particolare sensibilità per i temi sociali, in questo caso riferiti al lavoro dei bambini: problema attuale anche in occidente e che Bazzaro trasla in altro contesto. Un’altra ipotesi per la scelta può essere messa in relazione col fatto che, nel 1891, nel cortile principale del Castello Sforzesco di Milano, si era svolta un’esposizione egiziana costituita da quadri viventi con la presenza di beduini ed animali esotici. Un avvenimento che non poteva lasciare indifferenti gli artisti.
L’ultimo quadro pienamente orientalista in mostra è di Eugenio Cecconi (Livorno, 8 settembre 1842 – Firenze 19 dicembre 1903), del quale conviene scorrere, pur sinteticamente, la ricca biografia prima di prenderlo in considerazione.
Dopo gli studi nel Collegio nazionale di Torino, nel 1858 torna a Livorno in tempo per assistere ai preparativi dei patrioti livornesi per la seconda guerra di indipendenza (combattuta contro l’Austria dal Regno di Sardegna alleato con la Francia dal 27 aprile 1859 al 12 luglio 1859) fra i quali è suo padre, fervente patriota.
Contemporaneamente agli studi giuridici, ed alla pratica legale successiva alla laurea in legge conseguita a Pisa, studia pittura di paesaggio, privatamente e frequentanto l’Accademia di belle arti di Firenze, finché, nel 1866, anno successivo alla morte del padre, si arruola volontario con i bersaglieri del generale Cialdini, ma non è coinvolto nelle operazioni militari (la Terza guerra di indipendenza italiana combattuta dal Regno d’Italia contro l’Impero austriaco dal 20 giugno 1866 al 12 agosto 1866 nell’ambito della più ampia guerra austro-prussiana della quale rappresentò il fronte meridionale).
Finita la guerra abbandona la professione legale per dedicarsi a tempo pieno alla pittura e, con l’amico Adolfo Belimbau (Il Cairo, 1845 - Firenze, 1938) apre uno studio a Livorno prediligendo le ambientazioni paesaggistiche delle campagne pisane e di Castiglioncello: il ritrovo dei Macchiaioli livornesi, rappresentati al meglio da Giovanni Fattori (Livorno, 6 settembre 1825 – Firenze 30 agosto 1908) e Serafino De Tivoli (Livorno, 22 febbraio 1825 – Firenze, 1 novembre 1892) alla cui cerchia si avvicina incominciando a frequentare il critico d’arte Diego Martelli (Firenze, 29 ottobre 1839 – 20 novembre 1896): tra i primi sostenitori in Italia del realismo francese che sostenne ed unì i Macchiaioli ospitandoli nella sua tenuta di Castiglioncello.
Qui conobbe, tra gli altri, Giovanni Boldini, per il quale posò per un ritratto, ed il pittore e patriota Giuseppe Abbati, al quale lo legò una breve ma fruttuosa amicizia.
In questo ambiente si compie la sua vera formazione artistica: libero da regole accademiche, dedito soprattutto allo studio dal vero, a diretto contatto con la natura, condivide con Fattori (ritratto in Fattori che dipinge) l’amore per la Maremma toscana, specializzandosi nel ritrarre animali e scene venatorie (ai Musei Civici di Monza c’è Mancante all’appello, antecedente il 1883: un insolito cane da caccia morto in riva ad un corso d'acqua - foto sopra in cornice dorata), assecondando in ciò la propria passione per la caccia: un hobby che gli ispirerà i quadri migliori, espressione di un garbato realismo e suo soggetto più ambito dal collezionismo che lo segue con interesse. La sua capacità di rendere con immediatezza e vivacità gli atteggiamenti degli animali, in corsa o nell’atto di balzare sulla preda, è una dote molto lodata che anche l’amico Telemaco Signorini (Firenze, 18 agosto 1835 – 10 febbraio 1901) gli riconobbe.
Tralasciando gli ulteriori trasferimenti e l’intensa attività espositiva, è doverosa una citazione per le Cenciaiole livornesi del 1880 (esposte al Museo Fattori di Livorno), una delle sue opere più note e rappresentativa dei suoi ritratti di donne lavoratrici in cui il suo realismo raggiunge la qualità più elevata, e per il programmatico Sola natura ispiratrice è all’arte, affresco dipinto a Camugliano (Ponsacco) per il marchese Eugenio Niccolini, uno di coloro che ne ospitavano i lunghi periodi trascorsi in Maremma.
Inoltre è giusto ricordare che la sua natura poliedrica lo portò a dedicarsi anche ad altro: critica d’arte per la stampa nazionale ed estera, insegnamento della pittura per signorine, scrittura di racconti… fino all’organizzazione di una apprezzatissima mostra ornitologica ed alla traduzione, non pubblicata, del Cyrano de Bergerac e dei Romanesques di Edmond Rostand.
Rilevante, ai fini di quanto qui più ci interessa, è invece il viaggio che Cecconi fece in Tunisia nel luglio del 1875, accompagnato dall’amico di sempre Adolfo Belimbau. L’esperienza segnò una svolta importante nella sua formazione e di essa il pittore fece tesoro nei quadri ad essa successivi, caratterizzati da colori accesi e da uno studio più meditato della luce. Lo dimostrano Cortile di Rab-el-afrit, esposto nel 1878 a Brera ed alla Promotrice di Torino, e molti altri titoli con scorci urbani e paesaggi naturali di Tunisi e della Tunisia, scene di vita quotidiana e figure orientali… come la nostra Scena orientale del 1875, nella quale rivediamo i luoghi di Italo Vas Nunes in un riassunto di quel che Cecconi ha visto e riportato dal viaggio. Filtrato dal suo sguardo di persona di buona cultura e schiva della notorietà, che ci ha lasciato di sé il ricordo di un garbato uomo di spirito, affabile e pieno di una serena gioia di vivere.
 La stessa che dimostrano i personaggi del dipinto: gruppetti di arabi sonnolenti che sfuggono al sole del meriggio riparandosi a prendere il fresco all’ombra degli alberi che circondano un pozzo a leva attorno al quale si radunano, seduti o sdraiati sulle stuoie che ricoprono tutti i muretti che li accolgono, a conversare, bere un bicchiere, che in Toscana sarebbe di vino ma qui, con i divieti locali, non ci azzardiamo ad ipotizzare, o inginocchiati in preghiera sul proprio mantello.
La stessa che dimostrano i personaggi del dipinto: gruppetti di arabi sonnolenti che sfuggono al sole del meriggio riparandosi a prendere il fresco all’ombra degli alberi che circondano un pozzo a leva attorno al quale si radunano, seduti o sdraiati sulle stuoie che ricoprono tutti i muretti che li accolgono, a conversare, bere un bicchiere, che in Toscana sarebbe di vino ma qui, con i divieti locali, non ci azzardiamo ad ipotizzare, o inginocchiati in preghiera sul proprio mantello.
Per movimentare la scena il pittore introduce un dromedario in arrivo da dietro il pozzo ed un uomo con la pipa che risale la scaletta proveniendo da un piano interrato.
Quello che però più colpisce e sorprende, soprattutto chi più di noi ha negli occhi la pittura di macchia, alla quale si è visto che Cecconi appartiene in pieno, sono gli alberi: dipinti con la tecnica dei macchiaioli.
Siamo di nuovo in un ambiente orientale, in un luogo analogo a quello delle Sorgenti di acqua dolce a Istambul di Pasini, ma quelle che lo ombreggiano sembrano essere in tutto e per tutto piante del paesaggio toscano!
APPENDICE
 Seppure inserito nel percorso espositivo alla sezione riservata alle Odalische, espressamente abbiamo scelto di collocare in Appendice Cesare Tiratelli (Roma 1864 – 1933). Allievo del padre Aurelio, sull’esempio del quale si dedicò alla pittura di paesaggio affiancata da quadri di genere, anche in costume settecentesco, ebbe un’attività espositiva quasi esclusivamente romana.
Seppure inserito nel percorso espositivo alla sezione riservata alle Odalische, espressamente abbiamo scelto di collocare in Appendice Cesare Tiratelli (Roma 1864 – 1933). Allievo del padre Aurelio, sull’esempio del quale si dedicò alla pittura di paesaggio affiancata da quadri di genere, anche in costume settecentesco, ebbe un’attività espositiva quasi esclusivamente romana.
Il suo acquerello Al ballo in maschera, del 1888, è un bel dipinto sul quale si nota la sua firma dalla calligrafia ricercata, ma che tuttavia ci pare (e non solo a noi) fuori contesto. La protagonista, mascherata da Geisha giapponese, a complemento del travestimento ha in mano uno shamisen, liuto giapponese a tre corde che abbiamo conosciuto in una stampa di Utamaro (leggi di più >>>).
Il titolo, a prima vista non subito giustificato, è anch’esso, in un certo senso mascherato e lo si comprende da un piccolo dettaglio dipinto dietro il grande vaso che anch’esso reca disegni giapponesi e dal quale escono grandi foglie di palma: dietro una tenda, solo un poco scostata, si intravede una sala da ballo con alcuni personaggi vestiti all’occidentale ma con la mascherina nera sul viso.
Nel complesso, comunque, più che afferibile all’orientalismo, questo acquerello è rappresentativo del gusto europeo esotico della Belle Epoque, che ritroviamo nelle boiseries e negli arredi delle case borghesi.