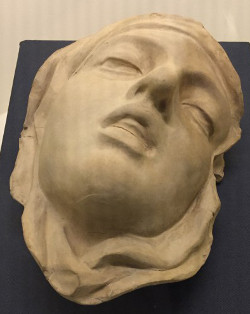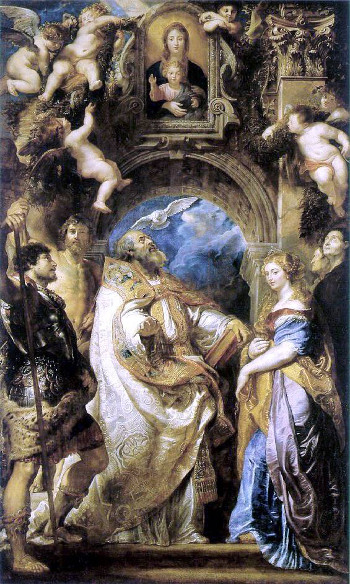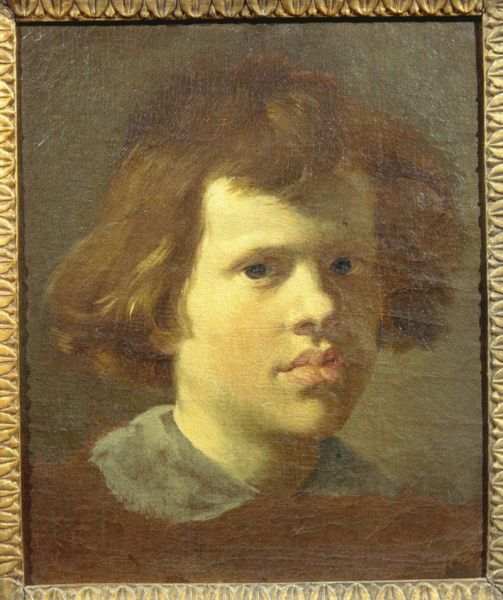L'Eclettico
Rubens, l'Italiano
L'ECLETTICO - web "aperiodico"
RUBENS, L'ITALIANO
L'Italia che fece di un giovane pittore fiammingo "Rubens", e l'eredità da lui lasciata agli Italiani dei primi decenni del Seicento
L’artista? Come minimo uno scapestrato dalla vita tormentata. Questa è l’idea romantica che per lo più ne abbiamo oggi. Restando fermi a questo stereotipo, allora, il pittore fiammingo Pieter Paul Rubens (Siegen, Germania, 28 giugno 1577 - Anversa, 30 maggio 1640) artista non dovrebbe proprio essere.
Ed invece, forse proprio perché era un “brav’uomo”, affezionato alla sua famiglia e bravo padre, colto (parlava cinque lingue) e con un fratello filosofo che lo accompagnò nella sua discesa in Italia (il 9 giugno del 1600 quando il pittore aveva poco più di 23 anni), di Rubens si può a buon diritto dire che fu il primo vero artista in senso pieno e qualcuno, con felice paragone, l’ha definito “il Bach della pittura”.
Paragone centrato anche per quanto riguarda la sterminata produzione artistica, visto che il catalogo di Rubens conta circa 1.000 opere, con la precisazione che tutte quelle precedenti il 1609 sono esclusivamente sue mentre in quelle successive intervengono anche aiuti, perché la sua fama gli fruttava moltissime commissioni alle quali non poteva fare fronte da solo.
IL MONDO DI RUBENS
 È questo, dunque, l’uomo che ci accoglie all’ingresso della mostra che Palazzo Reale di Milano gli ha dedicato (Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco): vestito con eleganza, severo e con una catena d’oro al collo (quindi anche ricco, cosa che sembra non gli dispiaccia dare a vedere) nel suo autoritratto proveniente dagli Uffizi in cui, come sempre quando raffigura sé stesso, si compiace di presentarsi come un gentiluomo. Giovan Pietro Bellori (Roma, 1613 - 1696), storico dell’arte ed uno dei più importanti biografi degli artisti del Barocco Italiano nel XVII secolo (considerato il corrispondente in epoca barocca di Giorgio Vasari) nel suo “Vite de’ pittori, scultori e architecti moderni” del 1672 scrisse di Rubens: «Era maestoso insieme ed umano, e nobile di maniere e d’abiti».
È questo, dunque, l’uomo che ci accoglie all’ingresso della mostra che Palazzo Reale di Milano gli ha dedicato (Pietro Paolo Rubens e la nascita del Barocco): vestito con eleganza, severo e con una catena d’oro al collo (quindi anche ricco, cosa che sembra non gli dispiaccia dare a vedere) nel suo autoritratto proveniente dagli Uffizi in cui, come sempre quando raffigura sé stesso, si compiace di presentarsi come un gentiluomo. Giovan Pietro Bellori (Roma, 1613 - 1696), storico dell’arte ed uno dei più importanti biografi degli artisti del Barocco Italiano nel XVII secolo (considerato il corrispondente in epoca barocca di Giorgio Vasari) nel suo “Vite de’ pittori, scultori e architecti moderni” del 1672 scrisse di Rubens: «Era maestoso insieme ed umano, e nobile di maniere e d’abiti».
Definizione che ne mette in luce una grandezza d’animo non inferiore a quella dell’artista. La statura morale di Rubens e la sua saggezza, sottolineate da Bellori in vari passi della biografia, si uniscono all’elogio delle sue doti di intellettuale colto, ma anche di gentiluomo dai «modi gravi e accorti», giustificando così la scelta di includere nelle Vite quella del fiammingo, “la cui pittura concitata e barocca era lontana dal gusto classicista belloriano, permeato sul concetto del bello ideale”.
La circostanza curiosamente si ripete un paio di secoli dopo, a fine Ottocento, con l’intensa biografia letteraria dello storico svizzero Jacob Burckhardt (1818-1897) pubblicata nel 1896, a solo un anno dalla sua morte. Egli, infatti, usava parole analoghe ricordando come Rubens: «Fu anche una natura radiosa, che già con la sua presenza suscitava fiducia e concordia».
Anche per Burckhardt la formazione su un’estetica classicista e sul mito di Raffaello sembra in contrasto con l’interesse che lo porta a seguire Rubens in tutta la sua vita e nelle sue opere, di cui ammira enormemente la «gigantesca fantasia», restando progressivamente incantato dalle innumerevoli doti dell’artista, che lo conquista proprio con l’armonia che sembra accompagnare ogni sua manifestazione del dipingere e del vivere.
Lo affiancano, in ritratto, altri familiari. La prima moglie, Isabelle Brant (1521 - 1626), che dipinge nel 1626, poco dopo la sua morte (nel luglio di quell'anno), accompagnandone la figura con elementi simbolici. Fra questi riconosciamo il fazzoletto fra le dita, ad indicare la morigeratezza della defunta, ed il tralcio di vite attorcigliato attorno alla colonna: simbolo di amicizia ed amore oltre la morte.
Attestazione che non impedirà a Rubens, nel 1630, di sposare, a 53 anni, una sedicenne: Helena Fourment (1614 - 1673) che a sua volta sarà protagonista di altri suoi successivi dipinti.
 Con Isabelle, Rubens ebbe una figlia, Clara Serena, che ritrae, nel 1616, all’età di 5 anni. L’interesse dell’artista in questo piccolo esemplare è tutto per l’espressione sorridente del suo viso: incorniciato dai capelli scapigliati e vibrante di piccoli tocchi di colore a sottolinearne l’espressione giocosa e tenera; nelle labbra appena chiuse e nello sguardo vivace delle pupille guizzanti. Non è un caso che il vestito non sia finito e sia reso con due tratti di bianco del colletto. Si capisce che è un ritratto dipinto con amore, nel quale, ciò che davvero conta, è trasmettere l’intensità della carica affettiva e l’attaccamento alla famiglia. È il tentativo di riprodurre sulla tela l’espressione di uno stato d’animo che possa rendere chi lo guarda partecipe di momenti d’intimità domestica: l’intento di comunicare gli affetti proprio del linguaggio barocco.
Con Isabelle, Rubens ebbe una figlia, Clara Serena, che ritrae, nel 1616, all’età di 5 anni. L’interesse dell’artista in questo piccolo esemplare è tutto per l’espressione sorridente del suo viso: incorniciato dai capelli scapigliati e vibrante di piccoli tocchi di colore a sottolinearne l’espressione giocosa e tenera; nelle labbra appena chiuse e nello sguardo vivace delle pupille guizzanti. Non è un caso che il vestito non sia finito e sia reso con due tratti di bianco del colletto. Si capisce che è un ritratto dipinto con amore, nel quale, ciò che davvero conta, è trasmettere l’intensità della carica affettiva e l’attaccamento alla famiglia. È il tentativo di riprodurre sulla tela l’espressione di uno stato d’animo che possa rendere chi lo guarda partecipe di momenti d’intimità domestica: l’intento di comunicare gli affetti proprio del linguaggio barocco.
Si è scritto che il ritratto della figlia Clara Serena può essere una delle chiavi privilegiate per entrare nel mondo di Rubens e questi ritratti di madre e figlia fanno infatti pensare ad opere che l’artista dipinge per sé, quasi una parentesi privata rispetto all’ufficialità del resto della sua produzione.
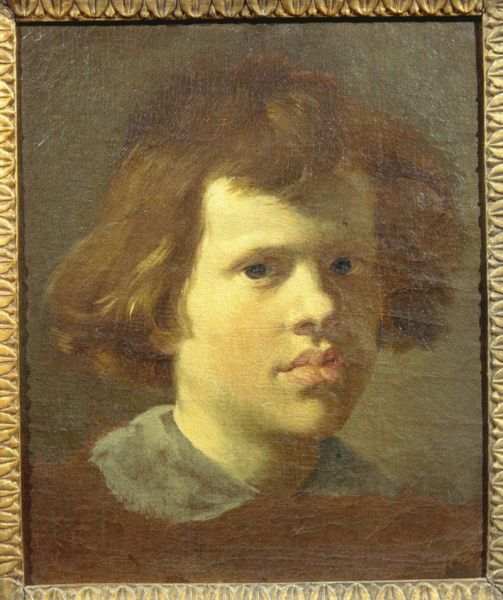 Poiché caratteristica peculiare di questa mostra milanese non è tanto il proporre un catalogo rubensiano, quanto documentare l’influsso ed il contributo dell’artista all’arte pittorica italiana, lo sguardo appena osservato lo ritroviamo nel Ritratto di bambino, di circa dieci anni più tardo (è del 1623) di Gian Lorenzo Bernini (Napoli, 7 dicembre 1598 - Roma, 28 novembre 1680), uno dei giovani della generazione che elesse Rubens a proprio modello.
Poiché caratteristica peculiare di questa mostra milanese non è tanto il proporre un catalogo rubensiano, quanto documentare l’influsso ed il contributo dell’artista all’arte pittorica italiana, lo sguardo appena osservato lo ritroviamo nel Ritratto di bambino, di circa dieci anni più tardo (è del 1623) di Gian Lorenzo Bernini (Napoli, 7 dicembre 1598 - Roma, 28 novembre 1680), uno dei giovani della generazione che elesse Rubens a proprio modello.
Come molti di questi, anche Bernini aveva conosciuto Rubens attraverso le celeberrime committenze in Roma: le pale della chiesa di Santa Croce in Gerusalemme e quelle più rivoluzionarie della chiesa di Santa Maria in Vallicella. E sebbene, con tutta probabilità, non avesse visto il Ritratto di Clara Serena, gli storici dell’arte osservano che “da tempo aveva iniziato a guardare al fiammingo con crescente interesse ed a condividere e riprendere il senso dinamico delle sue rappresentazioni, evidente in tutta la produzione degli anni venti, già a partire dalle grandi sculture realizzate per Scipione Borghese”.
L’accostamento fra questi due piccoli ritratti di formato quasi uguale è stato proposto da Tomaso Montanari, che riconosce in quello di Bernini, conservato alla Galleria Borghese, anch’esso non finito ed improntato a una simile intensità di espressione, il medesimo desiderio di ritrarre uno stato d’animo: giocoso per Clara Serena e qui più melanconico; entrambi tuttavia rappresentativi di un’idea informale della teoria degli affetti. La tela vuole infatti esprimere “una sfumatura particolare, un attimo fuggente di un’attitudine, in maniera non così diversa dallo studio della natura nel suo quotidiano mutare”.
Anna Lo Bianco, curatrice della mostra, vi scorge “un’affinità con i paesaggi dipinti da Elsheimer, amico fraterno di Rubens e da lui stimatissimo, che si concentra nel cogliere ogni trascolorare delle ombre e delle luci, nel corso delle ore mai identiche – così come i sentimenti che variano sui volti dei bambini – assimilando quasi tra loro i due generi, paesaggio e ritratto, entrambi peraltro destinati a raffigurare il mondo della natura. Entrambi espressione di quel panta rei che nella raffigurazione di Eraclito mostra tutta la sua suggestione sull’artista”.
RUBENS “L’ITALIANO”
“Il lungo ed ininterrotto soggiorno italiano di Rubens avviene all’inizio della sua vita d’artista e realizza pienamente le aspettative con le quali egli si era messo in viaggio. I suoi studi sul mondo classico, nella cerchia di cultori dell’antico, la pratica della letteratura, della filosofia, della lingua italiana e del latino lo avevano spinto infatti ad approfondire la conoscenza dell’arte del Rinascimento, con la quale desiderava finalmente incontrarsi”. Ed in Italia arriva proprio nel 1600, anno giubilare, “quando le novità in campo artistico sono più dense e stimolanti, come quelle proposte da pittori quali Caravaggio e Annibale Carracci, attivi in grandi committenze ufficiali, in un fiorire di nuovo mecenatismo”.
Nella sua prima sosta a Venezia - oltre al contatto dal vero con la grande pittura di Tiziano e Tintoretto studiata ad Anversa - Rubens ha l’opportunità di incontrare il segretario del marchese Vincenzo I Gonzaga che, alla ricerca di un pittore da ingaggiare per la corte di Mantova, lo porta al servizio di questa nobile dinastia, incarico che manterrà fino alla sua partenza, nel 1608, affiancandolo a molti altri, come le missioni diplomatiche in Italia e Spagna, grazie alle quali arricchirà la sua formazione e la sua maturazione artistica.
Alla fortuna occorsagli Rubens aggiunge di suo una “straordinaria capacità di intrattenere rapporti interpersonali, dalla quale emergono la sua statura morale, la benevolenza del carattere e la vocazione diplomatica”, qualità umane particolarmente apprezzate dai Gonzaga e da tutti i committenti per i quali lavorerà.
l’Italia è stata dunque di fondamentale importanza nella crescita artistica di Rubens rispondendo positivamente a quel che si aspettava dall’incontro con una tradizione alla quale la forza della sua invenzione si sarebbe ispirata. “L’influsso sulla creatività di Rubens dell’arte italiana e del mondo classico, a partire dai quali egli costruisce un vero e proprio patrimonio di idee dal quale attingere per tutta la sua futura attività artistica è documentato dalle sue numerose lettere, fonti imprescindibili di prima mano, e dai molti disegni dall’antico - risalenti soprattutto agli anni romani, 1605-1606, e ben identificabili - dai quali emerge l’idea di un mondo classico vibrante e pieno di vita”.
In mostra, oltre a dipinti a lui antecedenti, sono perciò presenti anche esemplari di statuaria classica che sappiamo essere stati conosciuti da Rubens affiancati dai dipinti che dimostrano come ad essi egli si sia liberamente ispirato.
Tutto quanto si è fin qui descritto definisce il versante “italiano” della maniera di Rubens, tanto sensibile ai grandi modelli italiani del passato da arrivare a “copiare”, sebbene sempre alla sua maniera, celeberrimi prototipi di Tiziano, Parmigianino e Correggio.
Attitudine quest’ultima che ne ha senza dubbio facilitato l’immediata affermazione presso i suoi primi committenti.
In una ben conosciuta lettera del 23 febbraio 1608, padre Flaminio Ricci, nobile di Fermo entrato nella congregazione dei Padri Oratoriani (che dopo la morte del suo fondatore prenderà il nome di San Filippo), definisce Rubens «fiammingo, ma da putto allevato a Roma».
E se oltre trecento anni dopo, nel 1957, Bernard Berenson scrive di lui che «è un italiano» significa che il radicamento di Rubens nell’arte italiana è pienamente riconosciuto. Cosa che non avviene, ad esempio, per altre importanti personalità, come van Dyck o Velázquez, per citare solo gli artisti a lui più vicini per cronologia e per fama che anch’essi vivranno e lavoreranno in Italia, il primo anche a lungo, seppure non quanto Rubens.
Ciononostante, nella percezione generale che si ha in Italia di questo artista, il suo ruolo nelle vicende delle arti figurative italiane è sottovalutato: “pressoché assente dai manuali di storia dell’arte – spesso anche dai testi specifici sul secolo XVII – è quasi sempre incluso nella generica voce «fiamminghi» e nelle mostre le sue opere sono per lo più accostate a quelle dei pittori fiamminghi del Seicento, il secolo d’oro di questa scuola che annovera artisti importanti come van Dyck, Jordaens, Brueghel, Seghers e altri dei quali è proposto come il caposcuola”.
Viceversa non si può negare che Rubens sia stato altrettanto determinante in Italia: “abbagliati dalle novità di una maniera così prorompente e conquistati dalla portata innovativa della sua pittura, gli artisti di una generazione più giovani di lui l’hanno infatti riconosciuto come il propugnatore di un’energia creativa nuova”. Perciò, con la mostra di Palazzo Reale, ci si è prefissi l’obiettivo di esplorare anche questo sentiero meno battuto, indagando l’ascendente e la notevole influenza esercitata dai suoi dipinti sulle opere, oltre che del già citato Bernini (Napoli, 1598 - Stato Pontificio, 1680), anche di Pietro da Cortona (Cortona, 1596 - Roma, 1669), Domenico Fetti (Roma, 1589 - Venezia, 1623), Giovanni Lanfranco (Parma, 1582 - Roma, 1647), Salvator Rosa (Arenella, Napoli, 1615 - Roma, 1673) e Luca Giordano (Napoli, 1634 - 1705).
Accostando quindi le opere del maestro a quelle degli artisti italiani per scorgerne le affinità, appare evidente il debito verso di lui, interpretato da ognuno di essi secondo la propria visione.
 Un secondo parallelismo ci viene proposto dal Ritratto di Vincenzo II Gonzaga (Mantova 1594 – 1627) che sarà VII Duca. Minima porzione della grande pala commissionata a Rubens nel 1606 da suo padre, il mecenate del pittore e IV duca di Mantova, Vincenzo I (Mantova, 1562 - 1612) per la chiesa cittadina della Trinità affidata ai Gesuiti: la Famiglia Gonzaga in adorazione della santissima Trinità.
Un secondo parallelismo ci viene proposto dal Ritratto di Vincenzo II Gonzaga (Mantova 1594 – 1627) che sarà VII Duca. Minima porzione della grande pala commissionata a Rubens nel 1606 da suo padre, il mecenate del pittore e IV duca di Mantova, Vincenzo I (Mantova, 1562 - 1612) per la chiesa cittadina della Trinità affidata ai Gesuiti: la Famiglia Gonzaga in adorazione della santissima Trinità.
Questa opera grandiosa era parte di un originario trittico celebrativo della famiglia che, nelle due pale ai suoi lati, sviluppava i temi della “Trasfigurazione” e del “Battesimo di Cristo”.
Davanti alla Trinità, miracolosamente raffigurata su un drappo sorretto da angeli in volo, erano dipinti il duca Vincenzo I e sua moglie Eleonora de’ Medici, assieme ai genitori, il duca Guglielmo Gonzaga ed Eleonora d’Austria, ed alla loro discendenza in ordine di successione, i figli maschi sulla sinistra e le femmine sulla destra, oltre ad alcuni alabardieri, tra i quali si è autoritratto lo stesso Rubens.
In questo dipinto Rubens ci mostra per la prima volta un tratto essenziale della sua pittura: “la commistione fra ritrattistica e grande maniera, sia sacra sia mitologica, come nel ciclo della Vita di Maria de’ Medici, in cui la grandiosità del mito e della storia convivono curiosamente con la tangibilità dei personaggi contemporanei ritratti. I due generi si potenziano a vicenda, con una nobilitazione dei ritratti e una più realistica percezione della scena narrata”.
Si tratta di un procedimento che in seguito sarà ripreso da altri artisti, fra i quali Pietro da Cortona nei cartoni della Vita di Urbano VIII, composti proprio sull’onda della suggestione del grande ciclo mediceo visto e apprezzato dal cardinal Barberini nel suo viaggio a Parigi nel 1625.
Un pregio artistico che possiamo considerare un’“attenuante generica” a beneficio degli scellerati che vandalizzarono l’opera. Anche in questa circostanza, infatti, nel momento in cui eserciteranno il proprio potere militare sull’Italia, i Francesi di Napoleone decurteranno il grande dipinto dei suoi margini laterali conservandone soltanto alcune parti di nuovo intelate come opere singole: e, più precisamente, proprio come ritratti.
Si è scritto che la rimozione dalla chiesa della pala fu motivata dalle sue non buone condizioni di conservazione, ma analoghe vicende del tempo ci fanno giudicare non infondato il sospetto che il vero obiettivo fosse quello di farne quadretti da vendere separati sul mercato antiquario e così ricavarne un maggiore guadagno (pessima azione che abbiamo stigmatizzata in “Una sana idea malsana” leggi di più >>>).
 Se la sua porzione principale e più ampia è ancora a Palazzo Ducale di Mantova, nella sala degli Arcieri, altri frammenti superstiti sono dispersi in varie sedi: a Vienna (Kunsthistorisches Museum) il ritratto in mostra, Francesco IV (V Duca), in proprietà dell’industriale mantovano Romano Freddi, Ferdinando Gonzaga bambino (VI Duca), vicino a Parma (Mamiano di Traversetolo, Fondazione Magnani-Rocca), Margherita, consorte duchessa di Lorena, a Londra (collezione Burchard).
Se la sua porzione principale e più ampia è ancora a Palazzo Ducale di Mantova, nella sala degli Arcieri, altri frammenti superstiti sono dispersi in varie sedi: a Vienna (Kunsthistorisches Museum) il ritratto in mostra, Francesco IV (V Duca), in proprietà dell’industriale mantovano Romano Freddi, Ferdinando Gonzaga bambino (VI Duca), vicino a Parma (Mamiano di Traversetolo, Fondazione Magnani-Rocca), Margherita, consorte duchessa di Lorena, a Londra (collezione Burchard).
È purtroppo perduta la futura imperatrice del Sacro Romano Impero, Eleonora, ancora bambina che accarezza un cagnolino, che viceversa si trova in altra sala di Palazzo Ducale come anche uno degli alabardieri originariamente presenti (probabilmente cinque).
Cecilia Paolini, nella scheda in catalogo, nota che “l’abito alla spagnola di Vincenzo II è composto per giustapposizione di brevi tocchi di pennello molto carichi di colore, e non per velature come nella tradizione pittorica accademica. Questa tecnica presuppone una grande distanza di osservazione, in modo che l’occhio percepisca come una miscellanea cangiante le tinte in realtà soltanto accostate, ma non diluite l’una sull’altra (soluzione che avrebbe reso meno vibrante l’effigiato): come nota Bodart, Rubens anticipa di più di due secoli le ricerche ottiche sviluppate dagli impressionisti alla fine del XIX secolo”.
RUBENS E FETTI
 A questa attenzione per gli ori e le sottili decorazioni degli abiti farà riferimento Domenico Fetti (Roma, 1589 - Venezia, 1623) il cui stile si ritiene cominci ad essere influenzato da Rubens al suo arrivo, nel 1614, alla corte dei Gonzaga. A giudizio della Lo Bianco la sua conoscenza del maestro fiammingo può invece essere “anticipata attorno al 1608, quando Fetti è in rapporti stretti con i padri oratoriani della Chiesa Nuova in Roma presso i quali c’è chi ritiene che fosse «pensionante» e quindi ad essi legato da una frequentazione quotidiana, oltreché da piccoli incarichi di lavoro, come documentato da un primo pagamento risalente al 1611 di soli venti scudi per ben quattro ritratti. La sua grande tela con gli “Angeli adoranti l’immagine della Madonna con il Bambino” (Baltimora, Walters Art Museum) dal formato verticale ed eseguita subito prima della partenza per Mantova, è una dichiarata citazione della pala absidale dipinta da Rubens e quasi un omaggio ad un maestro riconosciuto”.
A questa attenzione per gli ori e le sottili decorazioni degli abiti farà riferimento Domenico Fetti (Roma, 1589 - Venezia, 1623) il cui stile si ritiene cominci ad essere influenzato da Rubens al suo arrivo, nel 1614, alla corte dei Gonzaga. A giudizio della Lo Bianco la sua conoscenza del maestro fiammingo può invece essere “anticipata attorno al 1608, quando Fetti è in rapporti stretti con i padri oratoriani della Chiesa Nuova in Roma presso i quali c’è chi ritiene che fosse «pensionante» e quindi ad essi legato da una frequentazione quotidiana, oltreché da piccoli incarichi di lavoro, come documentato da un primo pagamento risalente al 1611 di soli venti scudi per ben quattro ritratti. La sua grande tela con gli “Angeli adoranti l’immagine della Madonna con il Bambino” (Baltimora, Walters Art Museum) dal formato verticale ed eseguita subito prima della partenza per Mantova, è una dichiarata citazione della pala absidale dipinta da Rubens e quasi un omaggio ad un maestro riconosciuto”.
Arrivato in Lombardia Fetti poi vede certamente la grandiosa pala celebrativa di cui sopra si è detto, “composta da Rubens con una pittura calda e metallica, che mescola i bagliori dei damaschi e degli ornati con chiaroscuri e contrasti accentuati, in cui i personaggi appaiono davvero vitali nel loro regale realismo.
A questa pittura materica e calda Fetti si ispira nella produzione mantovana, di cui la grande lunetta della Moltiplicazione dei pani e dei pesci in Palazzo Ducale è l’esempio più evidente, rivelando la sua derivazione da un’interpretazione concitata e densa degli insegnamenti di Rubens, da emulare anche nella grandiosità del formato e della scena”.
In mostra ritroviamo l’influsso del maestro nel Ritratto di fanciulla dormiente (Budapest, Museo di Belle Arti), “dall’invenzione sofisticata e inusuale”, con il largo primo piano del drappo in damasco dorato sul quale appoggia il capo facendovi convergere lo sguardo. Quasi un fondo oro rivisitato che riprende i riflessi metallici degli abiti e sul quale si stagliano “il bianco delle maniche sfrangiate ed il volto dall’incarnato caldo, denso di venetismi, filtrati forse dalla visione dinamica di Rubens”.
II SALA
Si torna a Rubens nella seconda sala. Dapprima incontrando un personaggio che testimonia la sua frequentazione dell’elite culturale del tempo: l’umanista cattolico Gaspar Schoppe, appartenente alla confraternita filippina della Madonna della Vallicella che faceva capo al Cardinale Baronius.
Il suo ritratto, del 1602-1604, è quel che si dice un “ritratto parlante”, ben diverso dalle pose stereotipate del secolo precedente. Il dipinto dimostra come l’amore di Rubens per la famiglia vada di pari passo con quello per gli amici, espressione di quelle «sue doti naturali di bontà» di cui scrive Bellori, che si è visto ne apprezzava sia l’opera sia la persona. Perché in lui amore ed amicizia si saldano in un’armoniosa visione del mondo classico dal quale traeva i valori etici sui quali fondava la sua vita. Una visione cristiana in cui si fondono perfettamente i principi della filosofia stoica al centro del pensiero della cerchia di intellettuali stranieri legati all’artista, della quale faceva appunto parte anche l’umanista tedesco ritratto (dal cognome latinizzato in Scioppius).
 Segue un soggetto di genere: la Testa di vecchio. Che vediamo in due versioni, la prima di profilo, del 1609, dalla Galleria Corsini, la seconda frontale, più tarda (del 1612-14) dall’Hermitage di San Pietroburgo, uno studio per “La corona di spine (Ecce homo)”.
Segue un soggetto di genere: la Testa di vecchio. Che vediamo in due versioni, la prima di profilo, del 1609, dalla Galleria Corsini, la seconda frontale, più tarda (del 1612-14) dall’Hermitage di San Pietroburgo, uno studio per “La corona di spine (Ecce homo)”.
Come risulta evidente all’occhio dell’osservatore si tratta della stessa figura ritratta da due punti di vista differenti: rispettivamente di profilo e di tre quarti.
 Queste “teste di carattere” sono pose antiche riprese dalla scultura dell’arte greco romana, più precisamente da erme di età adrianea del II secolo (d.C.), come modelli poi riutilizzati in altre opere, ad esempio per Gaspare nell’“Adorazione dei Magi” del Prado, proposta più oltre in questo testo alla sezione “Santi ed Eroi” a confronto con l’“Adorazione dei pastori”.
Queste “teste di carattere” sono pose antiche riprese dalla scultura dell’arte greco romana, più precisamente da erme di età adrianea del II secolo (d.C.), come modelli poi riutilizzati in altre opere, ad esempio per Gaspare nell’“Adorazione dei Magi” del Prado, proposta più oltre in questo testo alla sezione “Santi ed Eroi” a confronto con l’“Adorazione dei pastori”.
L’idea di queste “riprese” piacque e venne copiata anche da Antoon van Dyck (Anversa, 1599 - Londra, 1641) e dal pittore spagnolo Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, più semplicemente noto come Diego Velázquez (Siviglia, 1599 - Madrid, 1660): l'artista più importante tra quelli presenti alla corte di Re Filippo IV di Spagna.
Concedendoci una digressione sui Re Magi, possiamo qui ricordare che, nel complesso monastico di Kellia, in Egitto, sono stati rinvenuti i nomi di Gaspar, Melechior e Bathesalsa.
Melchiorre (colui che offre al Bambino la mirra) sarebbe il più anziano (ma per altri il più giovane), con fisionomia europea e il suo nome deriverebbe da Melech, che significa Re.
Baldassarre (il re nero, che offre l'incenso) - deriverebbe da Balthazar, mitico re babilonese, quasi a suggerire la sua regione di provenienza.
Gasparre (l'offerente oro) sarebbe infine il re orientale, per i greci Galgalath, significa signore di Saba.
 L’ascendenza classica appena descritta rappresenta per l’artista una fonte infinita d’ispirazione che in mostra ci viene documentata con numerosi esempi fra i quali la preziosa tela raffigurante l’Apoteosi di Germanico, rara copia di un cammeo romano. “In una lettera del 1622, scritta a Parigi e inviata da Nicolas-Claude Fabri de Peiresc a Girolamo Aleandro a Roma, leggiamo che l’artista è a Parigi e che «ha promesso di disegnare di sua mano i cammei di Augusto et Tiberio»”.
L’ascendenza classica appena descritta rappresenta per l’artista una fonte infinita d’ispirazione che in mostra ci viene documentata con numerosi esempi fra i quali la preziosa tela raffigurante l’Apoteosi di Germanico, rara copia di un cammeo romano. “In una lettera del 1622, scritta a Parigi e inviata da Nicolas-Claude Fabri de Peiresc a Girolamo Aleandro a Roma, leggiamo che l’artista è a Parigi e che «ha promesso di disegnare di sua mano i cammei di Augusto et Tiberio»”.
Ed ancora l’Erma dello pseudo Seneca dai Musei Capitolini (immagine in basso) che ritroviamo nel grande dipinto Seneca morente (1612-15).
In esso il volto del protagonista è ripreso da quello di un suo busto bronzeo di proprietà del Museo Archeologico di Napoli, mentre il corpo è quello di una scultura del Louvre… grazie ad un equivoco.
Si trattava, infatti, di un pescatore africano nel quale, per errore, si credette invece di riconoscere Seneca.
L’episodio raffigurato è quello del momento in cui il filosofo stoico, nato a Cordova in Spagna nel 4 a.C., si toglie la vita attorniato dai discepoli. Così facendo, con un estremo esempio, dà loro conferma di quanto aveva sempre insegnato: ad avere coraggio ed a rimanere imperturbabili e sereni di fronte al dolore.
Era infatti stato condannato a morte da Nerone essendo risultato implicato in una congiura contro di lui.
Già scampato alla condanna a morte da parte di Caligola, fu esiliato da Claudio e poi divenne, invece, tutore e precettore del futuro imperatore Nerone, su incarico della madre Giulia Agrippina Augusta.
Quando Nerone e Agrippina entrarono in conflitto, Seneca approvò l'esecuzione di quest'ultima come male minore.
Dopo il cosiddetto “quinquennio di buon governo” o “quinquennio felice” (54-59 d.C.), in cui Nerone governò saggiamente sotto la tutela di Seneca, l’ex allievo ed il maestro si allontanarono sempre di più, portando il filosofo al ritiro politico che aveva sempre desiderato, ma anche all’epilogo della sua vita a Roma nel 65 d.C..
In questa raffigurazione di Seneca leggiamo l’elogio della saggezza e della ragione dell’uomo giusto, per Rubens modello di tutta una vita.
I soggetti filosofici, che tanto successo riscuoteranno più avanti nel secolo, soprattutto nell’Europa del sud, vengono introdotti in questi decenni del Seicento proprio dai pittori nordici; tra questi lo stesso Rubens, particolarmente sensibile ai temi presocratici (Socrate: Atene, 470 a.C. - 399 a.C.) e partecipe del movimento neostoico in cui si coltivava una visione etica del mondo antico da lui pienamente condivisa.
È un fenomeno che si afferma nello stesso ambiente culturale in cui si muove l’artista, ovvero nella stamperia di Plantin ad Anversa, anche attraverso gli studi del filosofo e studioso di Seneca Justus Lipsius, ritratto da Rubens più volte, e riconosciuto maestro anche dal suo amatissimo fratello Philip.
LO STOICISMO
Nella storia del pensiero antico prendono il nome di stoicismo la dottrina e la tradizione che fanno riferimento a Zenone di Cizio (nell’isola di Cipro) ed alla sua scuola, così chiamata perché Zenone e i suoi successori usavano adunarsi nella Stoà Poikìle: il portico dipinto; il più celebre portico di Atene, costruito prima della metà del V secolo a.C. [da Peisianatte] nella parte settentrionale dell’Agorà.
Nella scuola stoica si possono distinguere tre grandi periodi.
Il primo, detto dell’antica stoà, è fondato da Zenone (336 - 335 a.C. – 263 a.C.) agli inizi del III sec. e si estende fino al II sec. a.C. inoltrato; in esso sono elaborati i motivi fondamentali della dottrina.
Già dal II sec. si afferma però la tendenza a fondere ecletticamente con le concezioni stoiche motivi platonici e aristotelici, aprendo così una seconda fase, la media stoà (o stoicismo medio), che si protrae dal II al I sec. a.C., ed ha come suoi maggiori esponenti discepoli di Diogene di Seleucia (sul Tigri, nei pressi di Babilonia, 240 a.C. - 150 a.C; da non confondere con il Diogene il Cinico - Sinope, città sul Mar Nero, 412 a.C.circa - Corinto, 10 giugno 323 a.C. - colui che viveva in una botte, che circolava con una lanterna “cercando l’uomo” ed invitò Alessandro Magno a spostarsi perché gli faceva ombra), importanti per l’influenza esercitata sulla cultura romana.
Il terzo e ultimo periodo della scuola, denominato dell’ultima stoà (o stoicismo tardo), si estende dal I al III sec. d.C. e si caratterizza per la sintesi di motivi desunti dalla tradizione cinica e di dottrine della prima stoà. Seneca, Epitteto e l’imperatore Marco Aurelio si annoverano fra i massimi esponenti di questa fase.
La scuola stoica ebbe grande importanza nel mondo romano, dove l’etica da essa elaborata, esaltando la libertà e la dignità dell’individuo, portò alla creazione di un tipo ideale di stoico: insensibile al male fisico e capace di affrontare volontariamente la morte, quando essa fosse l’unico modo per sottrarsi alle offese provenienti dal mondo esterno.
 Il nuovo interesse per il mondo presocratico che si viene proponendo è incentrato soprattutto sulle figure di Eraclito (535 - 475 a.C.) e di Democrito (460 - 370 a.C,), ma anche di Diogene, oltre a quello per Seneca e per le correnti stoiche.
Il nuovo interesse per il mondo presocratico che si viene proponendo è incentrato soprattutto sulle figure di Eraclito (535 - 475 a.C.) e di Democrito (460 - 370 a.C,), ma anche di Diogene, oltre a quello per Seneca e per le correnti stoiche.
Ne è una precoce dimostrazione, in un dipinto di Rubens del 1603 oggi a Valladolid, l’accostamento dei due filosofi, che esalta la visione universalistica di Eraclito determinante anche per lo Stoicismo, e quella atomista di Democrito anticipatore di una concezione scientifica moderna. Il primo, assertore del panta rei, tutto scorre, nella comune iconografia è raffigurato in pianto a causa dell’assurdità e mancanza di senso del mondo e della follia umana. Il secondo invece ride ironico: per l’incapacità di prendere sul serio tutto ciò per cui gli uomini si affannano, soffrono, o gioiscono.
 Occorrerà del tempo prima che questo genere di soggetti riscuota il favore di artisti e committenti anche in Italia. Cosa che avviene soprattutto in meridione grazie a Ribera, Luca Giordano e Salvator Rosa.
Occorrerà del tempo prima che questo genere di soggetti riscuota il favore di artisti e committenti anche in Italia. Cosa che avviene soprattutto in meridione grazie a Ribera, Luca Giordano e Salvator Rosa.
Ed è proprio quest’ultimo a dipingere, attorno al 1646, la coppia Democrito ed Eraclito, oggi al Kunsthistorisches Museum di Vienna nel quale, confrontandolo col quadro di Rubens di quarant’anni prima osserviamo che “le tematiche filosofiche abbiano assunto un carattere più eccentrico, prossimo alla stregoneria, con incursioni nel mondo degli straccioni, dei diseredati, tanto caro a Ribera”.
Più in generale notiamo che, ispirato dalle incisioni arrivate dal nord Europa, questo tema è sempre più replicato e, poco alla volta, “diventa un genere ben preciso: che trova in Rubens un punto di riferimento e tuttavia percorre una strada diversa, aprendosi a un collezionismo crescente, interessato proprio a queste opere cupe e anticonformiste. Al colto enunciato di Rubens, antesignano in Italia del nuovo componimento filosofico, si sostituisce uno stile volutamente eccentrico, nel quale possiamo scorgere anche l’interesse per la nascente fisiognomica”.
Per la verità, Guido Codecasa ci fa notare che l’icona dei due filosofi viene definitivamente sdoganata nell’Emblematum liber (libro degli Emblemata) del 1560, libro a stampe di Andrea Alciati, contenente gli episodi più “iconici” del mondo antico.
Che si sappia però, al di fuori di Bramante e Antonio Fregoso (I QUADERNI de L'ECLETTICO n. 2 - La stanza di Bramante, leggi di più >>>), non risulta nessuno che in precedenza abbia elaborato l’iconografia dei due filosofi trasformandola in un marchio di successo. Un'interessante ricerca tedesca conferma il sospetto: il che spingerebbe a supporre che il pianto di Eraclito ed il riso di Democrito siano una trovata tutta Milanese.
SANTI COME EROI
III SALA
La classicità continua ad essere un evidente e ricorrente punto di riferimento anche nella sezione successiva, nella quale ad essere raffigurati al modo di eroi della storia antica e di personaggi della mitologia sono, invece, i santi.
Fra Mantova, Genova, Roma e Fermo, le opere con soggetto sacro dipinte da Rubens nel corso del suo soggiorno italiano sono grandiose e rivoluzionarie, e la sua rivisitazione del mondo classico in termini sacri attrae ed esercita una forte impressione nei primi anni del Seicento sulla generazione degli artisti più giovani che già abbiamo ricordato e diventeranno i protagonisti del nuovo Barocco.
Ma accanto all’antico, l’interesse di Rubens si rivolge anche agli artisti che lo hanno preceduto come Michelangelo, Tiziano, Correggio, Tintoretto… Di fatto è l’intera grande tradizione italiana ad essere “ripresa e reinventata con un impeto creativo assolutamente nuovo”. È un complesso di stimoli che suscita in lui una fortissima vena creativa, capace di spingerlo “verso invenzioni ardite e complesse, del tutto innovative”.
Il suo biografo Bellori dimostra di aver ben compreso il disinvolto e personale rapporto di Rubens con l’antico, ma anche con il Rinascimento, quando scrive che: «Benché egli stimasse sommamente Raffaele e l’antico, li alterava tanto con la sua maniera che non lasciava in essi forma o vestigio per riconoscerli».
 Cominciamo a verificare l'affermazione nel Martirio di sant’Orsola (1605, Museo di Palazzo Ducale a Mantova), soggetto già incontrato a Milano alcuni anni fa nella versione di Caravaggio, allora da poco riconosciuta all’artista lombardo.
Cominciamo a verificare l'affermazione nel Martirio di sant’Orsola (1605, Museo di Palazzo Ducale a Mantova), soggetto già incontrato a Milano alcuni anni fa nella versione di Caravaggio, allora da poco riconosciuta all’artista lombardo.
SANT'ORSOLA
Poiché queste mostre d’arte antica sono sempre occasione per riscoprire quanto un tempo era patrimonio culturale diffuso, per una migliore comprensione dell’opera è opportuno ripassare la vicenda di questa santa non a tutti nota.
Una “Passio” del X secolo narra di una giovane d'eccezionale bellezza, Orsola, figlia di un sovrano bretone, che si era segretamente consacrata a Dio ma fu chiesta in sposa dal principe pagano Ereo.
Il rifiuto da parte della principessa avrebbe rischiato di scatenare una guerra ed anche per questo, consigliata da un angelo nel corso di una visione avuta in sogno, chiese di poter rimandare la decisione di tre anni, per meglio comprendere la volontà del Signore e nella speranza che il promesso sposo si convertisse al cristianesimo e cambiasse idea.
Allo scadere del tempo stabilito, ancora esortata da un messaggero divino, Orsola prese il mare con undicimila compagne e, secondo alcune versioni, anche con il promesso sposo. Attraversò il tratto di mare fra l'Inghilterra ed il continente su una flotta di undici navi, poi, sospinta anche da una tempesta, risalì il corso del Reno fino a Colonia e successivamente a Basilea, in Svizzera, da dove proseguì a piedi, in devoto e variopinto pellegrinaggio, fino a Roma.
A Roma Orsola e le sue compagne furono accolte da "papa Ciriaco", personaggio sconosciuto alla storia.
Successivamente, di ritorno in patria per la stessa via, transitò per Colonia, che nel frattempo era stata conquistata da Attila: qui le undicimila vergini, esortate da Orsola alla fermezza, furono subito trucidate in un solo giorno dalla furia dei barbari, mentre il famigerato re unno, invaghito dalla sua bellezza, risparmiò Orsola, che chiese anch’egli in sposa, promettendole salva la vita.
Al suo rifiuto la fece però uccidere a colpi di freccia, e con lei, secondo una tarda versione, fu ucciso pure papa Ciriaco, che l'aveva seguita nel suo viaggio.
Ancora Guido Codecasa ci informa che la tradizione sopra riferita sul mito di sant’Orsola ha origine celtica ed è facilmente frutto (come sempre accade in questi casi) della combinazione di più versioni.
Una è continentale e parte dal ritrovamento a Koln (Colonia Agrippina) di una lapide commemorativa del V sec. proveniente dal cimitero romano su cui ora sorge la basilica affacciata su Vrsulaplatz.
Poi c’è l’origine insulare della leggenda legata alla tradizione orale conservata, anche se in forma corrotta e confusa, fino a Goffrey of Monmouth. In questo caso Vrsula potrebbe essere imparentata con re Dionethus (uno dei primi re di Britannia) o Conan Meriadec (governatore dell’Armorica - ovvero Bretagna, piccola Britannia - scelto dall’usurpatore Massimo nel poema “Il sogno di Maxen Gwledig”) .
Il massacro di massa delle vergini compagne di sant’Vrsula potrebbe infine essere una corruzione di un’altra tradizione. Vrsula non viene infatti citata né da Beda né da Gregorio di Tours che, a riguardo di Colonia, ricorda invece il martirio della Legio Thebana.
È quindi probabile che, al momento dell’edificazione della basilica romanica da parte del vescovo Gunthar nel IX sec. d.C., il ritrovamento della lapide della vergine Vrsula uccisa per mano di Attila sia stato "integrato" anche con la leggenda dello sterminio della legione Thebana convertita al cristianesimo.
 Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente pittorico, in questa sua precoce tela si riconosce l’ascendente esercitato su Rubens, fin dai suoi primi passi mossi a Venezia, dal Tintoretto (Jacopo Robusti, Venezia, 1519 - 1594), unanimemente considerato una costante dell’universo del giovane fiammingo appena giunto in Italia.
Per quanto riguarda l’aspetto più strettamente pittorico, in questa sua precoce tela si riconosce l’ascendente esercitato su Rubens, fin dai suoi primi passi mossi a Venezia, dal Tintoretto (Jacopo Robusti, Venezia, 1519 - 1594), unanimemente considerato una costante dell’universo del giovane fiammingo appena giunto in Italia.
Il suo debito verso il maestro veneziano “per l’uso violento della luce, per la sommarietà d’esecuzione, per il senso concitato eppure aereo dell’insieme” si comprendono bene nel confronto con il Cristo e l’adultera (1546, Roma, Gallerie Nazionali d’Arte Antica) che gli è accostato.
In esso, fra gli elementi presi come riferimento da Rubens, gli esperti riconoscono la fierezza dei personaggi femminili nei cui volti non si faticano a ritrovare i lineamenti delle matrone romane.

 Come quella in mostra del Busto-ritratto femminile in marmo del II secolo d.C. dai Musei Capitolini che ci appare come un modello ideale per l’intensa Santa Domitilla di profilo del 1607 dall’Accademia Carrara (a destra).
Come quella in mostra del Busto-ritratto femminile in marmo del II secolo d.C. dai Musei Capitolini che ci appare come un modello ideale per l’intensa Santa Domitilla di profilo del 1607 dall’Accademia Carrara (a destra).
Una figura centrale che ricorre anche nella donna in piedi sulla sinistra fra le figure che circondano il Bambino Gesù nel bellissimo bozzetto preparatorio della pala della Circoncisione, per la chiesa del Gesù a Genova, dipinto nel 1605 ed oggi a Vienna (dettaglio a sinistra).
LA CHIESA NUOVA, SANTA MARIA IN VALLICELLA
Infine eccola, di nuovo, nella Santa Domitilla per l’altare maggiore di Santa Maria in Vallicella: la cosiddetta Chiesa Nuova che sorgeva in una delle zone più frequentate del Centro Storico di Roma, poco distante da piazza Navona, fra il Pantheon e Castel Sant’Angelo.
Come ben sanno gli storici dell’arte, la commissione nel 1606 per la decorazione dell’altare centrale di questa chiesa (la sua seconda commissione pubblica dopo il ciclo - non più in loco ed in parte perduto - per la basilica di Santa Croce in Gerusalemme) fu un’occasione unica ed un punto d’arrivo della carriera di Rubens, che ne era ben consapevole e lo annunciava orgogliosamente in una lettera del dicembre 1606 ad Annibale Chieppio, segretario di Vincenzo Gonzaga, nella quale definiva la chiesa «la più celebrata e frequentata di Roma».
 Si trattava di un lavoro fra i più ambiti per tutti gli artisti del tempo e Rubens, che già godeva della protezione di Scipione Borghese e del potente Giacomo Serra, ha l’ulteriore fortuna di essere in quel momento disponibile mentre i maggiori possibili contendenti - Caravaggio, Barocci, Zuccari, Carracci - , per varie ragioni, erano tutti fuori gioco.
Si trattava di un lavoro fra i più ambiti per tutti gli artisti del tempo e Rubens, che già godeva della protezione di Scipione Borghese e del potente Giacomo Serra, ha l’ulteriore fortuna di essere in quel momento disponibile mentre i maggiori possibili contendenti - Caravaggio, Barocci, Zuccari, Carracci - , per varie ragioni, erano tutti fuori gioco.
“Quando Rubens lascia frettolosamente l’Italia il 28 ottobre 1608, il complesso lavoro per l’Oratorio di Roma, dopo infinite difficoltà, è stato appena portato a termine. E subito dopo la sua partenza, non appena realizzati gli ornamenti in marmo, la decorazione viene scoperta diventando immediatamente un punto di riferimento soprattutto per gli Italiani della generazione che guardava a Rubens come un modello assoluto di invenzione compositiva, tecnica e fantasia verso il quale tendere. Santi con volti da imperatore e solenni come eroi del mondo antico, sante eleganti e statuarie come nobili matrone romane”.
 E, al centro, un trionfo di angeli in adorazione dell’immagine della Madonna col Bambino benedicente che, dipinta da Rubens su una lastra di rame sollevabile grazie ad un meccanismo di corde e pulegge, riproduce e protegge l’antica e miracolosa icona sacra della Madonna vallicelliana, un affresco del tipo della Nicopeia (apportatrice di vittoria) o Kyriotissa (Regina, dominatrice del mondo), ospitata all’interno di una nicchia sottostante. Il tutto pervaso da un dinamismo irrefrenabile che investe tutti i personaggi.
E, al centro, un trionfo di angeli in adorazione dell’immagine della Madonna col Bambino benedicente che, dipinta da Rubens su una lastra di rame sollevabile grazie ad un meccanismo di corde e pulegge, riproduce e protegge l’antica e miracolosa icona sacra della Madonna vallicelliana, un affresco del tipo della Nicopeia (apportatrice di vittoria) o Kyriotissa (Regina, dominatrice del mondo), ospitata all’interno di una nicchia sottostante. Il tutto pervaso da un dinamismo irrefrenabile che investe tutti i personaggi.
“Non si era mai vista una pittura del genere: la più grande novità a Roma a inizio secolo dopo Caravaggio”. “L’energia della decorazione della Chiesa Nuova colpisce così tanto il mondo dell’arte perché in essa si percepisce, in maniera chiarissima, la vera novità del messaggio: la seduzione della pittura sacra e la strada intrapresa verso la sua incontrastata secolarizzazione”.
 Di quest’opera cruciale la mostra ci propone due versioni.
Di quest’opera cruciale la mostra ci propone due versioni.
Una, I santi Gregorio, Domitilla, Mauro, Papiano, Nereo e Achilleo, allungata in orizzontale, del 1608 (oggi a Salisburgo), nella quale manca l’effigie della Vergine al centro ma sono schierati, sulla sinistra, San Gregorio fra i santi in armi Mauro e Papiano e, sulla destra, Domitilla fra i santi martiri Nereo e Achilleo, anch’essi ex militi ma qui raffigurati in abiti civili, forse facendo riferimento alla leggenda secondo la quale i due erano servitori della vergine Domitilla (sulla precisa identità della quale non vi sono certezze, tanto è vero che il suo culto, introdotto nel Calendario Generale Romano della chiesa Cattolica soltanto nel 1595, ne è stato rimosso nel 1969).
 Dall'iniziale progetto unitario Rubens poi si discostò recuperando tuttavia la figura di San Gregorio con le braccia aperte per le successive versioni.
Dall'iniziale progetto unitario Rubens poi si discostò recuperando tuttavia la figura di San Gregorio con le braccia aperte per le successive versioni.
Un’altra di esse in mostra (del 1606, oggi a Berlino), testimonia la prima idea di prova da sottoporre ai committenti più che un bozzetto, è invece orientata in verticale e vi “si condensano le novità del suo originale linguaggio”.
Mancano Nereo e Achilleo e l’icona della Vergine ma la troviamo molto più dinamica ed interessante anche grazie alla disposizione piramidale che, per movimentare la scena, si serve anche delle architetture nelle quali è inserita. Come i gradini della scalinata, sulla quale sostano o accennano un passo le figure, e lo sfondo aperto sotto l’arco, attraverso il quale vediamo un paesaggio di edifici inerpicati sulle pendici scoscese di un rilievo montuoso sovrastato da alberi e da un cielo di nubi plumbee e tempestose.
Semplicemente spettacolari, per colori e fattura, sono poi le vesti bianca abbagliante di Gregorio e lilla sericeo di Domitilla: i due santi dei quali la chiesa conserva le reliquie.
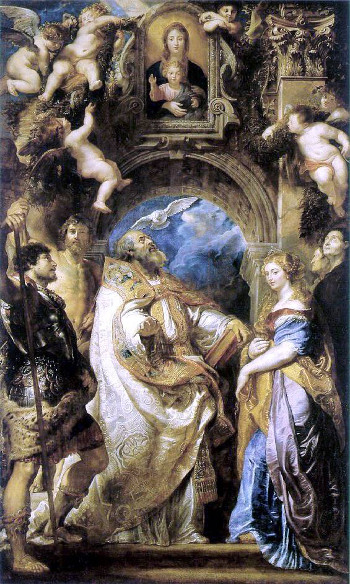 La versione definitiva di questa versione (a sinistra) sembra non trovò soddisfatti i committenti che la inviarono a Grenoble, nel cui museo cittadino ora si trova.
La versione definitiva di questa versione (a sinistra) sembra non trovò soddisfatti i committenti che la inviarono a Grenoble, nel cui museo cittadino ora si trova.
Risulta però che fu lo stesso Rubens, verso la fine del 1607, mentre stava terminando l’opera, ad accorgersi che la posizione del dipinto sull’altare attirava una luce eccessiva rendendola poco leggibile.
Per questo motivo la ritirò e nel 1608 la sostituì con tre dipinti su ardesia, materiale più adatto alla luce della chiesa, fra i quali suddivise la composizione in tre scene distinte: la“Madonna della Vallicella” al centro ed “I santi Gregorio, Papia e Mauro” e “I santi Domitilla, Nereo e Achilleo” rispettivamente alla sua sinistra ed alla sua destra ma entrambi in dialogo visivo con l’immagine della Madonna verso la quale sono rivolti in adorazione (foto in basso).
Come si è visto, per la sua posizione strategica, tra piazza Venezia e San Giovanni dei Fiorentini, frequentatissima meta dei numerosi toscani che vivono a Roma, “la Chiesa Nuova appare davvero un crocevia di cultura dal quale passano tutti gli artisti che lavorano a Roma, i committenti, gli eruditi: tutti assidui frequentatori dei palazzi aristocratici delle vicinanze”.
Cosicché la “concitata rivisitazione dell’antico, declinato in termini sacri ed in una grandiosità seducente” che Rubens vi ha messo in scena non passa inosservata ed attrae irresistibilmente la generazione di artisti più giovani sui quali esercita un effetto che si coglie nei primi decenni del XVII secolo in molti di coloro che diventeranno i protagonisti di uno stile nuovo, animato proprio da queste prerogative, interpretate da ciascuno di essi secondo modi e scelte personali.

RUBENS E LANFRANCO
Tra i giovani attratti da queste invenzioni di Rubens spicca Giovanni Gaspare Lanfranco (Parma, 26 gennaio 1582 - Roma, 30 novembre 1647) che, più anziano di Pietro da Cortona e di Bernini, conosce l’opera di Rubens nel 1612 quando torna a Roma, dove già aveva lavorato a palazzo Farnese, dopo un periodo trascorso nella patria Parma. “Successivamente è anche lui attivo a Fermo, attorno al 1616-1617, con una grandiosa Pentecoste, per la chiesa di San Filippo ed oggi nella Pinacoteca Civica, che sembra consapevole delle novità di Rubens di cui evoca l’affollata monumentalità. Ma l’adesione ai modi di Rubens diventa più esplicita nel 1622, nella decorazione della cappella della famiglia Sacchetti in San Giovanni dei Fiorentini, affidatagli dalla potente famiglia toscana, che poco dopo accentrerà la propria attenzione su Pietro da Cortona, allora troppo giovane per un possibile ingaggio”.
Nella pala raffigurante l’Andata al Calvario “Il riferimento all’artista fiammingo è evidente e quasi certamente maturato, oltre che nella frequentazione della Chiesa Nuova, anche nell’ambiente del cardinal Montalto, protettore di Lanfranco a partire dagli anni attorno al 1615”. Si tratta dello stesso cardinale che, nel 1601, aveva accolto Rubens a Roma – raccomandato da Vincenzo Gonzaga, che ve lo aveva inviato «per copiar e far alcuni quadri di pittura» – e ne aveva probabilmente seguito i primi passi romani.
 Più avanti nel tempo “le suggestioni di Rubens fanno ormai parte della concezione figurativa del pittore” ed in mostra lo documenta la tela raffigurante il raro soggetto di San Silvestro doma il drago, realizzata per la casa dei carmelitani scalzi di Caprarola (VT) nel 1628.
Più avanti nel tempo “le suggestioni di Rubens fanno ormai parte della concezione figurativa del pittore” ed in mostra lo documenta la tela raffigurante il raro soggetto di San Silvestro doma il drago, realizzata per la casa dei carmelitani scalzi di Caprarola (VT) nel 1628.
La grandiosità del protagonista, che appoggia sul vassoio offertogli da un chierico inginocchiato la chiave della catena con la quale ha imprigionato il drago ormai inoffensivo ai suoi piedi, ed i resti delle antichità sul fondo dove si perdono i dettagli, testimoniano la ricchezza di rimandi alle invenzioni della Chiesa Nuova.
Riferimenti che sono evidenti “soprattutto nell’interpretazione della figura del santo, dal ricco piviale d’uno stesso cangiante damasco dorato, solenne e centrale nell’ampia e mobile torsione del corpo, molto vicina al san Gregorio di Rubens.
Un’invenzione dinamica, tutta orchestrata secondo un andamento instabile e una visione di massa, di una teatralità fortissima. Sul fondo l’arco romano dalla forte valenza simbolica, che rimanda al Palatino, lo stesso che figura nella versione preparatoria, oggi a Berlino, della decorazione della Chiesa Nuova” che abbiamo già visto sopra ed alla quale rinviamo per un confronto diretto.
Nello stesso anno del San Silvestro, “questa visione porterà Lanfranco al grandioso e ammiratissimo affresco della cupola di Sant’Andrea della Valle con la Gloria del Paradiso, che Bellori paragona ad una «piena musica quando li tuoni insieme fanno l’armonia», riconoscendone il «bel genio» e la forte discendenza da Correggio, punto di riferimento anche per Rubens nella tela dell’Adorazione dei magi.
Incuriositi sulla vicenda raffigurata in questo inconsueto soggetto, scopriamo trattarsi di un’antica e popolare leggenda, tratta dagli "Acta Silvestri".
Nel IV secolo dopo Cristo, in una caverna sul Palatino con vicino un laghetto stagnante, viveva un terribile drago che con il suo alito pestifero era in grado di uccidere tutti quelli che abitavano o si trovavano a passare nelle vicinanze.
Per mettere fine a questa strage di innocenti, il pontefice Silvestro I, che aveva già vinto una belva simile a Poggio Catino, intervenne di persona e si recò alla tana del mostro: completamente disarmato ma con il mano il Crocifisso. Alla vista del simbolo sacro, mentre Silvestro invocava l’aiuto della Vergine, il drago divenne immediatamente mansueto, al punto che il Papa lo poté legare con un filo della sua veste e portare al guinzaglio come un cagnolino al cospetto dei suoi fedeli, che lo uccisero.
Persino i sacerdoti pagani, impressionati dai fatti, si convertirono al cristianesimo.
Intanto, l’enorme corpo fu trascinato nel Foro Romano fino al tempio di Castore e Polluce - di cui ancora rimangono tre eleganti colonne corinzie scanalate, sormontate da un breve tratto di architrave - e qui seppellito.
Secondo la tradizione, il Pontefice avrebbe ordinato di edificare nei pressi la chiesa di S. Maria Liberatrice, detta anche di S. Maria libera nos a poenis inferni.
Tornando alla leggenda di papa Silvestro, il suo significato è piuttosto chiaro e si riferisce alla vittoria del cristianesimo sul paganesimo, che proprio in quegli anni si realizzava con la conversione dell’imperatore Costantino.
La diffusione della leggenda è testimoniata dalle numerose raffigurazioni dell’episodio, a cominciare dall’affresco del XIII secolo, ormai molto rovinato, dell’oratorio di San Silvestro presso la chiesa dei Santi Quattro Coronati.
Sempre duecenteschi sono i cicli pittorici di San Silvestro a Tivoli, comprendenti la conversione di Costantino e la vittoria di San Silvestro sul drago.
Nella chiesa dedicata a San Silvestro ad Alatri, di cui si ha notizia fin dal 1220, un pannello ad affresco relativo alla più antica decorazione dell’edificio raffigura il miracolo di San Silvestro e il drago.
IV SALA
Altri riferimenti all’antichità, non citati filologicamente da Rubens ma liberamente reinventati assecondando la propria fervida fantasia, continuiamo a ritrovarli nelle due successive sale.
La testa abbandonata e riversa all’indietro, con gli occhi rivolti al cielo, dell’Alessandro Magno morente in porfido della seconda metà del XVI secolo, attribuito a Francesco del Tadda (Francesco Ferrucci, Fiesole, 1497 - 30 aprile 1585), è stata vista come un “esempio di sofferenza toccante, spesso copiata e riproposta dagli artisti del Seicento. Rubens, che conosce l’originale, vi si ispira per la testa dolente del San Sebastiano, che vedremo nella sala successiva, e per quella del Cristo morto” nel Compianto su Cristo morto (1603), una delle prime opere italiane di Rubens oggi alla Galleria Borghese di Roma.
 Non sembra esserle estraneo anche lo sguardo levato al cielo da Maria, che regge il corpo del Figlio fra Giuseppe d’Arimatea e Giovanni Evangelista, mentre, più sotto, la seminascosta Maria di Cleofa bacia la mano ferita del suo Signore ed il volto di Maria Maddalena, rivolto verso di noi, è solcato da una lacrima che scende lentamente sulla gota e sarà riproposta da Bernini “nella più virtuosa realizzazione in marmo sul volto della sua Proserpina rapita, nella grande scultura anch’essa alla Galleria Borghese.
Non sembra esserle estraneo anche lo sguardo levato al cielo da Maria, che regge il corpo del Figlio fra Giuseppe d’Arimatea e Giovanni Evangelista, mentre, più sotto, la seminascosta Maria di Cleofa bacia la mano ferita del suo Signore ed il volto di Maria Maddalena, rivolto verso di noi, è solcato da una lacrima che scende lentamente sulla gota e sarà riproposta da Bernini “nella più virtuosa realizzazione in marmo sul volto della sua Proserpina rapita, nella grande scultura anch’essa alla Galleria Borghese.
Il Compianto, di cui si ignora la provenienza e quindi il committente, “rappresenta in pieno il concetto della verosimiglianza e della vitalità dell’antico nella figura della bellissima Maddalena, vero fulcro di tutta l’invenzione”.
Antico “appare anche il sarcofago su cui è posto Cristo morto del quale si può notare il sottile artificio della gamba piegata, più volte raffrontata col prototipo dello Spinario (in mostra alcune sale più avanti) e con l’analoga posa dell’amorino alato nel rilievo antico sul suo fianco sinistro: è un gioco, già da grande artista, di contrapposte angolazioni che legano il mondo classico a quello religioso, la scultura alla pittura”.
 Direttamente dall’antichità, senza successive mediazioni, arriva invece il Torso del Belvedere dei Musei Vaticani. Grandiosa scultura mutila e capolavoro della scuola ateniese del I secolo a.C. è in mostra nella versione del suo calco in gesso, che sarebbe stato più opportuno utilizzare anche per le celebrazioni dei Trattati di Roma nel marzo scorso, in luogo dell’originale inopinatamente messo a repentaglio per ragioni stigmatizzate su L’Eclettico in Mostre d’arte, fu vera gloria? (Leggi di più >>>).
Direttamente dall’antichità, senza successive mediazioni, arriva invece il Torso del Belvedere dei Musei Vaticani. Grandiosa scultura mutila e capolavoro della scuola ateniese del I secolo a.C. è in mostra nella versione del suo calco in gesso, che sarebbe stato più opportuno utilizzare anche per le celebrazioni dei Trattati di Roma nel marzo scorso, in luogo dell’originale inopinatamente messo a repentaglio per ragioni stigmatizzate su L’Eclettico in Mostre d’arte, fu vera gloria? (Leggi di più >>>).
Si tratta di una delle opere più apprezzate dell’antichità, alla quale hanno guardato innumerevoli artisti dal Rinascimento in poi. Primo fra tutti i più grandi Michelangelo (1475-1564): che affermava di “amarla sommamente” e vi si ispirò per i suoi Ignudi della cappella Sistina ed al quale c’è addirittura chi in realtà lo attribuisce con argomentazioni non futili.
Al suo fascino non poté sottrarsi neppure Rubens, che la vide a Roma, nel cortile del Belvedere Vaticano dove si trovava dal 1536, e vi riconobbe “la perfetta sintesi dei suoi punti di riferimento: l’antico e la grandiosità michelangiolesca che lo aveva folgorato”. Dunque non sorprende il fatto di riconoscerla ricorrere più volte nei suoi dipinti. E lo testimoniano il confronto con il Compianto su Cristo morto e, subito accanto, il busto del Cristo risorto del 1616 (dalla Galleria Palatina di Palazzo Pitti a Firenze).
“Qui la scultura classica è il punto di partenza per una posa sbilanciata e ruotata, tutta incentrata sull’energia che nasce dalla forza compressa, secondo un’idea già pienamente barocca”.
Il modello è infatti inserito nella figura del Risorto ritratto proprio nel momento in cui gli angeli lo stanno scoprendo sollevandone il sudario e colto proprio nell’atto di levarsi: col piede sinistro sospeso alla ricerca del punto di appoggio che invece hanno già trovato la gamba destra, pronta alla spinta, la mano destra, arretrata a dare equilibrio, e la sinistra che impugna in alto l’asta per far meglio leva nell’aiutarsi per alzarsi in piedi.
Non meno interessante di quello plastico è il significato simbolico del dipinto. Il Cristo che irradia luce e mostra le ferite della passione si sta alzando dalla lastra di copertura di un sarcofago sul quale sono appoggiate le spighe dorate di grano che lo trasformano in un altare per l’eucarestia: veri e propri tocchi di luce di cui, come per altri dettagli, il recente restauro ci permette di vedere ancora intatte le piccole e rapide pennellate con le quali sono state dipinte.
V SALA
E sono sempre i modelli della Grecia classica ad essere ben presenti anche nel già sopra citato San Sebastiano curato dagli angeli del 1601 - 1602. Anche qui, infatti, Rubens rielabora a modo suo il canone classico della scultura greca di Policleto (460 - 420 a.C.) di cui è emblematica la posa tipica del Doriforo, con la gamba sinistra arretrata ed il peso del corpo tutto caricato sulla gamba destra lungo la quale è abbandonato il braccio destro: a comporre una struttura incrociata di tensione e rilassamento della muscolatura che suggerisce il movimento senza tuttavia far perdere alla figura compostezza e carattere monumentale.
 A sua volta il San Sebastiano di Rubens è l’evidente modello del San Sebastiano curato dalle pie donne del 1622 di Simon Vouet (Parigi, 9 gennaio 1590 - 30 giugno 1649).
A sua volta il San Sebastiano di Rubens è l’evidente modello del San Sebastiano curato dalle pie donne del 1622 di Simon Vouet (Parigi, 9 gennaio 1590 - 30 giugno 1649).
Contrariamente a quanto in genere si pensa, il martirio così frequentemente raffigurato di questo santo milanese del III secolo, comandante degli arcieri dell’esercito di Diocleziano e condannato a morte trafitto dalle frecce per essersi convertito al cristianesimo, non gli fu fatale.
Le sue ferite vennero infatti curate e per questo il suo culto era molto diffuso fin dal VII secolo ed a lui ci si affidava nei tempi in cui la peste imperversava per l’Europa.
Dal punto di vista pittorico fu un soggetto che riscosse un grande favore da parte degli artisti dal Quattrocento al Seicento.
La variante fra le versioni di Rubens e di Vouet dipende dal fatto che nella cultura popolare latina la tradizione voleva che a curarlo fossero stati degli angeli, mentre nel Nord Europa si riteneva che questo compito fosse stato svolto da Irene assieme ad altre pie donne della comunità cristiana di Roma.
VI SALA
Concludono la sezione dei Santi come eroi due confronti in duplice senso cronologico: ascendente e discendente.
 Il primo è la Maddalena in estasi del 1606, sorretta dagli angeli e colpita dal fascio di luce dell’amore divino in una stanza in penombra che non può non far pensare a Caravaggio. Non abbiamo la certezza che sia stata vista da Bernini, però la Santa Teresa D’Avila del 1650 ca. in terracotta patinata realizzata da Gian Lorenzo e bottega è un non trascurabile indizio a favore.
Il primo è la Maddalena in estasi del 1606, sorretta dagli angeli e colpita dal fascio di luce dell’amore divino in una stanza in penombra che non può non far pensare a Caravaggio. Non abbiamo la certezza che sia stata vista da Bernini, però la Santa Teresa D’Avila del 1650 ca. in terracotta patinata realizzata da Gian Lorenzo e bottega è un non trascurabile indizio a favore.
RUBENS E BERNINI
Pressoché coetaneo di Pietro da Cortona, Gian Lorenzo Bernini, si trasferisce a Roma da Napoli attorno al 1605, a soli sette anni, il che fa escludere che abbia potuto conoscere Rubens, con il quale è stato tuttavia messo a confronto da più studiosi.
Mina Gregori, osservando che il giovane Bernini potesse avere accesso, presso Scipione Borghese, protettore romano di Rubens, a disegni e modelli dell’artista fiammingo, li trova uniti dal medesimo stile concitato che, come si è visto nelle grandi pale della Chiesa Nuova, “assume il carattere di un esempio di inedita grandiosità in movimento, di un’antichità reinterpretata al presente”.
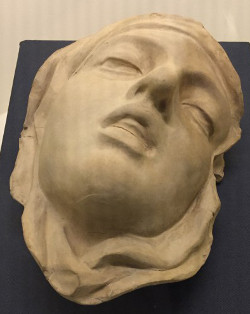 A suo modo di vedere “l’elemento che lega i due artisti va individuato soprattutto nella comune idea naturalistica dell’antico, che supera l’immobilità della pietra in favore della verosimiglianza di corpi e sentimenti, lontani dall’«effetto di sasso dipinto»”.
A suo modo di vedere “l’elemento che lega i due artisti va individuato soprattutto nella comune idea naturalistica dell’antico, che supera l’immobilità della pietra in favore della verosimiglianza di corpi e sentimenti, lontani dall’«effetto di sasso dipinto»”.
 Anche Francesco Petrucci si sofferma sull’argomento con una serie di approfonditi confronti nei quali sottolinea come “la nuova concezione spaziale dilatata di Rubens sia riproposta già nelle prime opere di Bernini” e come “i due condividano la stessa visione dinamica e anticonformista dell’antico”.
Anche Francesco Petrucci si sofferma sull’argomento con una serie di approfonditi confronti nei quali sottolinea come “la nuova concezione spaziale dilatata di Rubens sia riproposta già nelle prime opere di Bernini” e come “i due condividano la stessa visione dinamica e anticonformista dell’antico”.
Inoltre ricorda gli assai precoci studi su questi temi di Valentino Martinelli del 1952, poco conosciuti se non ignorati, nei quali l’autore sottolineava il forte contributo di Rubens all’arte di Bernini, proponendo confronti efficaci quali la grande scultura del San Longino realizzata per la basilica di San Pietro ed a suo parere modellata sul san Mauro della pala della Chiesa Nuova.
Infine Giuliano Briganti affronta diffusamente l’argomento nella sua monografia su Pietro da Cortona ed in essa afferma che l’opera di Rubens contiene già tutto lo spirito della successiva generazione degli anni trenta, di cui può considerarsi «il vero padre».
Variamente concatenati sono, infine, gli ultimi tre dipinti della sala.
 Il più antico è, paradossalmente, il più recente. Si tratta infatti dell’Adorazione dei pastori, detta La notte, di Correggio (Antonio Allegri detto il Correggio, Correggio RE, c. 1489 - Correggio, 5 marzo 1534) presente però in mostra nella copia dall’originale realizzata per la chiesa di San Prospero a Reggio Emilia da Giuseppe Nogari (Venezia, 1699 - 3 giugno 1763), esponente del Rococò.
Il più antico è, paradossalmente, il più recente. Si tratta infatti dell’Adorazione dei pastori, detta La notte, di Correggio (Antonio Allegri detto il Correggio, Correggio RE, c. 1489 - Correggio, 5 marzo 1534) presente però in mostra nella copia dall’originale realizzata per la chiesa di San Prospero a Reggio Emilia da Giuseppe Nogari (Venezia, 1699 - 3 giugno 1763), esponente del Rococò.
Se il Barocco è anche “i piedi sporchi” della Madonna dei Pellegrini di Caravaggio, non di meno è lo stupore della bellezza delle chiese dei gesuiti nelle quali sembra che gli angeli ci cadano addosso dall’alto.
Ed è proprio quello che accade in Correggio e che Rubens riprende nell’Adorazione dei pastori del 1608 per la chiesa dei Filippini a Fermo, sua ultima opera realizzata in Italia ed oggi conservata nella locale Pinacoteca Civica all’interno del Polo museale di Palazzo dei Priori.
Conservata si fa per dire… visto che, prima dell’attuale mostra, a Milano c’era già stata nel dicembre 2015 per la tradizionale esposizione natalizia nella sede comunale di Palazzo Marino. Iniziativa per diverse ragioni discutibile ma che, nell’occasione, ebbe il merito di un allestimento che cercava di restituire la visione che dell’opera si poteva avere nella chiesa per la quale era stata realizzata.
 Quest’opera riassume in sé le suggestioni della pittura veneta, di Caravaggio e dell’antico rievocando, ed insieme reinventando, pose, fisionomie e sfondi.
Quest’opera riassume in sé le suggestioni della pittura veneta, di Caravaggio e dell’antico rievocando, ed insieme reinventando, pose, fisionomie e sfondi.
“La creatività grandiosa e razionale di Rubens” gli permette infatti di realizzare “una sintesi unica fra innumerevoli spunti, attraverso una cifra del tutto personale e innovativa”.
Della “Notte” di Correggio Rubens “riprende l’impianto generale, la luce notturna e la gloria degli angeli in volo”. Con un effetto però totalmente differente perché “al sentimento bucolico dell’originale oppone il movimento impetuoso, il chiaroscuro intenso e la grandiosità statuaria dei personaggi tipici dell’antico”.
I suoi angeli, ad esempio, sono in minor numero ma più incombenti sulla scena sottostante, in particolare con l’angelo di sinistra di cui Rubens inverte la direzione proiettandolo verso terra.
Altro elemento dal quale si fa ispirare è la luce divina che il Bambino irradia attorno a sé illuminando tutti gli astanti.
Un bambino di cui non vediamo il viso in Correggio, che lo propone cullato dalla Madre, e che in Rubens è chiara prefigurazione della sua morte per la posizione e per il lenzuolino-sudario di cui Maria solleva i lembi con un elegante movimento incrociato delle braccia, all’apparenza più per ricoprirlo che per rivelarlo a chi è venuto ad adorarlo.
Nell’uno e nell’altro caso tornano sotto di lui le spighe già viste nella Resurrezione come simbolo eucaristico.
Per quanto riguarda le altre figure: Giuseppe, defilato sullo sfondo in Correggio, in Rubens diventa la giunzione fra la terra ed il cielo verso cui leva lo sguardo.
I due pastori, figure monumentali e possenti nella loro muscolatura, sono ripresi quasi fedelmente se non per le minime variazioni che Rubens sempre introduce nel reinterpretare i suoi modelli. In questo caso lo fa trasformando l’espressione del giovane in accorata, da serena che era in Correggio, e con ironia invertendo il movimento delle braccia del pastore in piedi: che in Rubens si ripara il viso con la mano sinistra per proteggere lo sguardo dalla luce che viene dal Bambino mentre in Correggio si toccava la nuca perplesso con la destra.
A completare la scena Rubens aggiunge una terza figura femminile (una balia?) che chiude la composizione sullo sfondo (al posto dell’asino in Correggio), mentre accomuna i due artisti la levatrice: che in Correggio è giovane e si ritrae diffidente mentre in Rubens è un’anziana donna che protende verso il Bambino le palme delle mani ed indirizza a Maria uno sguardo pieno di riconoscente tenerezza.
LA LEVATRICE
È un personaggio che i vangeli canonici non citano ma che, come spesso accade per i soggetti delle opere d’arte, si trova nei vangeli apocrifi.
Il suo nome è Salomè e si narra non credesse alla verginità conservata da Maria anche dopo il parto e che la volesse “verificare con mano”.
A causa di questa incredulità perde all’istante l’uso delle mani ma l’infermità sarà subito sanata dalla Madonna che, impietosita, la perdona e la guarisce facendole toccare il neonato.
Si tratterebbe quindi del primo miracolo di Gesù, di molti anni precedente quello delle nozze di Cana.
Questa figura per molto tempo è stata dipinta nelle Natività con la mano inerte. Se ne conoscono almeno una cinquantina di esempi, l’ultimo dei quali, allo stato attuale delle ricerche, sarebbe proprio quello appena descritto.
 Riconosciute come si è visto le ascendenze di questa Adorazione dei pastori, prototipo ripreso dallo stesso Rubens in una rivisitazione che lo porta verso nuovi traguardi, come nel caso dell’Adorazione dei magi del Museo del Prado, dipinta nel 1609 e ampliata dallo stesso autore nel 1628-1629, sulla parete accanto se ne può verificare l’eredità.
Riconosciute come si è visto le ascendenze di questa Adorazione dei pastori, prototipo ripreso dallo stesso Rubens in una rivisitazione che lo porta verso nuovi traguardi, come nel caso dell’Adorazione dei magi del Museo del Prado, dipinta nel 1609 e ampliata dallo stesso autore nel 1628-1629, sulla parete accanto se ne può verificare l’eredità.
Anche questa composizione esercitò infatti una fortissima suggestione sugli artisti più giovani, come ci appare chiaramente dal confronto con l’Adorazione dei pastori (immagine in basso) dipinta per la chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma da Pietro da Cortona (Pietro Berrettini, Cortona, 1º novembre 1596 - Roma, 16 maggio 1669).
RUBENS E PIETRO DA CORTONA
Abbiamo già visto come Fetti, attorno al 1611, sia stato tra i primi a intraprendere la strada di declinare l’antico nella pittura di soggetti sacri. Poco dopo lo seguì, all’incirca nel 1613, Pietro da Cortona, appena giunto a Roma ed agli inizi della sua attività di pittore alla scuola prima di Andrea Commodi e poi del maestro Baccio Ciarpi, quest’ultimo attivo nella stessa Chiesa Nuova.
“Sia Cortona sia Ciarpi sono strettamente inseriti nell’ambiente dell’Oratorio, crocevia di profonda spiritualità e di professione di vita devota, abbracciata da entrambi i pittori, che accompagnano la prassi di carità alla diligente operosità artistica, in un clima condiviso da tanti protagonisti. Nella chiesa le suggestioni e gli impulsi erano davvero infiniti, quasi una summa delle tendenze figurative più in auge nello scorcio del secolo, di cui la decorazione di Rubens mostrava il lato sorprendentemente avanzato.
Sono anni per Cortona di lenta e graduale formazione - quasi in contrasto con quella maniera veloce e prorompente che lo caratterizza e con cui ci è noto - anni in cui si sedimentano le sue prime invenzioni e si forma una profonda conoscenza dell’arte antica, praticata nel disegno dal vero, come del resto in Rubens.
Nei dipinti dell’artista si fa luce, ma all’inizio solo timidamente, l’interpretazione consapevole della maniera di Rubens, come possiamo vedere in uno dei suoi primi quadri documentati, Cristo e l’adultera - Roma, collezione privata - eseguito su committenza di Asdrubale Mattei nel 1626. La scena è composta secondo un andamento a registro ancora fortemente orizzontale, con la parte destra densa di reminiscenze toscane, ma con un’imprevedibile prima incursione nel mondo di Rubens nelle due figure grandiose dell’adultera e del soldato romano dietro di lei. Entrambe appaiono dilatate in un movimento solenne e instabile e il soldato, dalla bella testa barbuta, è un’evidente citazione dalla ritrattistica romana. Cortona non ha fatto altro che prendere la testa di Mauro, o Papiano, della pala di Rubens e ripresentarla nella tela per casa Mattei: il risultato incontrerà in pieno le aspettative del committente, che lo premierà per questo, a fronte di un compenso concordato davvero esiguo.
 Negli stessi anni, il riferimento a Rubens appare dichiarato nell’Adorazione dei pastori - dipinta probabilmente per gli Orsini nella chiesa di San Salvatore in Lauro - per la quale l’artista elegge a modello la famosa tela sullo stesso tema eseguita da Rubens nel 1608 per gli oratoriani di Fermo: che l’avevano molto apprezzata ed era certamente nota al più giovane Cortona attraverso incisioni e, forse, copie”.
Negli stessi anni, il riferimento a Rubens appare dichiarato nell’Adorazione dei pastori - dipinta probabilmente per gli Orsini nella chiesa di San Salvatore in Lauro - per la quale l’artista elegge a modello la famosa tela sullo stesso tema eseguita da Rubens nel 1608 per gli oratoriani di Fermo: che l’avevano molto apprezzata ed era certamente nota al più giovane Cortona attraverso incisioni e, forse, copie”.
In quest’opera del pittore toscano ritroviamo sia lo stesso soggetto, sia una rievocazione delle invenzioni di Rubens.
“La figura della Vergine, di una stessa bellezza carnosa e marmorea insieme, di derivazione statuaria rivisitata con prorompente vitalità”. Gli angeli, anche se meno numerosi e dinamici. E soprattutto l’utilizzo, come fulcro luminoso di tutta la rappresentazione sacra, della centralità del Bambino “intriso di luce”: ancora deposto sulle spighe di grano e di cui si enfatizza ancora più esplicitamente il destino con l’introduzione di un terzo pastore che, tenendolo per le zampe eloquentemente legate, depone ai suoi piedi un agnello sacrificale.
“Proprio in questa interpretazione delle sollecitazioni del mondo antico, da rivivere in maniera concitata, al presente, eludendo ogni intento dichiaratamente filologico, si va stabilendo il filo che lega i due artisti.
Un percorso che porterà Cortona a un uso spregiudicato e vario del mondo della mitologia e della storia, cui attingere liberamente, combinando insieme soggetti e scene, come nella volta Barberini e nelle sale di palazzo Pitti, vicino in questo alla «gigantesca fantasia» di Rubens”.
L’onda lunga del grande ascendente esercitato sulle generazioni dei più giovani dall’Adorazione dei pastori di Fermo arriva fino alla fine del Seicento con la pala di Gaulli, dipinta nel 1687 sempre per la città di Fermo, destinata alla chiesa di Santa Maria del Carmine e oggi nella Pinacoteca Civica. Moltiplicati i personaggi ed accentuati gli scorci, i lampi di luce che si accendono prendono tutti ugualmente corpo dalla piccola chiarissima figura del Bambino.
Che siano dunque di soggetto sacro, come abbiamo visto, o profano, come quelle che vedremo, le opere italiane di Rubens sono tutte “esempi di inedita grandiosità in movimento, di visione dinamica e dilatata dello spazio, d’interpretazione anticonformista dell’antico dense di una vitalità impetuosa” che con pieno diritto fanno di lui uno dei precursori del Barocco.
IL FURORE NEL PENNELLO
In una lettera a William Trumbull del 13 settembre 1621 Rubens infatti scrive: «Un’opera, per quanto in essa sia grande il numero e la varietà delle cose da raffigurare, non ha mai superato il mio coraggio» confermando la consapevolezza che egli aveva di quanto fosse innovativa, rivoluzionaria e veemente la propria creatività.
Rapidità di esecuzione e visione concitata ed unitaria della composizione, alla quale si può concedere di deliberatamente sacrificare il dettaglio per amplificare l'effetto dell'insieme, sono infatti diretta conseguenza del carattere dell’artista che il suo biografo, Giovan Pietro Bellori, gli riconosce: «Alla copia delle sue invenzioni e dell’ingegno, aggiunta la gran prontezza e la furia del pennello, si stese la mano di Rubens a tanto gran numero d’opere che ne sono piene le chiese ed i luoghi di Fiandra. […] Ebbe egli natural dono, spirito vivo, ingegno universale» (Le vite de’ pittori scultori e architetti moderni - Roma 1672). Questa definizione dello stile di Rubens condensa con efficacia la descrizione che lo stesso Bellori fa del suo modo di dipingere: «Colorì dal naturale e fu veemente nelle mistioni, radiando il lume con la contrarietà dei corpi ombrosi, sicché fu mirabile nelle opposizioni dell’ombre e dei lumi. Si mantenne così unito e risoluto che sembrano le sue figure eseguite in un corso di pennello ed inspirate in un fiato [...] Ebbe egli ingegno universale [...]».
“Cogliendo pienamente la portata rivoluzionaria della sua pittura impetuosa, con l’aggettivo «universale» Bellori vuole mettere in luce l’innovativa visione di Rubens. Ciò che conta è la rapidità di lettura e di esecuzione, alimentata da tutti gli artifici che l’artista inventa con la sua fantasia e il suo ingegno”.
Anche Baglione, che ne loda i ritratti equestri, «alti quanto al vivo, con amore condotti e similissimi et in quel genio hebbe egli pochi pari», conclude poi scrivendo che «è stato pittore universale & abbondante».
Per quanto fin qui argomentato non sorprende poi il ritrovare la parola «universale», con espressioni molto vicine a quelle usate per Rubens, nelle vite dei giovani artisti barocchi. Nella biografia di Pietro da Cortona, alla sua pittura di getto Passeri riconosce proprio che: «[...] ha avuto un ottimo universale», ovvero “una concezione unitaria e complessiva dell’invenzione figurativa. Sottolineando come nel disegno non possa essere paragonato a Michelangelo, ne loda tuttavia la capacità”: «di far vive, e belle le teste delle femmine, dei putti, dei giovani, o de vecchi [...] arie torbide, serene, nuvoli, piogge, splendor di sole, ed altre cose infinite».
Una critica ed insieme un complimento sorprendentemente simili a quanto Bellori aggiunge a quanto sopra citato: «Si può opporre a Rubens di aver mancato alle belle forme naturali per la mancanza del buon disegno [...]».
Analogamente, più tardi, Lione Pascoli dedicherà all’artista toscano una formula in tutto simile a quella coniata da Bellori per Rubens: «Aveva il fuoco ne’colori, la veemenza nelle mani, l’impeto nel pennello».
Venendo, infine, a Lanfranco, si è già sopra ricordato che Bellori ne descrive la cupola di Sant’Andrea della Valle come «una piena musica, quando li tuoni insieme fanno l’armonia, ma piace il misto e l’universale misura», “riutilizzando questo vocabolo denso di un preciso significato, che non si può, a questo punto, non mettere in relazione con l’idea ed il senso estetico più profondo della pittura barocca avviata da Rubens.
Come ricorda Burckhardt, l’amplificazione è una macchina potentissima per muovere la fantasia e l’immaginazione e per produrre tale effetto la tecnica acquista un ruolo prioritario”.
In mostra la “furia del pennello” è documentata da una serie di dipinti di soggetto e composizione molto varia ma che ci consentono di verificare dal vero queste affinità.
VII SALA
 Si comincia con la Conversione di Saulo (1601 - 1602) che, da vicenda individuale e privata diventa un episodio in cui sono coinvolti tutti i presenti (alcuni dei quali in sella a cammelli): che guardano con preoccupato stupore verso il Cristo che irrompe dal cielo, cercano di proteggersi dalla folgorante luce divina o tentano di soccorrere Saulo caduto accanto al suo cavallo stramazzato a terra.
Si comincia con la Conversione di Saulo (1601 - 1602) che, da vicenda individuale e privata diventa un episodio in cui sono coinvolti tutti i presenti (alcuni dei quali in sella a cammelli): che guardano con preoccupato stupore verso il Cristo che irrompe dal cielo, cercano di proteggersi dalla folgorante luce divina o tentano di soccorrere Saulo caduto accanto al suo cavallo stramazzato a terra.
Chi se ne intende vi nota l’eco della cultura figurativa italiana e, nella generale concitazione, una grandiosa instabilità.
 Vorticosa, quasi come una giostra lanciata a tutta velocità, è la Battaglia dello stendardo (1605): copia del nucleo centrale dell’affresco (sotto proposto in una sua recente ipotesi di ricostruzione) che, nel salone dei Cinquecento del Palazzo della Signoria (più noto come Palazzo Vecchio) di Firenze, Leonardo da Vinci dedicò alla Battaglia di Anghiari del 1440; episodio conclusivo, e per Firenze vittorioso, della guerra combattuta contro i Visconti di Milano che segnò l’ascesa della potenza medicea.
Vorticosa, quasi come una giostra lanciata a tutta velocità, è la Battaglia dello stendardo (1605): copia del nucleo centrale dell’affresco (sotto proposto in una sua recente ipotesi di ricostruzione) che, nel salone dei Cinquecento del Palazzo della Signoria (più noto come Palazzo Vecchio) di Firenze, Leonardo da Vinci dedicò alla Battaglia di Anghiari del 1440; episodio conclusivo, e per Firenze vittorioso, della guerra combattuta contro i Visconti di Milano che segnò l’ascesa della potenza medicea.
Questa battaglia coinvolse alcune migliaia di soldati e vide i milanesi in fuga a fine giornata: abbagliati dal sole al tramonto ed in difficoltà nel combattere perché rivolti a sfavore di vento, che riempiva i loro occhi della polvere sollevata dal campo di battaglia.
Fu importante più per Firenze che per Milano. La prima, in caso di sconfitta, avrebbe perso l’indipendenza, la seconda perse solo armamenti non difficilmente rimpiazzabili… beninteso pagando!
È curioso ricordare che Machiavelli, sottolineando che entrambe le schiere erano costituite da mercenari che, come prassi del tempo, stavano molto attenti nell’evitare di danneggiarsi troppo, osservò che “non vollero reciprocamente farsi del male”, come testimonia il fatto che, fra le migliaia di combattenti, vi fu solo un morto: caduto da cavallo e calpestato nella confusione!

Rubens realizzò la copia da una stampa del ‘500 in suo possesso, perché al suo tempo la Battaglia originale era già stata coperta da uno degli affreschi che Giorgio Vasari (Arezzo, 1511 - Firenze, 1574) dipinse nel salone dei Cinquecento e raffiguranti sei scene di battaglie che videro il suo committente Cosimo I de’ Medici (1519-1574) vittorioso sulle repubbliche di Pisa e di Siena.
 Per essere precisi, a coprire l’affresco di Leonardo (o quel che ne restava perché presto deperito per la tecnica innovativa ma poco durevole utilizzata dall’artista) è “La battaglia di Scannagallo” (nel comune di Marciano, in provincia di Arezzo) in un punto della quale (al centro appena sotto le prime colline coronate da edifici), su una bandiera verde, si leggono le due parole “cerca trova”, forse un indizio che rimanda a Leonardo.
Per essere precisi, a coprire l’affresco di Leonardo (o quel che ne restava perché presto deperito per la tecnica innovativa ma poco durevole utilizzata dall’artista) è “La battaglia di Scannagallo” (nel comune di Marciano, in provincia di Arezzo) in un punto della quale (al centro appena sotto le prime colline coronate da edifici), su una bandiera verde, si leggono le due parole “cerca trova”, forse un indizio che rimanda a Leonardo.
Più vicina nel tempo all’originale e nostro termine di paragone è la cosiddetta Tavola Doria (1503-05), nel 2012 ritornata nelle proprietà italiane e conservata agli Uffizi. Incompleta e dipinta su fondo oro si ritiene riproduca il nucleo focale, la lotta per la conquista dello stendardo di Firenze, del ben più grande lavoro di Leonardo.
La scena rappresenta mirabilmente, come forse mai era stato fatto prima nella pittura storica di guerra, quanto essa sia una "pazzia bestialissima", come la definiva il suo artefice. Ci viene, infatti, mostrata una feroce contesa su tre livelli che si lascia intendere non avrà mai fine.
 A quello superiore i cavalieri: le sciabole levate, i visi deformati da smorfie, la bocca aperta nelle urla che accompagnano il colpo sferrato sul nemico… ed al centro tre mani afferrano e stringono la lancia spezzata che diventa il supporto diametrale di una giostra in vorticosa rotazione attorno al suo asse verticale sotto la spinta delle forze contrapposte dei soldati e dei cavalli.
A quello superiore i cavalieri: le sciabole levate, i visi deformati da smorfie, la bocca aperta nelle urla che accompagnano il colpo sferrato sul nemico… ed al centro tre mani afferrano e stringono la lancia spezzata che diventa il supporto diametrale di una giostra in vorticosa rotazione attorno al suo asse verticale sotto la spinta delle forze contrapposte dei soldati e dei cavalli.
Nei quattro guerrieri, procedendo da sinistra verso destra, c’è chi ha individuato Francesco Piccinino e suo padre Niccolò (col berretto rosso), comandanti dell’esercito milanese, e quindi Ludovico Scarampo Mezzarota e Pietro Giampaolo Orsini, capi delle truppe papali e fiorentine alleate.
A livello del terreno accade lo stesso: anche se questa volta è disposto orizzontalmente l’asse attorno al quale due fanti rotolano avvinghiati e lottando a mani nude. Un terzo, sulla sinistra, cerca di scivolare di lato, strisciando sulle ginocchia e proteggendosi con lo scudo sollevato, per sottrarsi ai colpi che gli possono arrivare dagli zoccoli dei cavalli inalberati.
È noto quanto Leonardo avesse studiato la struttura e la muscolatura dei cavalli in relazione al loro movimento ed anche in questa composizione ce ne dà una prova di grande qualità.
Anche gli animali, infatti, partecipano al dramma della battaglia: le zampe posteriori contratte nella spinta che precede il balzo, quelle anteriori accavallate a quelle del destriero avversario, le teste che si spingono e quasi si fondono l’una nell’altra, riconoscibili solo per il diverso colore, e con gli occhi sbarrati: specchio del terrore che provano e che è lanciato al cielo dall’acuto nitrito che prorompe dalle mandibole spalancate del muso “prepicassiano” che si intravede in secondo piano fra gli elmi e le spade.
 Tutto questo si ritrova in Rubens: dallo spazio dinamico, all’ambientazione all’aperto e sotto il cielo tempestoso di una natura tumultuosa, come in Tiziano e Tintoretto, ma senza punti di riferimento e, soprattutto, isolata dal contesto della Battaglia che Leonardo non poteva non aver accuratamente dipinto.
Tutto questo si ritrova in Rubens: dallo spazio dinamico, all’ambientazione all’aperto e sotto il cielo tempestoso di una natura tumultuosa, come in Tiziano e Tintoretto, ma senza punti di riferimento e, soprattutto, isolata dal contesto della Battaglia che Leonardo non poteva non aver accuratamente dipinto.
L’altra personalizzazione, che ormai ci siamo abituati ad aspettarci immancabile nelle “rielaborazioni” di Rubens, è questa volta una trasposizione cronologica.
La battaglia non avviene più fra fazioni nemiche delle Signorie italiane, ma assume una portata internazionale diventando emblema della guerra dei Cristiani contro gli infedeli. Interpretazione dettata dalle tre falci dorate di luna, simbolo dell’esercito musulmano, ben evidenti sullo stendardo rosso che sventola sulla destra.
Tornando ai cavalli, imponente ed innovativo, è quello cavalcato da Gio(vanni) Carlo Doria, mecenate e committente genovese dell’opera e che ricordavamo averci già colpiti nella sua collocazione consueta: la Galleria di Palazzo Spinola a Genova. Collocazione per una volta appropriata. Infatti Giovanni Carlo Doria, figlio del Doge Agostino, sposò Veronica Spinola, a sua volta figlia di Ambrogio Spinola che servì la corona di Spagna come generale. Alla sua collezione di 463 dipinti oltretutto apparteneva anche la sopra citata “Tavola Doria”.
 Con quest’opera Rubens rivoluziona il ritratto equestre. Fino al ‘400, infatti, il cavaliere era raffigurato di profilo ed il cavallo al passo. Qui invece ce li troviamo dipinti con un’inquadratura frontale dalla quale prorompe l’esplosiva energia del destriero impennato, di cui è resa meravigliosamente la coda in controluce su uno sfondo di grigie nubi tempestose sospinte dal vento che agita il drappo rosso, legato al braccio del committente, e le fronde degli alberi dietro i quali il sole dardeggia i suoi raggi.
Con quest’opera Rubens rivoluziona il ritratto equestre. Fino al ‘400, infatti, il cavaliere era raffigurato di profilo ed il cavallo al passo. Qui invece ce li troviamo dipinti con un’inquadratura frontale dalla quale prorompe l’esplosiva energia del destriero impennato, di cui è resa meravigliosamente la coda in controluce su uno sfondo di grigie nubi tempestose sospinte dal vento che agita il drappo rosso, legato al braccio del committente, e le fronde degli alberi dietro i quali il sole dardeggia i suoi raggi.
A dire la verità, non proprio coerente con la scena è il portamento del cavaliere, un po’ troppo statico rispetto al movimento dell’animale di cui regge le redini fra le dita con un gesto un po’ troppo delicato rispetto a quello che sembrerebbe necessario per governarlo.
Un tocco di simpatico umorismo lo notiamo nel cagnolino che, sotto le zampe del cavallo, ne imita la posa. La sua presenza è poi il primo e più evidente elemento simbolico del dipinto fra i molti altri che contiene. Il suo rinviare alla virtù della fedeltà si accompagna, infatti, alla presenza della quercia, dell’ulivo e dell’edera: ad evocare rispettivamente coraggio, nobiltà d’animo e lealtà.
Altri simboli presenti sono l’aquila di casa Doria e, sul petto, l’emblema dell’ordine di San Giacomo, cavalierato al quale fu ammesso dal Re di Spagna Filippo III d’Asburgo. E proprio alla gratitudine di Giovanni per questa concessione si riferiscono le cicogne, simbolo di pietà, e Filippo III era infatti noto anche come Filippo il Pio.
Tutta la novità di questo nuovo modo, intenso e sintetico, di comporre è colta da Pietro da Cortona e Luca Giordano nei quali ritroviamo altri cieli sconquassati e scene turbinose.
“Gli angeli segnano la fronte a coloro che devono essere illesi dai flagelli” (Roma, Museo della Fondazione Roma) è il soggetto apocalittico commissionato al primo nel 1652 per la decorazione a mosaico della cupola della prima campata nella navata destra di San Pietro. Il suo grande bozzetto in mostra “riassume in maniera stringente proprio questi precetti” e trova un precedente in un famoso dipinto di Rubens del 1606, Ero e Leandro, opera notissima per essere stata celebrata anche in un sonetto nel poema di Marino La galeria, pubblicato nel 1619 a Venezia.
In Cortona un angelo si libra al centro della scena reggendo nella mano una croce che sembra una luce al neon. Alla sua destra una figura umana, personificazione del vento, emerge a torso nudo dalle nubi gonfiando le gote per soffiare un getto d’aria. Tutto intorno, sotto un cielo sempre cupo, altri angeli segnano la fronte a uomini e donne che, su barche o inginocchiate sulla terraferma, con le mani giunte rivolte al cielo impetrano il salvacondotto.
Nel suo bozzetto il pittore toscano “asseconda pienamente l’energia catalizzante del dipinto di Rubens senza forza di gravità, in cui le figure si muovono incalzate da un dinamismo irrefrenabile in un’assoluta mancanza di punti fermi, sullo sfondo di una natura tempestosa. In entrambi i dipinti, il cielo, corrusco in Cortona, notturno in Rubens, appare solcato da lampi con bagliori accesi; i personaggi sospesi nell’atmosfera si mescolano al vortice del paesaggio naturale, dipinti con tratti veloci e sfumati in Cortona, uniti in un inconsueto grappolo in Rubens, in una composizione che Nicole Dacos definisce a metà tra Michelangelo e Tintoretto. In entrambi manca completamente un punto fermo e un principio d’ordine e simmetria: tutto scorre”.
Altra scena apocalittica è la visione cosmica di San Giovanni Evangelista a Patmos di Luca Giordano (Napoli, 18 ottobre 1634 - Napoli, 12 gennaio 1705)
RUBENS E LUCA GIORDANO
Per Luca Giordano, il più giovane dei pittori dei quali ci stiamo occupando, Rubens “è un mito, un punto di riferimento da omaggiare, di cui conosce l’opera per la grande fama suscitata a Napoli da alcuni suoi capolavori appartenenti a varie collezioni ed in casa del mercante Gaspar Roomer. Un’influenza ben riconosciuta già da altri studiosi che, nei primi decenni del Novecento, parlavano di «dipinti sotto l’impressione di qualche focosa opera di Rubens» e scrivevano di «ardore rubensiano», trovando conferme in altre coincidenze professionali.
La rapidità del fare, famosa in Giordano, corroborata da un forte entusiasmo, sono elementi comuni che portano entrambi gli artisti ad avere un catalogo di opere vastissimo, quasi un migliaio per Rubens, poco meno per Giordano. Ci sono poi i dipinti che Luca Giordano compone guardando Rubens e riprendendone l’invenzione, come il grandioso Massacro degli innocenti, in collezione privata napoletana, che si rifà allo stesso tema trattato da Rubens nel quadro in mostra, noto probabilmente da un’incisione di Paul Pontius del 1643.
Lo stesso avviene anche nelle scene di battaglia realizzate da Giordano, che sembrano rileggere precedenti famosi di Rubens, come la Conversione di Saulo (Liechtenstein, The Princely Collections) in mostra. Lo stesso vortice di elementi, di uomini e cavalli, di armi, in una pittura fragorosa, che evoca l’epica più che la poesia del binomio «ut pictura poesis». Dopo la precoce Battaglia dello stendardo appena vista, Rubens si era dedicato più volte a scene turbinose mosse da uno stesso interesse per la fragorosa manifestazione di un contrasto di impulsi drammatico e universale. Ne sono esempi la Caduta di Fetonte (Washington, National Gallery of Art), messa in relazione con Ero e Leandro, e la famosa Battaglia delle amazzoni (Monaco, Alte Pinakothek).
Giordano conosce certamente questa produzione e se ne ispira più volte, come nel caso della sua stessa Conversione di Saulo (Napoli, collezione privata), o nel bozzetto della Visione di san Giovanni evangelista a Patmos (Napoli, collezione privata), in cui schiarisce la gamma dei colori, ma ripropone la costruzione aerea e in continua rotazione di Rubens”.
Ad accentuare il moto rotatorio del tutto è la stessa forma circolare del dipinto. Le pennellate spesse dell’artista rappresentano l’evangelista di spalle con accanto, ad ali dispiegate, l’aquila che lo identifica.
Sopra di lui scene dell’Apocalisse si susseguono in verticale, a diversi piani di una rupe che, salendo, diventa nube. Dalle più note, come la Vergine in piedi sulla falce di luna ed il drago a sette teste, all’arcangelo Michele che lo combatte con la spada infuocata, a due angeli sulla sinistra che saettano i demoni (o i dannati) abbattuti che precipitano verso il basso e, sopra tutto, Dio padre assiso sul suo trono attorniato da altri angeli.
 Restando sempre nell’ambito dei soggetti sacri, torniamo a Rubens con Il massacro degli innocenti di cui in mostra, ad olio su tela, abbiamo la copia che la sua bottega realizzò dall’originale su tavola oggi a Toronto.
Restando sempre nell’ambito dei soggetti sacri, torniamo a Rubens con Il massacro degli innocenti di cui in mostra, ad olio su tela, abbiamo la copia che la sua bottega realizzò dall’originale su tavola oggi a Toronto.
In diverse figure di quest’opera, densa di energia compressa e forze contrapposte, continuiamo a riconoscere le ascendenze classiche.
La donna sulla destra con la mano alzata, seminascosta fra le possenti figure dei due carnefici in primo piano, è una derivazione dal prototipo scultoreo della Niobide “tipo Psiche” (in Mito e Natura la vicenda di Niobe e dei suoi figli: leggi di più >>>).
Quella di spalle dal lato opposto del gruppo rimanda alla Venere accovacciata (che vedremo alla Sala IX) mentre uno dei corpicini delle vittime è una citazione del Cupido addormentato in marmo dai Musei Capitolini. Ma al di là di questi riferimenti quello che più ci colpisce di questa massa umana sono le dita della madre che artigliano il volto di uno degli assassini nel disperato tentativo di proteggere il figlio e la terribile violenza del gesto del carnefice che solleva in alto il corpicino di un bambino prendendo lo slancio per ucciderlo scagliandolo a terra con una crudeltà atroce.
Lo schema compositivo del Massacro degli innocenti, in cui la scena digrada in primo piano verso lo spettatore, è di nuovo un modello per La fucina di Vulcano, ancora di Luca Giordano.
Mentre il dio è identificabile nell’uomo anziano in secondo piano e quasi defilato, al centro, solenne e sacra come un altare, si impone infatti l’incudine attorno alla quale si svolgono altre scene su diversi piani di profondità.
Due fabbri la colpiscono con i martelli (anche qui portati sopra la testa e fin dietro le spalle per caricare il colpo), mentre un terzo opportunamente si piega a terra “per non impallare la telecamera”.
In alto non ci è chiaro il riferimento ai due personaggi che potremmo identificare in due dei quattro dannati frequentemente presenti nell’iconografia del Seicento: i giganti Tizio, appeso a testa in giù con un’aquila che gli divora il fegato che si riforma ad ogni luna nuova, ed Issione, legato ad una ruota in eterno movimento nel cielo, riconosciuti con certezza in un’altra versione della Fucina di Vulcano di Luca Giordano.
 Chiarissima, e singolare per come è proposta, è invece la scena sulla destra: dietro un drappo Cupido favorisce il tradimento del marito che Venere, la sposa di Vulcano, sta mettendo in atto con Marte: che nonostante l’armatura ha più l’aria infida di un subdolo traditore che quella fiera del dio della guerra.
Chiarissima, e singolare per come è proposta, è invece la scena sulla destra: dietro un drappo Cupido favorisce il tradimento del marito che Venere, la sposa di Vulcano, sta mettendo in atto con Marte: che nonostante l’armatura ha più l’aria infida di un subdolo traditore che quella fiera del dio della guerra.
Ed è chiaro l’intento morale dell’opera: mettere in guardia chi insidia la donna altrui. Cosa che infatti fecero sia Tizio, istigato da Era (sempre gelosa per le avventure extraconiugali del consorte Zeus), nei confronti di Latona, sia Issione verso la stessa Era.
Meno chiara è la ragione della presenza di una seconda ruota… ce ne faremo una ragione.
 Dalle profondità della terra Rubens ci fa poi risalire verso l’Olimpo, con lo stesso Giove per ascensore! Lo vediamo, infatti, in forma di aquila, rapire per amore Ganimede (Ganimede e l'aquila 1611 - 1612, Vienna), secondo Omero il più bello fra i mortali del suo tempo; indifferente al fatto che questo giovane principe del popolo troiano (figlio di Troo re dei Dardani e di Calliroe, una delle naiadi, le ninfe delle acque dolci) sia un uomo.
Dalle profondità della terra Rubens ci fa poi risalire verso l’Olimpo, con lo stesso Giove per ascensore! Lo vediamo, infatti, in forma di aquila, rapire per amore Ganimede (Ganimede e l'aquila 1611 - 1612, Vienna), secondo Omero il più bello fra i mortali del suo tempo; indifferente al fatto che questo giovane principe del popolo troiano (figlio di Troo re dei Dardani e di Calliroe, una delle naiadi, le ninfe delle acque dolci) sia un uomo.
Su questa controversa relazione molto si è indagato e scritto. Qui ci limitiamo a riferire che da Platone venne interpretata come intesa intellettuale fra maestro ed allievo e nel Rinascimento vi si riconobbe la tensione dell’anima rapita dall’amore per Dio.
 Sulla destra Ebe, divinità della gioventù figlia di Zeus e di Era e fino ad allora enofora, l'ancella delle divinità alle quali serviva nettare e ambrosia (Iliade, libro IV), cede la coppa d’oro a Ganimede che ne prende il posto come coppiere degli dei.
Sulla destra Ebe, divinità della gioventù figlia di Zeus e di Era e fino ad allora enofora, l'ancella delle divinità alle quali serviva nettare e ambrosia (Iliade, libro IV), cede la coppa d’oro a Ganimede che ne prende il posto come coppiere degli dei.
Ruolo prefigurato in secondo piano in alto sulla sinistra con il banchetto per il quale Rubens ha avuto senz’altro come modelli di riferimento il Banchetto degli Dei per le nozze di Cupido e Psiche affrescato da Giulio Romano in Mantova, a Palazzo Te (1526 ca. - 1528 ca.), un disegno di Michelangelo e l’affresco di analogo soggetto di Raffaello in Vaticano.
Dove si trova anche il Laocoonte che, con il fanciullo di sinistra, è ulteriore dimostrazione di quanto la scultura classica sia sempre molto presente in Rubens, in questo caso per la figura di Ganimede. NB Anche i Milanesi possono ammirare dal vero questo celeberrimo gruppo marmoreo, nella copia esposta sullo scalone di accesso della Pinacoteca Ambrosiana.
Chiudono la sezione tre rappresentazioni di una lotta titanica fra un uomo ed un leone, proposte a breve distanza di tempo da Rubens, Bernini e Lanfranco e tutte interpretate con la stessa furia presente nella lotta tra l’eroe e la fiera.
 La prima, di Rubens (Ercole e il leone di Nemea), ci presenta Ercole (per i Greci Eracle) avvinghiato al leone di Nemea: primo avversario nella serie di prove che conosciamo come le 12 fatiche di Ercole alle quali l’eroe si sottopose per incarico del tiranno di Tirinto e sulle quali torneremo più avanti.
La prima, di Rubens (Ercole e il leone di Nemea), ci presenta Ercole (per i Greci Eracle) avvinghiato al leone di Nemea: primo avversario nella serie di prove che conosciamo come le 12 fatiche di Ercole alle quali l’eroe si sottopose per incarico del tiranno di Tirinto e sulle quali torneremo più avanti.
IL LEONE NEMEO - PRIMA FATICA DI ERACLE
Qui ci limitiamo a ricordare (utilizzando la nomenclatura della mitologia greca) che il leone di Nemea, o leone Nemeo, è un animale al quale diverse versioni del mito attribuiscono diverse origini. Poiché anche per l’antichità vale il detto “mater semper certa”, a generarlo fu Echidna, un enorme serpente con sembianze di bellissima fanciulla dalle anche in su.
Echidna viveva in una grotta nel paese degli Arimi, luogo mai bene identificato dagli autori classici e che poteva essere situato sia in oriente come in occidente.
Quanto al padre potrebbe essere Tifone: il figlio di Gea, la madre terra, e Tartaro.
Tifone era un mostruoso gigante, il più grande mai apparso sulla terra di cui contese il dominio allo stesso Zeus. La sua testa d’asino toccava le stelle e dai suoi occhi uscivano fiamme. Aveva ali tanto grandi da oscurare il sole e braccia che, allargate, coprivano cento leghe in ogni direzione e terminavano con innumerevoli teste di serpenti al posto delle mani. Dalle cosce in giù era, infine, tutto un groviglio di serpenti.
Con Echidna diede la vita a diversi mostri: Cerbero, il cane infernale a tre teste; l’Idra, serpente acquatico dalle molte teste che viveva a Lerna; la Chimera, capra che sputava fiamme, con testa di leone e coda di serpente; la Scrofa di Crommione; l’avvoltoio che torturò Prometeo; Ladone, il drago che sorvegliava i pomi d’oro delle Esperidi; Ortro, il cane a due teste di Gerione (mostro che di teste ne aveva 3 - su tre busti! – al quale, nella decima fatica Ercole sottrasse i pregiati buoi).
Secondo Esiodo, invece, fu proprio Ortro che giacque con la propria madre e generò in lei il Leone Nemeo e la Sfinge di Tebe.
Per altri autori il leone Nemeo potrebbe tuttavia essere anche fratellastro di Eracle in quanto figlio di Zeus e Selene.
Indispettita con il consorte per i suoi continui tradimenti, fu Era a far nascere il leone a Nemea, nel nord dell'Argolide (regione sud - orientale del Peloponneso), per distruggere Eracle. Insediatosi in una grotta con due uscite, l'animale attaccava e sbranava uomini e greggi diventando un flagello per il popolo di Nemea che, temendone la ferocia, smise di lavorare per non correre il rischio di incontrarlo.
Eracle invece si mise sulle sue tracce e lo raggiunse seguendo la scia di carcasse che il leone lasciava dietro di sé.
Affrontandolo si accorse che i suoi artigli e le sue zanne erano duri quanto il metallo e che spada e frecce erano inefficaci contro di lui perché la sua pelle, resistente al ferro e al fuoco, non poteva essere ferita in alcun modo, rendendolo di fatto invulnerabile. Per vincerlo allora Eracle rinunciò a queste armi ma decise di percuoterlo con una mazza per stordirlo e poi strangolarlo a mani nude.
Dopo averlo ucciso, proprio per avvalersi delle loro proprietà, Eracle tolse al Leone di Nemea la pelle e la testa per farsene una corazza ed un elmo con cui proteggersi in battaglia. Per procurarseli dovette però usare i suoi stessi artigli, unici strumenti capaci di scalfirli. Ecco dunque spiegati significato ed origine della pelle e della testa di leone che a volte troviamo dipinte sulle spalle o sul capo di Eracle.
Conclude questo approfondimento l’osservazione che, dopo la sua morte, Zeus pose il leone Nemeo tra i segni dello zodiaco, dove formò la costellazione del leone.
Tornando a Rubens, nel dipinto in mostra (proveniente da collezione privata inglese) raffigura, con l’aggiunta “per buon peso” di un leopardo morto sotto i suoi piedi, ed ispirandosi ad un antico bassorilievo posto sulla facciata rivolta al giardino di Villa Medici (dal 1803 sede dell’Accademia di Francia a Roma), proprio il momento culminante della prima fatica.
“La tela dipinta con quella furia del pennello della definizione belloriana, si incentra sulla lotta tra l’uomo e il leone avvinghiati in una sorta di abbraccio circolare, con le due teste vicine – gigantesca ed esangue quella del leone, contratta nello sforzo quella di Ercole – e con le braccia dell’eroe attorno alle zampe dell’animale, in un moto anche qui fortemente concentrico.”.
Quanto al colore verde che vediamo nel dipinto, si tratta del verde usato per la base degli incarnati, che qui emerge per effetto di un restauro mal fatto.
 Ancora una volta, dal modello di Rubens discendono varianti, ma sempre ad esso riferibili, della nuova generazione di artisti italiani. “Per Lanfranco e Bernini la furia del dipingere si esprime chiaramente in due composizioni di tema molto affine, entrambe in mostra tra loro correlate e legate alle prime raffigurazioni rubensiane di Ercole, ispirate all’Ercole Farnese, più volte presente nei disegni del maestro, su cui torneremo”.
Ancora una volta, dal modello di Rubens discendono varianti, ma sempre ad esso riferibili, della nuova generazione di artisti italiani. “Per Lanfranco e Bernini la furia del dipingere si esprime chiaramente in due composizioni di tema molto affine, entrambe in mostra tra loro correlate e legate alle prime raffigurazioni rubensiane di Ercole, ispirate all’Ercole Farnese, più volte presente nei disegni del maestro, su cui torneremo”.
Quello che cambia, nel soggetto della lotta col leone, è che si passa dalla mitologia all’ambito delle storie sacre. L’episodio dipinto è, infatti, quello in cui Sansone, Giudice di Israele dalla forza sovrumana, indifferente alle raccomandazioni dei familiari, si reca a sposare una donna appartenente al popolo dei Filistei, i nemici giurati del suo popolo, politeisti, ben armati e dotati di carri da guerra, che si erano stabiliti sulla costa meridionale della Palestina. Lungo il tragitto viene attaccato da un leone che, naturalmente, sconfigge a mani nude (e, sulla strada del ritorno, ne ritroverà la carcassa colonizzata da uno sciame di api di cui raccoglierà il miele).
Nel Sansone e il leone probabilmente eseguito da Giovanni Lanfranco nel 1625 per il colto cardinale Brancacci, protettore anche di Salvator Rosa, il pittore riprende da Rubens il dettaglio della zampa alzata dell’animale.
 Quasi analogo, e sempre con una concezione monumentale, è il quadro, da alcuni attribuito a Bernini, da altri ad un suo anonimo allievo: Sansone “sbarra” il leone. “Di poco più tardo, forse verso il 1631, e legato alla cultura Barberini”.
Quasi analogo, e sempre con una concezione monumentale, è il quadro, da alcuni attribuito a Bernini, da altri ad un suo anonimo allievo: Sansone “sbarra” il leone. “Di poco più tardo, forse verso il 1631, e legato alla cultura Barberini”.
In entrambi i dipinti gli autori si concentrano sullo sforzo dell’eroe nell’impresa, ambientata in uno stesso arido paesaggio, quasi privo di luce, in cui si vuole mettere in evidenza solo il gioco delle contrapposte energie. Con sommarietà e sprezzatura, sia Lanfranco sia Bernini definiscono la tensione muscolare, il rossore della pelle, le vene gonfie nello sforzo, con un risultato davvero sorprendente per affinità allo stile di Rubens.
C’è chi ha ipotizzato che, se fosse rimasto a Roma, probabilmente Rubens si sarebbe trovato a lavorare proprio con Bernini, a lui così vicino nel concepire in grande e nell’intendere l’antico un mondo da declinare al presente.
Altri dissentono sul fatto che questo sarebbe mai stato possibile, “considerata la forte diversità di carattere, autorevole in entrambi, ma autoritario e arrogante in Bernini, diversissimo dalla magnanimità rubensiana. L’amicizia, così affettuosamente sentita nel pittore fiammingo, si contrappone in Bernini nel contrasto perenne con Borromini, di cui egli sente tutta l’inesauribile e quindi pericolosa creatività. Entrambi mondani, sono graditi ai committenti più prestigiosi, reali e papi, ma, mentre Rubens può davvero definirsi un artista internazionale, legato all’Europa intera che considera sua patria, Bernini non trova fuori dell’Italia la stessa ispirazione, come dimostra il soggiorno a Parigi, che gli è così poco congeniale”.
A proposito del verbo usato nel titolo, su Treccani.it leggiamo che l’azione descritta sembra quella del disarticolamento delle mascelle dell’animale. L’ipotesi è dunque che in questo caso il significato di "sbarrare" provenga dall'italiano antico, di cui nell'uso attuale rimane ad esempio "sbarrare gli occhi" = "spalancare".
Quindi Sansone spalanca le mascelle del leone sino a disarticolare la mandibola dalla mascella superiore.
In italiano esistono tre sbarrare con etimi diversi e una lunga compresenza nella lingua letteraria italiana.
Sbarrare1 significa 'chiudere una porta, un ambiente, una stanza, ecc. con sbarre, chiavi, chiavistelli': viene da barrare e reca all'inizio una s- proveniente dal prefisso latino ex- con valore intensivo.
Sbarrare2 significa 'spalancare (la bocca o gli occhi)': viene da barrare e reca all'inizio una s- proveniente dal prefisso latino ex- con valore privativo.
Sbarrare3 significa 'sventrare, squarciare un corpo, umano o animale, per estrarne le interiora': è questo lo sbarrare di Bernini e della sua scuola; deriva da sbarrare2, incrociato semanticamente con sparare (vedi il Grande dizionario della lingua italiana Utet, comunemente detto Il Battaglia – dal nome del curatore, (Salvatore) Battaglia, vol. XVII, pp. 651-52). Questo sbarrare ha fatto perdere le sue tracce nel corso del XIX secolo.
LA FORZA DEL MITO
Con la sala successiva si apre l’ultima, molto ampia, sezione della mostra: la forza del mito (a dire il vero già cominciata nella precedente). Nell’introdurla è opportuno ribadire che “L’energia catalizzante della decorazione della Chiesa Nuova colpisce il mondo dell’arte perché in essa si percepisce, in maniera sintetica e quindi chiarissima, la vera grande novità del messaggio: la seduzione della pittura sacra e la strada intrapresa verso la sua incontrastata secolarizzazione. Alimentati dal crescente fenomeno del collezionismo, i soggetti sacri acquistano una nuova veemenza patetica, mentre quelli profani mettono in scena complesse e affollate rivisitazioni del passato, destinate alle nuove, prestigiose quadrerie.
Non stupisce quindi che la «gigantesca fantasia» di Rubens, come la definisce Burckhardt, sia particolarmente attratta dalle potenzialità dei tanti temi mitologici, i quali, declinati con esuberante esaltazione della bellezza, offrono spunti narrativi densi di personaggi ora grandiosi, ora foschi, ora di grande e suggestiva bellezza, e possono anche volgere al dramma e alla rappresentazione cruenta. Protagonista di questo mondo è un’umanità mirabile ed eccezionale, le cui gesta eroiche sono alle radici del nostro comune passato, che Rubens celebra per tutta la sua vita di artista.
VIII SALA
IL MITO DI ERCOLE
Ne emerge la figura di Ercole, che abbiamo già incontrata e che si ripresenta in mostra in una sequenza di tele celebrative delle sue imprese ed in un confronto con l’interpretazione del medesimo tema da parte degli artisti più giovani, stimolati dal linguaggio del maestro venuto dal nord.”.
 Il fascino che essa esercita nell’arte di Rubens rientra dunque nella sua ammirazione per il mondo classico e trova un punto di riferimento (fra i dipinti in mostra, in particolare per l’Ercole nel giardino delle Esperidi della Galleria Sabauda) nella grandiosa copia marmorea dell’originale in bronzo di Lisippo (390 - 306 a.C.) rinvenuta a Roma nel 1545 nelle Terme di Caracalla, poi confluita nella collezione Farnese, da cui il nome di Ercole Farnese, ed oggi conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Il fascino che essa esercita nell’arte di Rubens rientra dunque nella sua ammirazione per il mondo classico e trova un punto di riferimento (fra i dipinti in mostra, in particolare per l’Ercole nel giardino delle Esperidi della Galleria Sabauda) nella grandiosa copia marmorea dell’originale in bronzo di Lisippo (390 - 306 a.C.) rinvenuta a Roma nel 1545 nelle Terme di Caracalla, poi confluita nella collezione Farnese, da cui il nome di Ercole Farnese, ed oggi conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Di questo tipo in mostra abbiamo una testa che, più volte disegnata dall’artista, ritroviamo nei suoi dipinti rievocativi del personaggio eroico, esempio di virtù virili e di coraggio.
Rubens è infatti attratto dalla maestosa forza fisica di Ercole, ma anche dalla sua capacità di superare le difficoltà riuscendone sempre vincitore: un modello di vita che l’artista praticava in prima persona di fronte alle prove dell'esistenza.
Prima di procedere può essere utile fare un po’ di chiarezza sulle origini di Ercole e su come arrivò alle celeberrime 12 fatiche. Naturalmente lo faremo per quanto possibile con una realtà tanto ricca di varianti come è quella della mitologia greca ed accontentandoci in questa sede di una versione semplificata.
Per gli interessati ad un maggiore approfondimento suggeriamo la lettura di “I miti greci” di Robert Graves, testo di riferimento anche per quanto pubblicato di seguito e più oltre.
NASCITA DI ERACLE
Innanzitutto Eracle è figlio di una delle innumerevoli relazioni extraconiugali di Zeus: non proprio un consorte fedele di Era: regina degli dei e molto indispettita da questo comportamento.
Nel caso specifico la madre di Eracle fu Alcmena, figlia di Elettrione, re di Micene (ancora nella già sopra citata Argolide), i cui sette figli maschi furono uccisi durante l’assalto portato alla città dall’esercito di Pterelao, re dei Tafi o Taleboi, popolo di naviganti e predoni che abitava le isole Ionie di Tafo e di Carno (oggi Meganisi e Kalamos), a nord di Cefalonia e Itaca.
Per vendicare i figli Elettrione partì in guerra contro i Taleboi lasciando in custodia il regno al nipote Anfitrione, figlio di suo fratello Alceo (come lui figlio di Perseo) e re di Tirinto, al quale promise in moglie Alcmena.
Durante l’assenza del re, Pterelao propose ad Anfitrione di patteggiare la pace pagando un riscatto per ottenere la restituzione del bestiame rubato durante la precedente scorreria.
Anfitrione credendo di fare la cosa giusta accettò la proposta e per questo, al ritorno di Elettrione, venne ingiustamente accusato di complicità col nemico. Nella discussione che ne seguì uccise involontariamente il re e, per questo, Stenelo, un terzo dei numerosi figli di Perseo, intervenne prendendo possesso di Micene ed esiliando Anfitrione.
Alcmena, fiduciosa nella rettitudine di Anfitrione lo seguì ed entrambi furono accolti a Tebe, in Beozia, da Creonte (fratello di Giocasta, la madre di Edipo e reggente della città dopo la nota tragedia e le successive che ad essa seguirono) che assolse Anfitrione dalla colpa.
Alcmena però non lo volle sposare finché Anfitrione non avesse vendicato i suoi fratelli. Un’impresa nella quale Anfitrione riuscì grazie all’esercito di Tebe ma, soprattutto, grazie a Cometo, figlia di Pterelao, che si innamorò di lui e per favorirlo recise al padre il capello d'oro al quale era legata la sua immortalità, privilegio concessogli da Poseidone di cui era nipote.
Per tutta “gratitudine” Anfitrione la condannò a morte per la colpa di patricidio ed assegnò il regno a Cefalo, giovane ateniese che, col suo cane Lelope, lo aiutò a sconfiggere la volpe Teumessa che affliggeva il regno di Tebe.
Mentre Anfitrione era sulla strada del ritorno con l’intenzione di sposare finalmente Alcmena, ecco intromettersi Zeus che, presentandosi alla donna con le sembianze del promesso sposo, precedette la loro relazione.
Alcmena rimase così incinta di Eracle da Zeus e di Ificle da Anfitrione.
Poiché Zeus già si vantava che un suo figlio avrebbe regnato su Tirinto, Era fece in modo di ritardare il parto di Alcmena ed accelerò quello di Nicippe, moglie di suo zio Stenelo.
Il figlio di questi ultimi, Euristeo, nacque perciò un'ora prima di Eracle ed ottenne così la primogenitura ed il conseguente diritto a regnare su Tirinto.
Eracle, invece, nacque insieme a Ificle cosicché Anfitrione ed Alcmena, ignari dell’intervento di Zeus, credettero di aver generato due gemelli.
La straordinaria ascendenza di Eracle fu successivamente rivelata ad Alcmena dall’indovino Tiresia.
Consapevole che il bambino sarebbe stato perseguitato dalla regina degli dei e che non avrebbe potuto proteggerlo con le sue sole forze, lo lasciò in un campo confidando che avrebbe pensato Zeus ad assicurare la sua protezione al proprio figlio.
E così fu: Zeus incaricò il fedele Hermes di far allattare Eracle da Era mentre dormiva e lo rese così un invincibile eroe. Svegliata di soprassalto da un morso del bambino, Era si mosse repentinamente facendo cadere un poco del suo latte che andò a costituire la Via Lattea.

GIOVINEZZA DI ERACLE E PRIMA PAZZIA
Eracle crebbe quindi assieme al padre adottivo Anfitrione al quale era affezionato e che perse durante la vittoriosa spedizione contro la città di Orcomeno (nel Peloponneso centrale) grazie alla quale Tebe venne liberata dal tributo ad essa fino ad allora dovuto.
In segno di riconoscenza per questo successo, Creonte gli concesse in moglie Megara, la più bella fra le sue figlie con la quale mise al mondo otto figli.
Benché affascinato dalle proposte del Piacere Eracle preferì seguire il Dovere, votando la sua esistenza al servizio dei più deboli.
Ma Era non aveva cessato di accanirsi contro il figliastro e, avvalendosi di Lissa, la Rabbia, sconvolse la mente dell'eroe che, non più padrone delle sue azioni, in preda ad una furia assassina uccise i figli credendoli nemici.LE 12 FATICHE
Tornato in sé e resosi conto dell'accaduto, si sottopose ad un rito di purificazione celebrato dal re amico Tespio che e gli consigliò di recarsi a Delfi per chiedere al celebre oracolo un modo per cancellare dal proprio animo tutto quel sangue versato.
La risposta dell’oracolo lo costrinse a mettersi per 12 anni al servizio del re di Tirinto, Argo e Micene: Euristeo, dal quale ricevette l’ordine di affrontare le celeberrime dodici “fatiche”, simbolo della lotta fra l'uomo e la natura nella sua forma più selvaggia e terribile.1. Leone Nemeo; 2. L'Idra di Lerna; 3. La cerva di Cerinea; 4. Il cinghiale d'Erimanto (e Lo scontro con i centauri); 5. Gli uccelli della palude di Stinfalo; 6. Le stalle del re Augia; 7. Le cavalle di Diomede (e La resurrezione di Alcesti); 8. Il Toro di Creta; 9. Il cinto di Ippolita; 10. I buoi di Gerione; 11. I pomi delle Esperidi; 12. La cattura di Cerbero.
Sulla Cerva di Cerinea ed I pomi delle Esperidi: leggi di più in Mito e Natura >>>
LA SECONDA PAZZIA DI ERACLE
Mentre Eracle terminava le 12 fatiche, un usurpatore, Lico (re dell’Eubea), uccise il vecchio Creonte per prenderne il posto come re di Tebe. Comportandosi da sovrano arrogante e dispotico insidiò anche Megara ma Eracle ritornò in tempo per impedirne i propositi uccidendolo.
Tuttavia di nuovo Era intervenne togliendogli il senno e così fu che Eracle uccise anche Megara.
Rinsavito decise di suicidarsi per porre fine alle proprie sofferenze ma fu Teseo, il giovane ateniese che Eracle aveva liberato dal Tartaro, a farlo desistere dal suo gesto disperato ed a condurlo di nuovo dalla Pizia di Delfi.
Questa volta il prezzo per la redenzione fu un anno di schiavitù presso Onfale, la regina di Lidia (regione affacciata sul Mediterraneo dell’attuale Turchia occidentale).
Secondo un’altra versione del mito, Eracle diede in sposa Megara al nipote Iolao, che gli aveva fatto da auriga nel corso delle fatiche, e partecipò alla sfida lanciata dal suo amico e maestro d’arco Eurito, figlio del re di Ecalia Melanio, che aveva offerto in sposa la propria figlia Iole a chi avesse battuto lui ed i suoi quattro figli nel tiro con l’arco, pratica nella quale si vantava di essere più abile dello stesso dio Apollo che gliene aveva regalato uno bellissimo.
Eracle naturalmente vinse senza difficoltà ma Eurito non mantenne la parola data quando seppe che Eracle aveva ripudiato Megara e ne aveva uccisi i figli.
Concordi col padre furono anche i figli di Eurito, salvo il maggiore, Ifito, che riteneva giusto onorare il patto.
Proprio Ifito fu tuttavia ucciso da Eracle che lo precipitò da una torre ancora una volta preda dell’ira.SCHIAVO DELLA REGINA ONFALE
Guidato da Hermes, Eracle si imbarcò per l'Asia, dove non era conosciuto, e per tre talenti venne acquistato da Onfale. Ben presto la regina comprese l’eccezionalità dello schiavo che aveva acquistato, e quando seppe che era il famoso Eracle non lo volle più come servitore ma come compagno di vita.
Anche per Onfale Eracle compì imprese degne della sua fama liberandone il regno da diversi nemici. Fra questi i bizzarri Cercopi: uomini scimmia e raro caso in cui la vicenda si concluse in modo incruento.
 A questo periodo, in cui Eracle è costretto alle mollezze della vita di corte, fanno riferimento i dipinti che lo presentano in vesti femminili ed intento a filare la lana: questo infatti era uno dei passatempi con i quali si divertiva la regina che, da parte sua, giocava con la clava e la pelle di leone.
A questo periodo, in cui Eracle è costretto alle mollezze della vita di corte, fanno riferimento i dipinti che lo presentano in vesti femminili ed intento a filare la lana: questo infatti era uno dei passatempi con i quali si divertiva la regina che, da parte sua, giocava con la clava e la pelle di leone.
Il tempo della schiavitù presso la regina Onfale è rappresentato in mostra dall’Ercole e amorini o La punizione di Ercole di Pietro da Cortona, che usa il colore per dare movimento e, come in molte opere in mostra, a sua volta cita il Torso del Belvedere e propone ben evidente il riferimento all’Ercole Farnese.
Caratterizzano la scena gli angioletti che giocano con la clava e la pelle di leone cedendo in cambio a Ercole il fuso per filare la lana, un mantello di seta ed una corona d’oro ornata di pietre preziose.
Infine, due cuscini di velluto rosso sulla sinistra sono la più efficace sintesi di questo periodo non particolarmente eroico.
Una prima versione del soggetto, intitolata Ercole e Onfale, fu dipinta da Rubens nel 1603. Il dipinto, oggi al Louvre ma che al tempo si trovava a Genova ed era noto anche attraverso le incisioni, rimane certamente in Italia fino alla metà del secolo. Questo ci porta a considerare come Pietro da Cortona, che ne fu un grande ammiratore, possa essersi direttamente ispirato proprio a questa famosa tela proponendoci nella Punizione di Ercole una sua rielaborazione dell’opera del maestro fiammingo che, parallelamente, riprende un secondo e più tardo esempio di Rubens sul tema, Ercole ebbro (Dresda, Staatliche Kunstsammlungen Gemäldegalerie Alte Meister).
“I tre dipinti sono tutti concepiti con la figura dell’eroe frontale, volto verso sinistra, nell’andamento sbilanciato della grandiosa scultura ellenistica. In maniera quasi sovrapponibile Cortona mette in scena la stessa posa dell’eroe, che forza le pieghe anatomiche del torso e del busto, seduto appena, o meglio poggiato su un basamento antico”.
 A testimonianza del successo che questa così particolare parte della vita di Ercole ancora riscuoteva fra gli artisti anche molti decenni dopo Rubens ed i suoi seguaci, è l’Ercole di Giovanni Battista o Giambattista Pittoni (Venezia, 20 giugno 1687 - 17 novembre 1767).
A testimonianza del successo che questa così particolare parte della vita di Ercole ancora riscuoteva fra gli artisti anche molti decenni dopo Rubens ed i suoi seguaci, è l’Ercole di Giovanni Battista o Giambattista Pittoni (Venezia, 20 giugno 1687 - 17 novembre 1767).
Non sfugge infatti a nessuno quanto un simile soggetto si prestasse nel permettere ai pittori di liberare la propria inventiva al di fuori degli usuali schemi nei quali normalmente dovevano comunque inscriverla.
Prima del nuovo riallestimento della sala che l’ospitava, questo dipinto, dono dello storico dell’arte Carlo Bertelli, era visibile nella Pinacoteca di Brera. Essendo stato al momento ritirato riteniamo interessante proporlo qui ai lettori. Anche in segno di riconoscenza verso chi ce l’ha fatto conoscere presentandocelo nel corso di uno dei sempre interessanti itinerari tematici organizzati dai Servizi Educativi della Pinacoteca.
Un Ercole tanto leggiadro, coronato da un serto di fiori è visione rara che merita questa digressione che ci siamo concessi.
 Ercole vincitore dell'Idra (Firenze, Galleria Palatina) ci porta in mostra la seconda fatica con un Ercole in posa da culturista. Si tratta di un soggetto più volte dipinto sia da Rubens sia dallo stesso Guido Reni di cui apprezziamo una versione di grandi dimensioni nella quale la figura di Ercole, rivolta verso destra, “appare in controparte, colta nel riposo che segue alla terribile impresa, ugualmente poderosa ma in atteggiamento forse più plastico e quasi pensoso. A sottolineare la grandiosità della vittoria, l’orribile mostro gioca in questo senso un ruolo prioritario nell’intenso primo piano della testa mozzata dall’eroe sulla quale la nostra attenzione tende a focalizzarsi”.
Ercole vincitore dell'Idra (Firenze, Galleria Palatina) ci porta in mostra la seconda fatica con un Ercole in posa da culturista. Si tratta di un soggetto più volte dipinto sia da Rubens sia dallo stesso Guido Reni di cui apprezziamo una versione di grandi dimensioni nella quale la figura di Ercole, rivolta verso destra, “appare in controparte, colta nel riposo che segue alla terribile impresa, ugualmente poderosa ma in atteggiamento forse più plastico e quasi pensoso. A sottolineare la grandiosità della vittoria, l’orribile mostro gioca in questo senso un ruolo prioritario nell’intenso primo piano della testa mozzata dall’eroe sulla quale la nostra attenzione tende a focalizzarsi”.
L'IDRA DI LERNA - SECONDA FATICA DI ERACLE
Nella foto di famiglia del leone Nemeo, abbiamo già visto l’Idra in compagnia delle mostruose creature come lei generate da Echidna e Tifone.
Viveva in Argolide, nella palude di Lerna, località affacciata sul mare a sud di Argo ed aveva corpo di cane e molte teste di serpente che, a seconda dei miti, potevano essere da tre a nove e più: fino a 50, 100 o addirittura 10.000. Nelle raffigurazioni in cui sono sette si rimanda alle sette sorgenti del fiume Amimone presso il quale aveva la tana, sotto un platano in un bosco di questa specie di alberi.
Addestrata da Era per attentare alla vita di Eracle era velenosa al punto che anche solo il suo fiato o la puzza delle sue tracce potevano uccidere.
Guidato da Atena ed accompagnato da Iolao che ne conduceva il cocchio e gli indicò la tana dell’Idra, Eracle la obbligò ad uscire allo scoperto tempestandola di frecce infuocate per poi attaccarla trattenendo il respiro.
Attorcigliandosi ai suoi piedi l’Idra cerca di farlo inciampare e cadere a terra per sopraffarlo, mentre Eracle ne colpisce le teste con la clava. Ma ogni testa spaccata ricresce moltiplicandosi in due o tre e per di più in aiuto dell’Idra arriva anche un enorme granchio che Era poi ricompenserà collocandolo nello Zodiaco.
Anche Eracle chiama in aiuto Iolao, che incendia il bosco e con i rami infuocati cauterizza la ferita delle teste abbattute impedendo che ricrescano.
Infine, con la spada o falcetto d’oro Eracle taglia la testa immortale principale, che nel dipinto di Guido Reni vediamo ai piedi di Ercole e con aspetto di muso di cane, e la seppellisce sotto una roccia lungo la strada per Elea (località affacciata sul Golfo di Laconia, all’estremità sud orientale del Peloponneso).
Ne squarta poi la carcassa e vi immerge la punta delle sue frecce, che così diventano fatali anche quando causano una minima scalfittura.
Vedremo più avanti quanto questo dettaglio risulterà decisivo nella vita di Eracle.
Tutta questa fatica fu però vana perché Euristeo non convalidò la prova adducendo l’obiezione che Eracle non l’aveva portata a compimento da solo ma con l’aiuto di Iolao.
 Una terza fatica di Ercole troviamo ancora in mostra, la penultima: la sottrazione dei pomi d’oro dal giardino delle Esperidi. Un giardino molto rappresentato nella storia dell’arte fin dall’antichità e che già abbiamo incontrato e descritto nella mostra Mito e Natura (leggi di più >>>).
Una terza fatica di Ercole troviamo ancora in mostra, la penultima: la sottrazione dei pomi d’oro dal giardino delle Esperidi. Un giardino molto rappresentato nella storia dell’arte fin dall’antichità e che già abbiamo incontrato e descritto nella mostra Mito e Natura (leggi di più >>>).
I POMI D'ORO DEL GIARDINO DELLE ESPERIDI - UNDICESIMA FATICA DI ERACLE
Considerato il giardino del Paradiso terrestre, stava nell'estremo Occidente del mondo: oltre i confini della terra abitata, al di là delle colonne d’Ercole, sulle pendici del monte Atlante.
Apparteneva ad Era che, ricevuto in dono da Gea per le nozze con Zeus un albero che produceva mele d’oro, lo gradì tanto da volerlo piantare in questo suo giardino custodito dalle tre Esperidi: Egle, Eritea ed Esperetusa.
Secondo i miti più accreditati erano ninfe (dal greco fanciulle) figlie di Atlante, il Titano che, poco distante, sorreggeva sulle spalle l’intera volta Celeste; punizione che gli fu inflitta da Zeus per essersi alleato con suo padre Crono, a capo della rivolta contro gli dèi dell’Olimpo.
Nel giardino pascolavano liberamente le greggi e le mandrie di Atlante e, terminato il suo corso quotidiano, scendeva anche Helios, la divinità del sole, che vi lasciava a pascolare i cavalli del suo carro e con loro lì riposava durante la notte.
Le Esperidi vengono così collegate al tramonto, quando i colori che assume il cielo ricordano, appunto, quelli di un melo carico di frutti dorati.
Poiché le Esperidi, alle cui cure era stato affidato, ne stavano cogliendo i frutti aurei, come “antifurto” Era ingaggiò un drago-serpente con cento teste al quale ordinò di avvolgere il tronco dell’albero con le sue spire e vigilarlo senza mai chiudere gli occhi.
Questo serpente, che oltretutto parlava diverse lingue (!), era Ladone, figlio dell’antica divinità marina Forci (o Forcide) e della sorella Ceto e fratello della già conosciuta Echidna oltre che delle Graie (letteralmente “anziane donne” canute fin dalla nascita e con un solo dente ed un solo occhio da condividere e passarsi vicendevolmente in due) e delle più note Gorgoni (Steno, Eurialo e, soprattutto, Medusa).
Nonostante la presenza di questo all’apparenza insuperabile guardiano, ad Atlante, che si vantava di avere nel giardino l’albero dei pomi d’oro, fu detto che un figlio di Zeus ne avrebbe rubato i frutti.
Egli allora vi costruì attorno un muro ma neppure questo impedì ad Eracle di impossessarsene.
Secondo alcune tradizioni lo fece in maniera incruenta affidando il compito ad Atlante in cambio dell’offerta di sostituirlo nella punizione di reggere il mondo sulle spalle.
Una non consueta raffigurazione di questo episodio della vicenda può essere ammirata in una sinopia esposta nella Pinacoteca del Castello Sforzesco di Milano.
Poiché a missione compiuta Atlante non voleva più saperne di tornare al suo posto Eracle gli chiese di reggere ancora il cielo solo per un momento mentre lui si sarebbe predisposto ad accomodarsi meglio il peso sulle spalle.
Atlante acconsentì e, deposti i pomi a terra, ingenuamente riprese il suo carico!
Altri miti invece raccontano che il serpente venne ucciso da una freccia scoccata da Eracle e, per alleviare il dolore di Era, fu trasformato nell’omonima costellazione.
Il resto della storia racconta che i pomi d’oro, dopo vari passaggi, furono restituiti alla legittima proprietaria. Invece le Esperidi morirono disperate per la perdita del loro tesoro e del loro amato custode-protettore il giorno dopo il furto e gli Argonauti, nel frattempo arrivati anche qui, assistettero alla loro trasformazione in alberi: un pioppo nero, un salice e un olmo.
 Di questi fatti in mostra vediamo una diversa versione. In Ercole lotta con il dragone nel giardino delle Esperidi del 1635 - 1640, olio su tela dal Museo del Prado, vediamo che il combattimento consiste in una lotta corpo a corpo. Naturalmente più interessante per Rubens da descrivere in pittura rispetto allo scoccare di una freccia o ad un astuto espediente. Ed è evidente quanto gli piaccia rendere l’espressione aggrottata e la tensione dei muscoli di Ercole. Nel quale di nuovo ritroviamo la stessa testa e la stessa muscolatura già appena viste in Guido Reni per l'Ercole vincitore dell’Idra nonché ancora gli echi del Torso del Belvedere. Ultima annotazione: gli studiosi dell’opera evidenziano come la familiarità del pittore verso questo soggetto si possa cogliere anche da un dettaglio di questa tela nella quale lo sfondo dipinto da Rubens sembra riproporre l’aggraziato giardino verdeggiante e coltivato nella sua dimora di Anversa.
Di questi fatti in mostra vediamo una diversa versione. In Ercole lotta con il dragone nel giardino delle Esperidi del 1635 - 1640, olio su tela dal Museo del Prado, vediamo che il combattimento consiste in una lotta corpo a corpo. Naturalmente più interessante per Rubens da descrivere in pittura rispetto allo scoccare di una freccia o ad un astuto espediente. Ed è evidente quanto gli piaccia rendere l’espressione aggrottata e la tensione dei muscoli di Ercole. Nel quale di nuovo ritroviamo la stessa testa e la stessa muscolatura già appena viste in Guido Reni per l'Ercole vincitore dell’Idra nonché ancora gli echi del Torso del Belvedere. Ultima annotazione: gli studiosi dell’opera evidenziano come la familiarità del pittore verso questo soggetto si possa cogliere anche da un dettaglio di questa tela nella quale lo sfondo dipinto da Rubens sembra riproporre l’aggraziato giardino verdeggiante e coltivato nella sua dimora di Anversa.
Diverso, più solenne e statico, è l’impianto compositivo della scena conclusiva: Ercole nel giardino delle Esperidi del 1638, dalla Galleria Sabauda di Torino (la cui immagine è pubblicata all'inizio di questa sottosezione). È opera della maturità dell’artista che dipinge l’eroe al termine dell’undicesima fatica quando, dopo l’uccisione del serpente Ladone, esprime tutto il suo soddisfatto compiacimento nel contemplare i pomi d’oro che sta cogliendo dall’albero nel giardino segreto di Giunone.
 Questo non impedisce a Rubens di riproporci la torsione del Torso del Belvedere e, nel portamento e nella posizione delle gambe, con l’espediente di quella semipiegata per via del piede appoggiato sulla testa del serpente sconfitto, è ancora una volta riconoscibile il prototipo classico della collezione Farnese, copia dall’originale di Lisippo che attua la già illustrata lezione di Policleto.
Questo non impedisce a Rubens di riproporci la torsione del Torso del Belvedere e, nel portamento e nella posizione delle gambe, con l’espediente di quella semipiegata per via del piede appoggiato sulla testa del serpente sconfitto, è ancora una volta riconoscibile il prototipo classico della collezione Farnese, copia dall’originale di Lisippo che attua la già illustrata lezione di Policleto.
Oltretutto il soggetto è proprio il medesimo. Infatti anche questa scultura raffigura Eracle al termine della medesima undicesima fatica. Lo si capisce guardandolo da dietro. Infatti nella mano nascosta dietro la schiena tiene i pomi d’oro delle Esperidi.
Completa la sala la Cattura di Sansone del 1614 - 1620 (da Monaco) dove torniamo ad un soggetto biblico ma con i sempre evidenti riferimenti alla scultura classica e con un protagonista che già abbiamo incontrato ed è qui presentato prigioniero come il Laocoonte (gruppo scultoreo già sopra presentato in relazione al rapimento di Ganimede e del quale, realizzata da Bernini, è in mostra una copia della testa del sacerdote): con le corde e la pelle di leone che lo avviluppano in luogo dei serpenti e le braccia degli armigeri tutte distese e protese verso di lui, centro di un vortice di spinte centripete.
 Un vortice dal quale, sorretta ed aiutata da una governante, cerca di sottrarsi Dalila: con ancora in mano le forbici, strumento del tradimento che ha tolto la forza all’uomo che si fidava di lei lasciandolo in balia dei suoi nemici.
Un vortice dal quale, sorretta ed aiutata da una governante, cerca di sottrarsi Dalila: con ancora in mano le forbici, strumento del tradimento che ha tolto la forza all’uomo che si fidava di lei lasciandolo in balia dei suoi nemici.
Dalila poggia un piede a terra, calzando una babbuccia mentre l’altra è fuori posto per il trambusto accanto all’immancabile cagnolino sgusciato fuori da sotto il letto ad osservare la scena. Il tutto è reso se possibile ancora più drammatico dal rosso dei panneggi che la incorniciano come una quinta teatrale e dalla coperta orlata di bianca pelliccia sul letto. Infine, quasi personificazione dell’artista, che sembra dirci “guardate cosa vi mostro” è il personaggio seminascosto sullo sfondo di cui vediamo bene il braccio teso che regge la fiaccola che dà luce alla stanza e, seminascosto, l’occhio sinistro che ci guarda fissi in viso.
IX SALA
Dopo la parentesi biblica si torna ai miti dell’antichità classica con due dipinti di una tale realistica durezza che lo sguardo fatica a sostenerne la vista. Perché “il mito è certo bellezza ed armonia, ma è anche dramma intenso e cupo, che rappresenta l’altro, complementare, cruento volto di un passato remoto e fosco dell’umanità primitiva.
 Nel primo, di Rubens, Saturno divora uno dei figli 1636 - 1638 la tela contiene a malapena i due personaggi, isolati sullo sfondo di una natura cupa e inquietante ed è terribile l’orrore suscitato nell’osservatore dalla testa rovesciata all’indietro del bambino che lancia un grido straziante mentre il padre gli strappa letteralmente la carne dal petto.
Nel primo, di Rubens, Saturno divora uno dei figli 1636 - 1638 la tela contiene a malapena i due personaggi, isolati sullo sfondo di una natura cupa e inquietante ed è terribile l’orrore suscitato nell’osservatore dalla testa rovesciata all’indietro del bambino che lancia un grido straziante mentre il padre gli strappa letteralmente la carne dal petto.
Un soggetto ridipinto da Goya dopo aver visto questo quadro esposto al Museo Nazionale del Prado di Madrid.
L’unico dettaglio che possiamo notare senza restare impressionati sono le tre stelle in alto nel cielo. È un riferimento al pianeta Saturno, splendente anche di notte con i suoi anelli, che tuttavia, nelle osservazioni astronomiche di Galileo Galilei, non erano stati riconosciuti come anelli piani ma gli apparivano come una luce più grande in mezzo a due stelle più piccole. E così, dunque, li rappresenta Rubens che era in contatto con lo scienziato fiorentino.
Sulla stessa linea di realismo sanguinolento si pone Salvator Rosa (Napoli, 22 luglio 1615 - Roma, 15 marzo 1673) con la sua versione del Prometeo incatenato del 1630 e, come il già visto Tizio, sottoposto al supplizio di avere il fegato per l’eternità divorato a beccate dall’aquila.
Seppure analogo è il tormento, ben diverse sono le motivazioni che l’hanno determinato. Se per Tizio era il poco lodevole tentativo di insidiare Latona, Prometeo rappresenta, invece, il simbolo del potere che schiaccia chi lo combatte in nome del progresso e della libertà. Titano amico dell'umanità sottrae il fuoco agli dei per donarlo agli uomini e subisce la punizione di Zeus che lo incatena a una rupe ai confini del mondo e poi lo sprofonda nel Tartaro, al centro della Terra.
Con questa sua grande tela Salvator Rosa ci offre “la misura della novità proposta da Rubens sullo stesso tema molti anni prima, attorno al 1610-1612, quando dipinge un altro straordinario esempio della produzione “oscura” di cui si è detto: il Prometeo oggi a Filadelfia (Philadelphia Museum of Art).
Realizzato insieme all’allievo Frans Snyders, artefice della grandiosa e incombente aquila che atterra pesantemente sul corpo del protagonista, ce ne presenta la figura gigantesca in uno scorcio estremo: spinto sul limite del primissimo piano della tela, rimeditando e coniugando insieme Tintoretto e Michelangelo, oltre naturalmente alla scultura antica”.
Ma anche nella versione del pittore napoletano, “realizzata con una tecnica sorprendentemente matura e con toni bruni di derivazione anche riberesca”, la scena è davvero titanica. Nella cruenta immagine sono impressionanti ed inguardabili le viscere martoriate dell'eroe, che il rapace strappa dal suo corpo straziato e sanguinante e sparge sulle rocce circostanti, mentre dalla bocca spalancata allo spasimo sul volto di Prometeo, deformato dal dolore, erompe un urlo assordante ed agghiacciante.
 Ci riporta a scene meno realisticamente tragiche l’ultima ricorrenza in mostra di vicende legate al mito di Eracle. Con Nesso e Dejanira (San Pietroburgo, Hermitage), copia di un allievo del perduto originale di Rubens siamo ai “titoli di coda” della vita dell’eroe. Nella sala precedente avevamo lasciato Eracle alle dipendenze della regina Onfale ed alle “mollezze” della vita di corte. Poiché questo genere di esistenza non si addiceva ad un eroe come lui, che aveva tutt’altro ideale di vita, infine Eracle lasciò Onfale ed onorò la promessa che, incontrandolo nel Tartaro, aveva fatto a Meleagro: sposarne la sorella Deianira.
Ci riporta a scene meno realisticamente tragiche l’ultima ricorrenza in mostra di vicende legate al mito di Eracle. Con Nesso e Dejanira (San Pietroburgo, Hermitage), copia di un allievo del perduto originale di Rubens siamo ai “titoli di coda” della vita dell’eroe. Nella sala precedente avevamo lasciato Eracle alle dipendenze della regina Onfale ed alle “mollezze” della vita di corte. Poiché questo genere di esistenza non si addiceva ad un eroe come lui, che aveva tutt’altro ideale di vita, infine Eracle lasciò Onfale ed onorò la promessa che, incontrandolo nel Tartaro, aveva fatto a Meleagro: sposarne la sorella Deianira.
LA FINE DI ERACLE
Figlia di Dioniso ed Altea, moglie di Eneo re dell’Etolia (Grecia centrale, ovest del golfo di Corinto), Deianira è una delle sole due sorelle di Meleagro (piangenti per la morte del fratello causata dalla sua stessa madre) che Dioniso indusse Artemide a non trasformare in galline faraone.
Erano tanti i pretendenti ad averla in moglie, ma quando seppero di doversi confrontare con Eracle, si ritirarono tutti ad eccezione del padre di tutti i fiumi greci: il dio del fiume Acheloo. Inutilmente sfruttando le peculiarità della sua triforme natura di serpente dalla pelle macchiettata, toro e uomo dalla testa di toro, Acheloo venne sconfitto e così Eracle conquistò Deianira.
Durante il viaggio, trovandosi i due a dover guadare il fiume Eveno in piena, il centauro Nesso che viveva nei suoi pressi e traghettava i viandanti, si offrì di portare Deianira sull’altra sponda. Tuttavia, mentre Eracle attraversava a nuoto il corso d’acqua, Nesso rapì Deianira e fuggì dalla parte opposta cercando di approfittarsi di lei.
Eracle però riuscì a fermarlo raggiungendolo con una freccia, benché scoccata da una distanza di mezzo miglio.
In questo fatto, apparentemente banale, risiede il presupposto della morte di Eracle.
Ridotto in fin di vita, Nesso invitò Deianira a raccogliere il sangue uscito dalla sua ferita mortale facendole credere che non avrebbe più dovuto temere l’infedeltà del suo uomo se l’avesse utilizzato come componente di un unguento col quale avrebbe dovuto cospargerne gli abiti.
Poiché anche a lei era nota la facilità con cui Eracle cedeva alle lusinghe femminili, Deianira fece quanto le era stato consigliato.
Tempo dopo avvenne che Eracle tornò in Ecalia (in Tessaglia, Grecia del nord) per vendicarsi del re Eurito, che gli aveva negato la figlia Iole come sposa, punendolo in quanto trasgressore dei patti. Un’impresa che, secondo un decreto dell'Oracolo di Dodona, sarebbe stata la sua ultima. E così fu.
Dopo aver ucciso Eurito ed i suoi familiari, Eracle fa prigioniera Iole, che cerca di sfuggire alla cattura tentando di suicidarsi gettandosi dalle mura della città. Ma invano: durante il volo la sua veste si allarga e, come fosse un paracadute, attutisce la caduta.
Sulla strada del ritorno verdo Trachine (nella Malide - Trachinia, terra affacciata sul golfo Malico ad ovest delle Termopili) dove lo attende Deianira, Eracle si ferma per celebrare i riti di ringraziamento agli dei per la vittoria e manda avanti il servitore Lica perché gli porti la tunica da vestire per l’occasione.
Notando fra gli ostaggi catturati anche Iole, che sapeva essere stata desiderata da Eracle, Deianira si ingelosisce e decide di mettere in pratica l'incantesimo che il centauro Nesso le aveva insegnato e tratta con il portentoso unguento il vestito da inviare.
Così Eracle lo indossa ma, non appena il fuoco acceso sull'altare ne riscalda il tessuto, un dolore bruciante gli entra fin nelle vene. Infatti il sangue del centauro di cui era intriso era avvelenato dal veleno letale dell’Idra di Lerna nel quale era stata intinta dallo stesso Eracle la freccia che aveva ucciso Nesso. Che dunque ottiene la sua vendetta benché già morto.
Il veleno dunque aderisce alle carni dell’eroe e le corrode inesorabilmente ed i tentativi di strapparsi la veste di dosso ottengono il solo risultato di scarificarsi fino a scoprire le ossa. In un estremo tentativo di salvarsi Eracle si getta nel fiume ma ottiene l’effetto contrario di bruciare ancora di più. Da allora queste acque, sempre ribollenti, sono chiamate Termopili, ovvero “passaggio caldo”.
Da parte sua Deianira, vedendo bruciare al sole lo straccio gettato nel cortile col quale aveva sparso l’unguento sulla camicia, capisce il pericolo e cerca di avvisare Eracle inviando un corriere, che però non arriva in tempo.
Impotente per la prima volta nella sua vita, Eracle non può fare altro che subire l’agonia, non mancando di uccidere, nella disperazione, il servo Lica che, ignaro, gli aveva portato la veste fatale.
Ormai morente fa promettere al figlio Illo (suo e di Deianira) di sposare Iole non appena avrà raggiunto la maggiore età e gli rivela la profezia di Zeus che si sta avverando: “Nessun uomo vivente ucciderà mai Eracle; ma un nemico morto segnerà la sua fine”.
Con le ultime forze, Eracle sradica alcuni alberi e costruisce una pira sulla quale poter bruciare ma, una volta preparato il rogo né Illo né il nipote Iolao hanno il coraggio di accenderlo, ed Eracle è costretto a chiedere aiuto al pastore Filottete.
Questi ubbidisce ed Eracle, in segno di riconoscenza, gli dona le sue armi, che gli faranno comodo durante la guerra di Troia.
Quindi, indossata la pelle di leone che non aveva mai lasciato dall'età di diciotto anni, sale sulla pira, intanto che Iolao, Illo e Filottete intonano i lamenti funebri.
Mentre Eracle comincia ad ardere, da vero “deus ex machina”, Zeus interviene prima che muoia e, al suono di un rombo, ne preleva il corpo per portarlo con sé nell’Olimpo, dove l’eroe si riconcilierà con Era e sposerà Ebe, la dea della giovinezza e coppiera degli dei.
Dopo aver assistito a questo prodigio, Iolao costruirà un tempio in onore dello zio mentre Deianira, non appena informata di quanto successo, si uccide in preda ai sensi di colpa.
 Dal punto di vista pittorico e delle citazioni dall’antico, invece, Dejanira ha la postura della famosa Venere accovacciata o Afrodite al bagno con Eros dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli (a lato) della quale colpisce lo sguardo vigile-astuto.
Dal punto di vista pittorico e delle citazioni dall’antico, invece, Dejanira ha la postura della famosa Venere accovacciata o Afrodite al bagno con Eros dal Museo Archeologico Nazionale di Napoli (a lato) della quale colpisce lo sguardo vigile-astuto.
Nota per le numerosissime repliche è un modello di armonia assoluta al quale, come per Deianira, in un continuo rimando fra soggetti mitologici e tratti dalla Bibbia, Rubens non manca di rifarsi anche per la Susanna e i vecchioni dalla Galleria Sabauda, che risulta dipinta dal maestro fiammingo assieme alla bottega ed è in deposito a Venaria Reale.
SUSANNA E I VECCHIONI
Il soggetto della "Susanna e i vecchioni" è molto diffuso nella storia della pittura. Si tratta, infatti, di un comodo pretesto per dipingere una donna svestita. La vicenda narra di Susanna, moglie del ricco ebreo Gioacchino, sorpresa da due Giudici (capi temporanei del popolo di Israele nei momenti in cui è minacciato da pericoli; ricordiamo che, ad esempio, era un Giudice anche Sansone al tempo della guerra contro i Filistei) che vogliono approfittare di lei e, al suo rifiuto di cedere alle loro richieste, la accusano di adulterio.
La sorte della sventurata sarebbe segnata, e tragica, se non intervenisse in suo soccorso il profeta Daniele, nel cui omonimo libro biblico si racconta l’episodio, insinuando il dubbio che non ci siano le prove della colpa della donna.
Da quanto si legge nel suo libro, Daniele, di nobile famiglia giudea, viene deportato a Babilonia quando è ancora un adolescente. Per la sua saggezza conquista la fiducia del re Nabucodonosor diventando interprete dei suoi sogni e funzionario di corte. La sua ottima reputazione gli permette di continuare la sua attività anche dopo la conquista di Babilonia da parte dei Medi e dei Persiani nel 539 a.C..
Il re persiano Ciro II ne apprezza i consigli ma, a causa di trame di corte che lo fanno cadere in disgrazia, è costretto a gettarlo nella fossa dei leoni. Confidando in Dio, Daniele evita miracolosamente il supplizio e viene graziato.
 Se in questa versione Susanna è al centro della scena, come è caratteristico nello “stile” nordico, in dipinti precedenti la vediamo, invece, di lato e con evidenti rimandi ad altri due “tipi” della scultura classica: lo Spinario e la Ninfa Spinaria.
Se in questa versione Susanna è al centro della scena, come è caratteristico nello “stile” nordico, in dipinti precedenti la vediamo, invece, di lato e con evidenti rimandi ad altri due “tipi” della scultura classica: lo Spinario e la Ninfa Spinaria.
Di essi in mostra vi sono due esempi marmorei entrambi provenienti dagli Uffizi di Firenze.
La Replica del tipo dello Spinario è una copia del ‘500 nella quale un fanciullo, seduto, solleva il piede sinistro appoggiandolo sul ginocchio destro e vi si piega sopra col busto e la testa inclinata per vedere meglio nel tentativo di togliersi una spina da sotto la pianta del piede.
Fa lo stesso la Ninfa spinaria, ma con più eleganza, senza piegare il busto e tenendo appoggiata al piano sul quale è seduta la mano non intenta nell’operazione.
 Tutti gli antecedenti scultorei trovano sintesi nella più antica versione di Rubens del soggetto: quella del 1607 oggi a Villa Borghese.
Tutti gli antecedenti scultorei trovano sintesi nella più antica versione di Rubens del soggetto: quella del 1607 oggi a Villa Borghese.
Nella penombra della scena Susanna, sorpresa dai vecchi che col gesto del dito indice la invitano al silenzio, è seduta nella posa della Spinaria, ma piega la testa con eleganza come la Venere accovacciata, della quale l’artista riprende anche la morbida sensualità del corpo, e ruota il busto al modo dello Spinario nel tentativo di coprirsi col panno bianco drappeggiato sotto la sua gamba ed attorno al suo braccio stretto da un ricco bracciale d’oro con incastonate pietre preziose.
Analoghe considerazioni, fatta eccezione per il braccio sinistro alzato, valgono per la postura della Susanna dell’Hermitage, seduta su un plinto con i piedi in acqua mentre i vecchioni qui sono più aggressivi ed uno di essi arriva ad afferrare il suo velo cercando di strapparglielo di dosso.
 Tutte queste importanti versioni sul tema a confronto in mostra documentano l’esaltazione della grazia femminile, così ricorrente nell’opera di Rubens, contrapposta alla crudezza di sentimenti che poco addietro ci ha fatti inorridire.
Tutte queste importanti versioni sul tema a confronto in mostra documentano l’esaltazione della grazia femminile, così ricorrente nell’opera di Rubens, contrapposta alla crudezza di sentimenti che poco addietro ci ha fatti inorridire.
Come questa però, anche l’armoniosa bellezza si fonda sul suo amore per l’antico e sullo studio delle soluzioni che gli scultori Greci e Romani avevano elaborato per la posa dei loro personaggi, non mancando però mai di ribadire la sua interpretazione libera e vitale del mondo classico.
In definitiva esse “esprimono perfettamente il nuovo interesse del collezionismo crescente per quel genere - definito da Marino Istorie, spesso tratte dalla Bibbia - che riscuote pieno successo nelle raccolte delle nuove case patrizie, anche per le sue sfumature erotiche”.
X SALA
Si torna ancora alla mitologia greca, ma alla sua fase più recente, quella che precede immediatamente la guerra di Troia, con una delle otto scene pensate come modello per arazzi: Achille scoperto da Ulisse tra le figlie di Licomede (1630 - 35) dal Museo Nacional del Prado di Madrid.
Dipinto che riveste anche un interesse storico perché Pieter Paul Rubens è stato il primo pittore a pensare ad un ciclo dedicato ad Achille.
La raffigurazione della storia è resa in modo molto vivace con l’inserimento di molti particolari che si comprendono appieno solo se la si conosce. Eccola dunque.
ACHILLE SMASCHERATO DA ULISSE
Per evitare che il figlio Achille sia costretto ad accompagnare i Greci nella guerra di Troia, dove sapeva che avrebbe trovato la morte, Teti lo nasconde nell’isola di Sciro dove, travestito da damigella, vive con le figlie del re Licomede.
I greci, però, scoperto il nascondiglio inviano all’isola Ulisse e Diomede che, a loro volta travestiti da mercanti, allettano le figlie del monarca con oggetti tipicamente femminili come specchi, stoffe preziose e gioielli.
Tra questi però Ulisse aveva infilato delle armi per suscitare l’interesse maschile di Achille: che immediatamente si scopre scegliendo queste.
Secondo alcuni autori classici, Ulisse si fa accompagnare da un trombettista al quale, simulando un attacco nemico, fa suonare le musiche marziali amate da Achille il quale, non appena udito il suono della tromba, si strappa di dosso l’abbigliamento femminile ed indossa l’armatura.
Durante il suo soggiorno a Sciro Achille si innamora di Deidamia, la più bella figlia di Licomede, cosicché la principessa resta incinta di Neottolemo.
 Rubens ha rappresentato Achille mentre si tradisce indossando l’elmo e rivelando così la propria identità. La sua amata Deidamia, e le sue sorelle che l’attorniano, lo guardano con timore, come se percepissero la drammaticità della situazione. I due falsi mercanti sono sul lato opposto. Ulisse, alla destra di Achille, è rappresentato con la testa avvolta dalle spire di un turbante mentre si copre la bocca con una mano come se stesse bisbigliando qualcosa ad una figura che non appare nella scena. Forse si tratta di un sommesso messaggio al trombettista di cui si è detto che Rubens non dipinge.
Rubens ha rappresentato Achille mentre si tradisce indossando l’elmo e rivelando così la propria identità. La sua amata Deidamia, e le sue sorelle che l’attorniano, lo guardano con timore, come se percepissero la drammaticità della situazione. I due falsi mercanti sono sul lato opposto. Ulisse, alla destra di Achille, è rappresentato con la testa avvolta dalle spire di un turbante mentre si copre la bocca con una mano come se stesse bisbigliando qualcosa ad una figura che non appare nella scena. Forse si tratta di un sommesso messaggio al trombettista di cui si è detto che Rubens non dipinge.
Come anche per gli altri sette quadri, le due cariatidi laterali sono direttamente correlate alla scena raffigurata.
Quella di sinistra rappresenta l’inganno. Accucciata alla sua base, una volpe simboleggia l’astuzia messa in atto da Ulisse, mentre la maschera che le è scivolata di lato scoprendone il viso sembra essere legata alla fine del travestimento di Achille.
A destra troviamo invece la dea Atena. Facilmente riconoscibile per la presenza, seppure seminascosta accanto al suo basamento, di una civetta: l’uccello notturno a lei sacro e qui dipinto con molta accuratezza.
Atena è la personificazione della saggezza ed è la dea della guerra combattuta con strategia e per necessità. Diversamente dal fratello Marte, il violento dio della guerra condotta per il gusto di uccidere. Altro dettaglio che identifica Atena è la presenza della sua egida: lo scudo protettivo magico realizzato con pelle di capra e nel quale fu inserita la testa irta di serpenti della Gorgone Medusa che fu vinta da Perseo.
Non ci è invece ancora chiaro il significato dell’oggetto rosso in primo piano che sembra essere un carbone ardente o un frammento vulcanico infuocato; indagheremo.
Quanto al paesaggio marino in lontananza ed alle architetture, sembra di potervi riconoscere lo stile di Veronese (Verona, 1528 - Venezia, 1588).
Venendo infine alla ripartizione dei compiti tra Rubens e la sua bottega, sembra che la realizzazione di questo quadro sia stata condotta in modo diverso rispetto a quella riconosciuta per altri episodi della serie, come ad esempio quello relativo all’educazione di Achille.
Naturalmente è più che probabile che le cariatidi, gli elementi architettonici ed il tassello centrale siano opera di un collaboratore, mentre il principale gruppo di figure, composto da Deidamia e dalle sorelle, siano esclusivamente di Rubens così come sono in gran parte anch’essi attribuibili al maestro i tre uomini ed il cagnolino. In questo caso, tuttavia non c’è traccia di ritocchi eseguiti da Rubens sulle architetture che il suo aiutante ha dipinte sullo sfondo lasciando parte della tela vuota perché il maestro la potesse riempire con le figure principali.
Viceversa, in altri modelli, è quest’ultimo a lasciare agli allievi lo spazio per i dettagli minori come le cornucopie o le nature morte in primo piano.
Dagli antichi miti greci si passa questa volta alla rappresentazione di un racconto di carattere morale contenuto nel repertorio di exempla (positivi e negativi) raccolto in nove libri dallo storico latino Valerio Massimo e pubblicato nel 31 d.C. col titolo di Factorum et dictorum memorabilium libri IX (Nove libri su fatti e cose varie da ricordare). Si tratta della Carità Romana, Cimone e Pero dipinto nel 1612, quindi quando Rubens aveva già lasciato l’Italia ma evidentemente era ancora pienamente impregnato della cultura di Roma.
 Il tema raffigurato ebbe grande popolarità nei secoli XVI-XVIII e, di riflesso, questa si tradusse in una sua frequente presenza nei dipinti di tanti artisti del tempo. Si tratta della vicenda di Cimone, cittadino romano in prigione e condannato a morte per fame (non si sa bene per quale ragione). Poiché la figlia Pero ha appena partorito, gli fa visita in carcere e di nascosto lo nutre allattandolo. Ma un carceriere infine la scopre e lo riferisce al comandante che, tuttavia, è commosso dal gesto e non la punisce, anzi revoca la pena e concede la libertà anche al padre.
Il tema raffigurato ebbe grande popolarità nei secoli XVI-XVIII e, di riflesso, questa si tradusse in una sua frequente presenza nei dipinti di tanti artisti del tempo. Si tratta della vicenda di Cimone, cittadino romano in prigione e condannato a morte per fame (non si sa bene per quale ragione). Poiché la figlia Pero ha appena partorito, gli fa visita in carcere e di nascosto lo nutre allattandolo. Ma un carceriere infine la scopre e lo riferisce al comandante che, tuttavia, è commosso dal gesto e non la punisce, anzi revoca la pena e concede la libertà anche al padre.
Nella maggior parte delle versioni di questo soggetto dipinte da altri autori, mentre alimenta il padre Pero volge lo sguardo attorno: in vigile tensione per accorgersi in dell’arrivo dei sorveglianti.
Anche in questa circostanza Rubens, invece, si distingue e la dipinge che guarda con tenerezza il genitore, dallo sguardo assente e dall’aspetto disordinato per la durezza della prova alla quale era sottoposto.
Oltre l’inferriata della finestrella in alto a sinistra si vede un luminoso cielo veneto, forse presagio del lieto fine che arriverà mentre ci sfugge il significato simbolico (che siamo certi non possa mancare) del ragno sulla ragnatela intessuta fra le sbarre. "La raffigurazione di due delle opere di misericordia, visitare i carcerati e nutrire gli affamati, e la composizione che assume una geometria triangolare connotano il modello di un’eroica umanità superiore alla quale l’osservatore è invitato a conformarsi".
Ultimo curioso dettaglio è la targhetta apposta sulla cornice che riporta il nome dell’autore “PP Rubens” scritto in caratteri latini ma anche, vista la provenienza dal Museo di Stato dell’Hermitage di San Pietroburgo, in caratteri cirillici!
XI SALA
È un’alternanza, questa fra grecità e latinità, che ci accompagna fino agli ultimi quattro dipinti in mostra. I primi tre sono riferiti ai miti di fondazione delle due principali capitali dell’antichità ed ai loro primi re: che, non troppo sorprendentemente, hanno natali non troppo sereni. Erittonio e Romolo alle radici della civiltà occidentale.
Oltre alle Istorie tratte dalla Bibbia, anche i grandi temi mitologici, che il poeta barocco Marino chiama Favole, offrono infatti a Rubens l’occasione di celebrare quel passato grandioso dell’umanità nel quale egli vede le radici della civiltà occidentale ed al quale da sempre si ispira.
Interpretandole a suo modo l’artista ha così una vastissima possibilità di mettere alla prova la propria fantasia, sostenuta dalla conoscenza dei classici, per mettere in scena, celebrandoli, i momenti salienti della storia antica ed i personaggi di rilievo che ne sono stati protagonisti.
È, appunto, il caso di Erittonio re di Atene e di Romolo, nel grande dipinto ispirato alla leggenda della fondazione di Roma, di cui è primo re. Il confronto tra le due opere, con il richiamo ai padri della storia antica, appare quasi suggerito dallo stesso Rubens che le esegue entrambe intorno fra il 1612 ed il 1615.
Ad Atene fa dunque riferimento Il Ritrovamento di Erittonio.
ERITTONIO RE DI ATENE
Secondo il mito, il re di Atene Cecrope, personificazione dell’animale sacro nato dalla terra, il serpente, e che del serpente aveva per metà le sembianze, aveva preferito avere a protezione della città Atena, che le aveva donato l’ulivo, rispetto a Poseidone, che vi aveva fatto sgorgare una sorgente d’acqua dolce.
Forse indispettito per l’affronto, il dio del mare aveva allora ingannato Efesto dicendogli che Atena lo avrebbe raggiunto perché era volontà di Zeus che si unisse a lui.
In realtà Atena andava dal fabbro degli dei per avere delle armi perciò, quando questi le manifestò, con i fatti, le sue intenzioni lei si scostò e nella circostanza ad essere fecondata fu invece Gea, la terra.
Nacque così Erittonio, un bambino le cui gambe terminavano in due serpenti.
Poiché nessuno si voleva occupare di lui lo fece allora Atena che lo nascose in una cesta e lo affidò alle tre figlie di Cecrope, Aglauro Erse e Pandroso, vietando loro di scoprirgli le gambe.
Ovviamente la curiosità ebbe il sopravvento ed il dipinto ci mostra il momento (scolpito anche da Fidia in una metopa sul lato sud del Partenone) in cui Aglauro, la maggiore delle tre, convince le altre sorelle a violare il divieto e solleva il coperchio della cesta facendo la scoperta che non avrebbero dovuto fare.
La punizione sarà la follia (non tanto per lo spavento, che anche nel dipinto non sembra reso con grande realismo) e la morte.
Su come questa avvenne, a seconda degli autori le versioni sono discordanti. Secondo alcuni tutte le sorelle si uccisero gettandosi dall’Acropoli, secondo altri Erse si salvò perché di lei si innamorò Ermes. Rubens dà credito a questa versione raffigurando Cupido che le tocca il mantello rosso, in questo modo identificandola.
Si narra anche che Ermes chiese l’aiuto di Aglauro per introdursi nella stanza della sorella, ma questa, che ne era gelosa (anche per l’intervento di Atena che non aveva “gradito” la disobbedienza rispetto al suo ordine), non fece quanto promesso cosicché il dio si vendicò tramutandola in pietra.
Tempo dopo Cecrope trasmise proprio ad Erittonio il dominio su Atene.
 Più che di riferirsi al futuro re di Atene il dipinto sembra però voler avere il significato di un’allegoria dell’amore passionale e della fertilità. Infatti, oltre a quanto fin qui osservato, notiamo sulla sinistra un’erma di Pan, proprio il dio dell’amore passionale. Naturalmente non è casuale neppure la presenza del pavone che sbuca fuori da dietro il suo basamento. Pur non avendo alcun elemento che ci indirizzi sulle intenzioni dell’artista, rileviamo che il pavone è considerato sacro ad Era, di cui evoca il volto, così come rimanda allo splendore della volta celeste di cui gli occhi rappresentano le stelle. Occhi che sono anche quelli di Argo dai 100 occhi che Era mise sulla coda del pavone quando Ermes, dopo averlo addormentato raccontandogli la vicenda di Pan e Siringa, lo uccise per liberare Io, sacerdotessa della regina degli dei, a lui affidata perché la sorvegliasse nella prigionia sotto forma di giovenca in cui l’aveva trasformata Zeus, per sfuggire all’ira di Era che lo aveva scoperto mentre cercava di possederla nascondendosi sotto forma di nube.
Più che di riferirsi al futuro re di Atene il dipinto sembra però voler avere il significato di un’allegoria dell’amore passionale e della fertilità. Infatti, oltre a quanto fin qui osservato, notiamo sulla sinistra un’erma di Pan, proprio il dio dell’amore passionale. Naturalmente non è casuale neppure la presenza del pavone che sbuca fuori da dietro il suo basamento. Pur non avendo alcun elemento che ci indirizzi sulle intenzioni dell’artista, rileviamo che il pavone è considerato sacro ad Era, di cui evoca il volto, così come rimanda allo splendore della volta celeste di cui gli occhi rappresentano le stelle. Occhi che sono anche quelli di Argo dai 100 occhi che Era mise sulla coda del pavone quando Ermes, dopo averlo addormentato raccontandogli la vicenda di Pan e Siringa, lo uccise per liberare Io, sacerdotessa della regina degli dei, a lui affidata perché la sorvegliasse nella prigionia sotto forma di giovenca in cui l’aveva trasformata Zeus, per sfuggire all’ira di Era che lo aveva scoperto mentre cercava di possederla nascondendosi sotto forma di nube.
Conferma l’interpretazione che si è proposta la presenza della vecchia levatrice il cui volto, nel quale gli occhi brillano, non ha affatto l’aspetto di un volto generico ma è un vero e proprio ritratto inserito nel dipinto.
La rafforzano le due grandi conchiglie incastonate nella roccaglia sullo sfondo, rispetto alle altre rese con una evidenza ed un dettaglio tali che non è possibile fare a meno di vedervi un esplicito riferimento all’organo sessuale femminile.
 Sulla destra, infine, toglie ogni dubbio la scultura al centro della fontana. Secondo alcuni raffigurazione della stessa Madre Terra, secondo altri Venere rappresentata come dea della fertilità con mammelle multiple.
Sulla destra, infine, toglie ogni dubbio la scultura al centro della fontana. Secondo alcuni raffigurazione della stessa Madre Terra, secondo altri Venere rappresentata come dea della fertilità con mammelle multiple.
Chiarissimo “prestito” dalla Artemide Efesia (Diana per i Romani) del II secolo d.C. dei 1 Musei Capitolini presente in sala e probabilmente nota al pittore.
Scultura in "marmo lunense" (pietra ornamentale caratterizzata da un uniforme colore bianco candido, che può avere riflessi dorati. I Romani chiamavano questo litotipo “Marmor lunense” perché il più importante centro di estrazione e imbarco del materiale era la città di Luni, frazione di Ortonovo - La Spezia SP) e "bigio morato" (quest’ultimo per testa e mani) è ricoperta su tutti i lati da figure di animali in bassorilievo: in testa una cavalletta o un grillo, sul lato (dall’alto verso il basso) arpie, sfingi, leoni, un granchio,antilopi, grifoni, felini, ed i più placidi buoi. È l’intero mondo della creazione nella quale Artemide è immersa ed al quale, contemporaneamente, dà la vita. La sua particolarità che più colpisce l’osservatore è il suo essere anteriormente coperta da protuberanze che, secondo le indicazioni fornite in mostra, furono erroneamente interpretate come ghiandole mammarie mentre in realtà sono scroti di toro.
Dello stesso anno in cui dipinge La carità romana, il 1612, è un altro soggetto ispirato alla città Caput Mundi, anch’esso proveniente dai Musei Capitolini, che Rubens vuole celebrare ispirandosi al passato dal quale discende la sua gloria: La lupa allatta Romolo e Remo.
Se è universalmente noto che i gemelli Romolo e Remo furono allattati da una lupa, gli antecedenti di questo episodio sono meno conosciuti, dunque conviene richiamarli per comprenderlo meglio.
NASCITA DI ROMOLO E REMO
Innanzitutto siamo ad Alba Longa, città fondata nel XII sec a. C. da Ascanio, figlio del principe troiano Enea, a sua volta figlio di Venere. Lo storico Tito Livio (Patavium [Padova] 59 a. C. – 17 d. C.) la colloca sulla sponda orientale del lago di Albano, dalla parte opposta di Castel Gandolfo, e ci dice che fu distrutta dal re di Roma Tullio Ostilio dopo il 673 a. C..
Numitore, figlio maggiore di Proca, discendente da Enea e re dei Latini, è designato dal padre a succedergli come re. Tuttavia è spodestato ed imprigionato dal fratello Amulio, che ne uccide tutti i figli e, per impedirle di avere una discendenza, costringe la loro unica sorella, Rea Silvia, a diventare Vestale: ovvero sacerdotessa addetta a non far spegnere mai il fuoco acceso nel tempio di Vesta, sorella di Giove e dea del focolare domestico. Tuttavia il dio Marte s'innamorò di lei e, dopo averne vinto la resistenza, la rese madre dei gemelli Romolo e Remo. In questo modo è raggiunto l’obiettivo di nobilitare la nascita del fondatore di Roma facendolo discendere da due degli dei maggiori.
 Abbiamo già conosciuto alcune sale addietro questo genere di prodezze di Marte, quest’ultima, invece, è esposta alla sala successiva, insieme ad un suo bozzetto, nella visione di Rubens del 1616-17: Marte e Rea Silvia (Vienna, Palazzo Liechtenstein - The Princely Collections). Rea Silvia sembra spaventata e si ritrae davanti all’arrivo del dio della guerra, con un atteggiamento che ci ricorda il soggetto sacro dell’Annunciazione.
Abbiamo già conosciuto alcune sale addietro questo genere di prodezze di Marte, quest’ultima, invece, è esposta alla sala successiva, insieme ad un suo bozzetto, nella visione di Rubens del 1616-17: Marte e Rea Silvia (Vienna, Palazzo Liechtenstein - The Princely Collections). Rea Silvia sembra spaventata e si ritrae davanti all’arrivo del dio della guerra, con un atteggiamento che ci ricorda il soggetto sacro dell’Annunciazione.
Viceversa fra i due personaggi c’è Cupido che tocca entrambi, a significare che, per l’artista, questo amore era stato invece consenziente.
Particolarmente degna di nota è la cappa rossa di Marte. Il suo movimento svolazzante sottolinea il repentino arrivo del dio, uscito all’improvviso dalla nube, che vediamo sotto i suoi piedi, nella quale si era nascosto per arrivare di sorpresa al cospetto della sacerdotessa, e senza che altri potesse vederlo entrare nel tempio di Vesta; di cui, alle spalle di Rea Silvia, vediamo la statua che sovrasta l’altare col suo fuoco sacro.
Il colore rosso del mantello è, invece, un riferimento al carattere sanguinario di Marte. Anche i mantelli dei guerrieri spartani, soldati il cui valore militare è sempre stato riconosciuto da tutti, erano infatti rossi: perché realizzati con la pelle dei nemici scannati in guerra.
ROMOLO E REMO ALLATTATI DALLA LUPA
Il seguito della vicenda vede quindi Rea Silvia imprigionata e, dopo il parto, condannata a morte per ordine dello zio, come prevedeva la legge per le vestali che non rispettavano il voto di castità.
Non è chiaro se fu uccisa oppure morì di stenti. Ad ogni modo il suo corpo fu poi gettato nel Tevere (o nell’Aniene suo affluente in sinistra idrografica appena a nord di Roma) che, però, ne ebbe pietà, la resuscitò e ne fece sua moglie (secondo altre fonti fu, invece, liberata dalla prigione alla morte di Amulio).
Quanto ai gemelli appena nati, il re Amulio li affidò a due schiavi con l’ordine di adagiarli in una cesta, portarli nella parte più profonda del Tevere, ed affidarli alla corrente.
Ma per le piogge recenti il fiume era straripato ed aveva allagato i campi nella zona del Velabro (ad est dell’Isola Tiberina), così uno dei due propose di lasciarli là dove erano arrivati. L’altro condivise l’idea e spiegò ai piccoli cosa stava per accadere; i due emisero un vagito come se avessero capito e vennero spinti nel fiume nella loro cesta che, poco più a valle, si arenò poi in una pozza sulla riva, presso la palude del Velabro tra Palatino e Campidoglio.
Quando le acque del fiume si ritirarono, la cesta rimase all’asciutto ai piedi di un albero di fico selvatico.
Altre fonti fanno coincidere il punto dove si fermò la cesta con i gemelli con una grotta collocata alla base del Palatino, detta “Lupercale” perché sacra a Marte ed al Fauno Luperco.
 Ed eccoci quindi arrivati alla scena dipinta da Rubens che, fra le due citate, sceglie l’ambientazione sotto il fico; denominato “ruminale” o, secondo Tito Livio, “romulare” con riferimento rispettivamente al latino “ruma” che significa mammella (da cui anche i nomi di Romolo e Remo), visto che alla sua ombra i due bambini furono allattati dalla lupa, o al nome del fondatore di Roma.
Ed eccoci quindi arrivati alla scena dipinta da Rubens che, fra le due citate, sceglie l’ambientazione sotto il fico; denominato “ruminale” o, secondo Tito Livio, “romulare” con riferimento rispettivamente al latino “ruma” che significa mammella (da cui anche i nomi di Romolo e Remo), visto che alla sua ombra i due bambini furono allattati dalla lupa, o al nome del fondatore di Roma.
La leggenda prosegue, infatti, raccontando che i vagiti dei bambini attirarono l’attenzione di una lupa scesa dai monti al fiume per abbeverarsi. Raggiuntili si mise ad allattarli e la tradizione dice che anche un picchio portò loro del cibo. Ed ecco perché nel quadro ne vediamo uno che, in volo, offre due ciliegie ad uno dei bambini, nel quale è logico individuare Romolo visto che le ciliegie sono simbolo di vittoria ed in questo modo viene così simbolicamente rappresentata la maestosa grandiosità di Roma. Da notare è anche il fatto che entrambi gli animali sono sacri a Marte.
Da quanto sopra si è detto di lei è facile identificare nelle figure sulla sinistra la personificazione del fiume Tevere ed, accanto a lui, Rea Silvia, la madre dei gemelli divenuta sua sposa e la cui floridezza è emblematica dell’ideale di bellezza femminile del tempo che Rubens da par suo contribuiva a consolidare.
Opera dei suoi aiutanti sono invece ritenuti essere il picchio, le ciliegie e tutti gli altri dettagli naturalistici riferiti al fiume come le conchigliette sulla sabbia, i granchi ed i pesci. Resi con la puntuale fotografica abilità tipica della pittura fiamminga. E non è un caso visto che, come si è detto, l’opera è stata dipinta dopo che Rubens era ritornato a vivere nella sua terra natale.
L’ultimo riferimento alla vicenda che ritroviamo nel dipinto è il pastore che vediamo sopraggiungere da dietro la vegetazione. Si tratta di Faustolo, il custode dei porci del re Amulio, che li raccoglie e li porta nella sua capanna posta in cima al colle Palatino nella località detta “Germalo” (o “Cermalo”) dove, assieme alla moglie, Acca Larenzia, decide di adottarli e dove i due quindi cresceranno fino al momento in cui torneranno ad Alba Longa per reinsediare Numitore come legittimo re e si compirà il loro destino nella fondazione di Roma.
A proposito di Acca Larenzia, alcune versioni della storia attribuiscono questo nome alla lupa stessa che allattò i bambini. Poiché la parola “lupa” in latino ha anche il significato di prostituta (e da qui discende il vocabolo “lupanare”, ovvero luogo in cui avviene la prostituzione) non è escluso che il riferimento all’animale selvatico fosse in realtà un mascheramento del fatto che fu proprio una prostituta a salvarli.
XII SALA
“Il 28 ottobre 1608, a cavallo come vi era giunto, Rubens lascia l’Italia per non tornarvi mai più. L’amore per questo paese e il desiderio di farvi ritorno saranno in lui sempre fortissimi. Il suo insegnamento vive nelle opere dei tanti artisti che ne hanno seguito la strada”. Lo dimostra, chiudendo la mostra, a dire il vero in modo un po’ improprio, e non è chiaro se per scelta o per causa di forza maggiore, un dipinto non già di Rubens ma del suo seguace Luca Giordano: l’Allegoria della pace, Anch’esso proveniente dalla casa museo genovese di Palazzo Spinola, come il cavaliere già incontrato nel nostro percorso.
Per introdurlo giova ricordare che, nel 1638, “Rubens invia a Firenze al suo amico Justus Sustermans, che gliel’ha commissionata, un’opera grandiosa, densa di significati sottesi, Le conseguenze della guerra, oggi alla Galleria Palatina, che lo stesso Rubens descrive in una famosa lettera del 12 marzo 1638.

Ne sono protagonisti Marte e Venere, rappresentati dai simboli dell’armonia e della pace in contrasto con i terribili danni delle guerre. La forte componente ideale del quadro si manifesta in una scena altamente drammatica, tutta giocata in diagonale, in un intreccio di corpi, di piani affioranti, di moti, che precipitano verso lo spettatore. Rubens s’ispira a un tragico evento storico: il ritorno della guerra in Fiandra, fra le truppe spagnole destinate a soccombere e quelle francesi alleate degli olandesi, in un prevalere della violenza e della brutalità sulla ragione. La forza simbolica, ma allo stesso tempo attualissima, del quadro realizzato per Sustermans non sfugge a chi vi coglie, sottolineandolo, proprio tutto il sentimento di dolore espresso da Rubens nella lettera all’amico sul triste destino dell’Europa devastata dalle continue guerre e da lui dipinta con il volto solcato di meravigliose lacrime. Quella matrona lugubre, vestita di nero, con il velo stracciato e spogliata delle sue gioie e d’ogni sorta di ornamenti, è infatti l’infelice Europa, la quale già da tanti anni soffre per le rapine, gli oltraggi e le miserie che la affliggono. Il tema stava molto a cuore all’artista: per anni, e spesso con successo, Rubens aveva profuso la sua intelligenza e tante energie in un’intensa attività diplomatica volta al bene comune della pace, che vede ora irrimediabilmente infranto. Dopo la sua partenza nel 1608, Rubens non torna più in Italia e, a due anni dalla morte, nel 1638, questo suo dipinto grandioso e accorato su un tema così universale, destinato ad un amico caro, a Firenze, patria del Rinascimento, appare come un compendio finale della sua vita di artista e di uomo”.
Il quadro lascia un segno indelebile in chi l’ha visto. Pochissimi anni dopo, tra il 1641 e il 1642, impegnato negli affreschi della sala di Venere a Palazzo Pitti, Pietro da Cortona cita la Venere del capolavoro di Rubens nella figura di Pallade che strappa l’Adolescenza dalle braccia di Venere, dipinta in controparte, nella stessa impetuosa ascesa.
Anche Luca Giordano, rende omaggio a Rubens sul tema della pace, nella grande tela degli anni sessanta, ancora più esplicita, raffigurante Rubens che dipinge l’allegoria della pace (Madrid, Museo del Prado).
Per L’artista napoletano Rubens è un mito. Come si è già detto ne conosce infatti molto bene l’opera, anche grazie alla fama suscitata a Napoli da alcuni capolavori del pittore fiammingo presenti in varie collezioni. Giordano è attratto dalle scene turbinose, dense di impulsi drammatici. Per questo compone con la stessa ardita destrezza, tanto da guadagnarsi la definizione: «Genio vasto, risoluto, creatore» (Lanzi). A volte non è solo il linguaggio concitato di Rubens in generale a ispirare Giordano, ma il desiderio di condividere un tema specifico dipinto dal maestro fiammingo e di rendere così omaggio a un’opera in particolare. È questo appunto il caso della nostra grandiosa tela dell’Allegoria della pace con la quale termina il percorso della mostra per la quale Luca Giordano si rifà direttamente a due originali di Rubens: Minerva protegge la pace da Marte, presso la National Gallery di Londra (immagine sottostante), ed il sopra menzionato Le conseguenze della guerra nella Galleria Palatina a Firenze.

Dipinta 40 anni dopo il quadro di Rubens di analogo soggetto, dimostra quanto fosse forte (e resistente nel tempo) l’influsso che il maestro aveva lasciato nei suoi “discepoli”, seppure non diretti ma d’adozione. Purtroppo le sue condizioni di conservazione non sono ottimali per via della patina ingiallita che la ricopre: risultato della degradazione nel tempo della protezione che vi era stata applicata.
Il problema, che al giorno d’oggi si evita usando una protezione trasparente, non impedisce di rilevare come l’opera sia pervasa da un senso di movimento inarrestabile.

La Pace vi è rappresentata in lotta con le figure dell’Odio, nelle sembianze di un’anziana seminuda, e della Guerra, in quelle di Marte, o comunque di un uomo in armi.
Al suono della tromba dell’angelo in volo sopra di lei, che l’Odio cerca di sfuggire portando le mani a coprirsi le orecchie, con un gesto eloquente delle braccia distese la Pace sospinge i due avversari lontano da sé e dal centro della composizione. Come volesse fisicamente scacciarli fuori dalla scena fino al punto da portarli quasi ad affiorare sulla superficie della tela.
Densa di simboli di armoniosa convivenza, dipinti con toni metallici e fortemente contrastati, anch’essi ispirati ai modi di Rubens, sul lato opposto Luca Giordano vi dipinge il ritorno delle arti, come la musica e la danza, ed il ritorno della prosperità, simboleggiata dal putto che ha in mano spighe di grano.
Al centro, in primo piano, è invece la più emblematica delle immagini: quella di tre putti con ali di farfalla che giocano “addosso” ad una fiera, addirittura coronandola di fiori.
Da notare un dettaglio nel muso dell’animale: il pittore vi corregge un errore, “girandolo” frontalmente rispetto all’iniziale posizione di profilo e rivolta verso i piccoli, ma il muso resta “doppio”!
L’insieme, in questo grande dipinto, conferma quanto sia ancora vivo a fine secolo il fascino esercitato da Rubens sulla generazione di artisti più giovani che, comprendendone tutta la novità, riprendono e divulgano lo stile del maestro.
Con un particolare ringraziamento a Guido Codecasa
per il sempre prezioso e puntuale supporto
nelle ricerche e nella verifica di ipotesi.
NOTA BENE