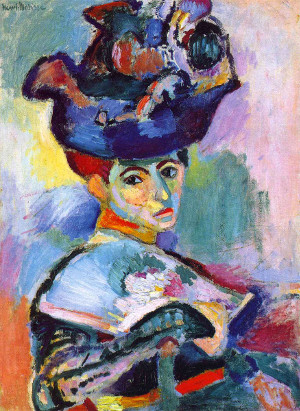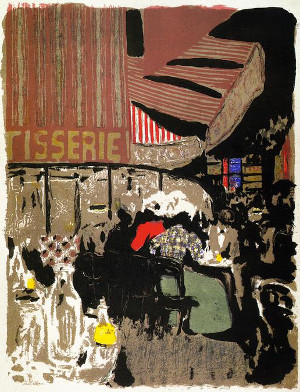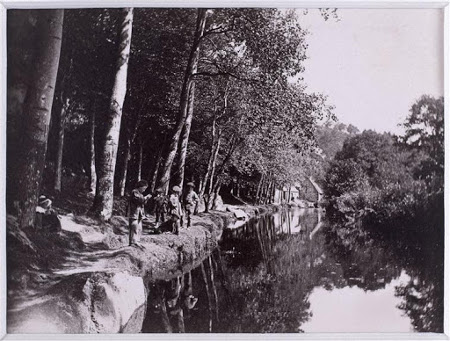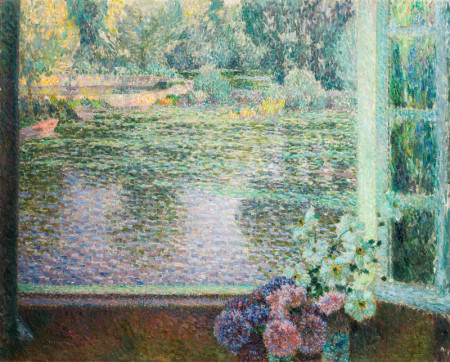L'Eclettico
Vista dall'Africa: la mia Europa che dipinge
Scuole nazionali fra Otto e Novecento nel sogno realizzato di Lady Phillips ... E la sorpresa che non ti aspetti
L'ECLETTICO - web "aperiodico"
VISTA DALL'AFRICA: LA MIA EUROPA CHE DIPINGE
Scuole nazionali fra Otto e Novecento nel sogno realizzato di Lady Phillips
“È bello che anche a Monza si facciano di queste cose, se devo essere sincera da questo punto di vista non l’ho mai considerata”. Così una visitatrice, commentando la mostra “Da Monet a Bacon, capolavori della Johannesburg Art Gallery” tributa il meritato riconoscimento al lavoro di chi, anche con queste iniziative, valorizza le sale della Villa Reale di Brianza.
Aspettandoci dunque che la strada intrapresa continui ad essere seguita, per gli allestimenti futuri corre tuttavia l’obbligo di suggerire una maggiore attenzione a risolvere positivamente le interferenze con le fonti luminose, naturali ed artificiali, preesistenti in una sede non appositamente realizzata per ospitarvi mostre d’arte.
Quando anche chiusi (non sempre con la dovuta tempestività), gli scuri in legno interni alle finestre si sono dimostrati insufficienti a schermare la luce abbagliante proveniente da fuori, perciò i dipinti inopportunamente collocati lungo le pareti finestrate inevitabilmente risultano completamente oscurati dall’effetto controluce, quando sono ad esse paralleli, e comunque disturbati dai riflessi se ortogonali.
Un problema analogo è determinato anche dai punti luce a servizio dell’illuminazione ordinaria delle sale. Anch’essi infatti abbagliano il visitatore colpendone gli occhi proprio da sopra le pareti temporanee dell’allestimento dove sono appesi i dipinti.
Per queste ragioni, fra le opere risultate peggio visibili, si possono paradossalmente citare, quasi un contrappasso, proprio il Mattino soleggiato del 1910 di Lucien Pisarro (Parigi, 1865 – Hewwood, Londra, 1944), figlio del più celebre Camille, oltre all’Otello di Daniel Maclise ed, addirittura, alla Primavera di Monet: unico suo dipinto in mostra.
A questo proposito occorre ammettere che non si può dar torto ai visitatori delusi perché indotti a credere dal titolo della mostra, sebbene formalmente ineccepibile, che avrebbero trovato il capostipite degli Impressionisti rappresentato con qualcosa in più di un’opera.
Ciò doverosamente rilevato, è però altrettanto giusto riconoscere che nessuna voce si è levata a lamentare l’analoga scarsità di… Bacon! Nel complesso, con un’assonanza alimentare forse un po’ troppo facile, la mostra può essere riassunta come un pranzo di matrimonio in cui viene servito un assaggio di tutto; e nello specifico non sempre di prima scelta: a nostro modesto modo di vedere non abbiamo infatti rilevato la presenza di capolavori assoluti nonostante il prestigioso dispiegamento di celebrità fra gli artisti in catalogo.
Un limite che tuttavia, in una logica di formazione – educazione del pubblico alla quale auspichiamo che le produzioni d’arte sempre più dedichino attenzione (leggi di più in Mostre d’arte, fu vera gloria? >>>), ha avuto anche un risvolto positivo. Specialmente per chi non ha una competenza artistica di primo livello, come il sottoscritto, questa mostra si è infatti risolta nell’opportunità di poter operare immediati e diretti confronti fra scuole ed autori nell’ambito di un itinerario, seppure essenziale, nell’arte occidentale dell’Otto-Novecento. Un utile ripasso e verifica di quanto appreso ed assimilato dall’assidua frequentazione di mostre monografiche.
Cosicché, fra prima visita “panoramica” e successivi ritorni, avanti e indietro fra le sale, per approfondire osservazioni e trovare conferme ad intuizioni, anche in questa occasione le diverse ore della nostra visita sono volate. Perché i quadri non si possono guardare come fossero scarpe in vetrina, se ci sofferma davanti a lungo e poi si torna a rivederli cercando di fissarli nella memoria, dopo qualche ora di questo esercizio li si “impara” e ci diventano familiari, ed è allora che cominciano a parlarci riservandoci sorprese non scontate.
 Altra valenza della mostra, che diremmo la più rilevante, è il suo essere una concreta testimonianza del percorso di formazione della Johannesburg Art Gallery (JAG), con le evidenze storiche di donatori ed allestimenti originali ben riconoscibili su gran parte delle cornici (nell'immagine a lato si nota in basso la didascalia del tempo: Landscape By J.B. COROT B. 1796 D. 1875 French School = Paesaggio Di J.B. COROT Nato (Born) 1796 Morto (Died) 1875 Scuola Francese) e, dal punto di vista artistico, con la curiosità suscitata dalle sue sezioni d’apertura e finale: rispettivamente l’arte inglese dei Preraffaelliti e l’arte africana, non folcloristica, del Novecento. Interessanti, l’una e l’altra, proprio perché inconsuete nell’ordinaria programmazione espositiva.
Altra valenza della mostra, che diremmo la più rilevante, è il suo essere una concreta testimonianza del percorso di formazione della Johannesburg Art Gallery (JAG), con le evidenze storiche di donatori ed allestimenti originali ben riconoscibili su gran parte delle cornici (nell'immagine a lato si nota in basso la didascalia del tempo: Landscape By J.B. COROT B. 1796 D. 1875 French School = Paesaggio Di J.B. COROT Nato (Born) 1796 Morto (Died) 1875 Scuola Francese) e, dal punto di vista artistico, con la curiosità suscitata dalle sue sezioni d’apertura e finale: rispettivamente l’arte inglese dei Preraffaelliti e l’arte africana, non folcloristica, del Novecento. Interessanti, l’una e l’altra, proprio perché inconsuete nell’ordinaria programmazione espositiva.
 Ad introdurci nel mondo che la sua ispirazione è stata in grado di immaginare ed allestire è dunque la fondatrice della JAG: Lady Florence Phillips in persona.
Ad introdurci nel mondo che la sua ispirazione è stata in grado di immaginare ed allestire è dunque la fondatrice della JAG: Lady Florence Phillips in persona.
Dorothea Sarah Florence Alexandra Ortlepp (Città del Capo, 14 giugno 1863 – Vergelegen, 23 agosto 1940), sebbene nata in Sudafrica era per cultura pienamente Britannica. Nel 1885 sposa il Baronetto Sir Lionel Phillips, un magnate del settore minerario e uomo politico e con lui si trasferisce dapprima a Johannesburg (nel 1889) e successivamente a Londra.
I - LA PITTURA INGLESE DELL'OTTOCENTO
Antonio Mancini (Roma, 1862 - 1930), pittore che, grazie al gallerista Goupil, gode di buona notorietà come ritrattista a Londra fra il 1901 e il 1907, ce la presenta a 46 anni, nel 1909: l’anno che precede l’avvio della sua iniziativa filantropica. L’apertura della Johannesburg Art Gallery avviene infatti nel 1910, con una presentazione della sezione francese delle sue opere a Londra, prima del loro trasferimento in Sudafrica.
Il ritratto, dal quale ci guarda appoggiata con un gomito allo scrittoio, davanti ad un fondo giallo, come se ci ricevesse al banco dell’accoglienza del suo museo, ne trasmette egregiamente il carattere di pacata risolutezza: requisito indispensabile per la riuscita dell’impresa.
Suo primo e principale collaboratore fu Sir Hugh Percy Lane, un irlandese che viveva a Londra ed al quale si affidò nell’orientare i suoi acquisti dopo un avvio autonomo ispirato dalla sua inclinazione personale. A questo si deve il fatto che, nel primo nucleo della collezione Phillips, se consideriamo i classici fuori categoria, troviamo i vertici dell’arte nel gusto dei britannici del tempo: ovvero il Primo Ottocento inglese.
 Fra questi il massimo pittore dell’epoca Vittoriana ed Edoardiana l’olandese di nascita Sir Lawrence Alma Tadema (Dronrijp, Olanda del nord, 1863 – Wiesbaden, Francoforte, 1918).
Fra questi il massimo pittore dell’epoca Vittoriana ed Edoardiana l’olandese di nascita Sir Lawrence Alma Tadema (Dronrijp, Olanda del nord, 1863 – Wiesbaden, Francoforte, 1918).
In mostra abbiamo il suo drammatico La morte del primogenito (del Faraone), del 1858. Un soggetto che ripropone molte volte, perché gli consente di rappresentare sempre il lato più oscuro ed immaginifico dell’antico Egitto. Qui reso con cura in particolari quali i diademi a forma di cobra sulle coroncine di madre e figlio, la gonnella decorata del bambino con i suoi disegni geometrici e l’avvoltoio stilizzato al centro…
Ma più che il dettaglio ciò che colpisce lo spettatore è l’imponenza impotente del Faraone. La si intuisce per il suo essere fuori scena nonostante regga sulle sue ginocchia il corpo esanime del figlio, sul quale si piega la madre affranta dallo sguardo perso nel vuoto. Un insieme che fa pensare alle deposizioni Cinque Seicentesche.
Abile nel suscitare l’interesse di industriali e di appartenenti al suo ambiente sociale, mentre la sua collezione cresce Lady Phillips riesce ad arricchirla grazie a donazioni prestigiose. Come quella di Sir Sigismund Neumann che, nel 1912, le regala arredi vittoriani e opere di Preraffaelliti.
Tra i fondatori, nell’autunno del 1848, di questo movimento artistico, la Confraternita dei Preraffaelliti, è il pittore e poeta Gabriel Charles Dante Rossetti (Londra, 12 maggio 1828 - Birchington-on-Sea, 9 aprile 1882). Figlio di un esule italiano, cultore della civiltà del suo paese, assunse il nome pubblico di Dante Gabriel Rossetti per sottolineare maggiormente l’affinità che sentiva di avere con la sua patria d’origine e culla del Rinascimento e la sintonia che provava per il poeta fiorentino del quale tradusse sistematicamente gran parte dell’opera poetica.
 In mostra abbiamo il suo Regina cordium.
In mostra abbiamo il suo Regina cordium.
Ne è protagonista Elizabeth Siddal, modella ed anch’essa pittrice, dipendente dal laudano (derivato dall’oppio che veniva mescolato all’assenzio per produrre un distillato allucinogeno) col quale si toglie la vita nel 1862, dopo una lunga e tormentata storia d’amore con chi, due anni prima, nell’anno del loro matrimonio, l’ha ritratta: riconoscendone la luce spenta negli occhi senza però riuscire a riportarvi una ragione che potesse dare senso alla sua esistenza.
Il titolo, che naturalmente non richiede spiegazioni, è ribadito più volte nel dipinto. Per lo più esplicitamente e nel colore intenso della massa dei lunghi capelli di Elizabeth, rossi come i quattro giri della collana di corallo che la orna ed alla quale è appeso un ciondolo anch’esso rosso ed a forma di cuore. Così come sono rosse le linee che isolano tanti piccoli cuori sullo sfondo oro. In mano ha, invece, una viola, fiore dai vari significati simbolici ma con foglie dal profilo esattamente in tema.
 Cofondatori della Confraternita furono anche William Hunt, Ford Madox Brown e John Everett Millais (Southampton, 8 giugno 1829 - Kensington, Londra, 13 agosto 1896), quest’ultimo a sua volta in mostra con due dipinti di grandi dimensioni, entrambi donati alla Phillips nel 1910: rispettivamente da Mrs. G.F. Watts e da Sir Julius Wernher. Come ci suggeriscono i loro nomi, scritti a eleganti caratteri nero su oro dopo la comune dicitura “Presented by…”, sulla parte alta delle belle cornici originali, se non delle opere, almeno del loro allestimento nella JAG.
Cofondatori della Confraternita furono anche William Hunt, Ford Madox Brown e John Everett Millais (Southampton, 8 giugno 1829 - Kensington, Londra, 13 agosto 1896), quest’ultimo a sua volta in mostra con due dipinti di grandi dimensioni, entrambi donati alla Phillips nel 1910: rispettivamente da Mrs. G.F. Watts e da Sir Julius Wernher. Come ci suggeriscono i loro nomi, scritti a eleganti caratteri nero su oro dopo la comune dicitura “Presented by…”, sulla parte alta delle belle cornici originali, se non delle opere, almeno del loro allestimento nella JAG.
Entrambi con titoli quasi onomatopeici Stich! Stich! Stich! (Cuci, cuci, cuci!), del 1876, il primo e Cuckoo! (Il cuculo!), del 1880, il secondo, sono per la verità ascrivibili al periodo in cui, dopo il matrimonio nel 1856 con Euphemia Chalmers Gray, più nota come Effie Gray e già moglie del critico d’arte John Ruskin, il pittore si era allontanato dallo stile dei Preraffaelliti per privilegiare temi sociali o ritratti di bambini, come nel nostro caso.
 Con ottimi risultati, come vediamo, nonostante la critica fu per questo severa con lui. La ragazzina dipinta di spalle, con pennellate lunghe sui toni del grigio, seppure con delicatezza ci lascia intuire lo sfruttamento lavorativo dell’infanzia di quei tempi. Descritto in quegli stessi anni nei romanzi di Dickens e ben più brutale di quanto il dipinto ci lasci intendere col suo pure imperioso triplice richiamo a non smettere di cucire che ci propone con l’eloquente titolo.
Con ottimi risultati, come vediamo, nonostante la critica fu per questo severa con lui. La ragazzina dipinta di spalle, con pennellate lunghe sui toni del grigio, seppure con delicatezza ci lascia intuire lo sfruttamento lavorativo dell’infanzia di quei tempi. Descritto in quegli stessi anni nei romanzi di Dickens e ben più brutale di quanto il dipinto ci lasci intendere col suo pure imperioso triplice richiamo a non smettere di cucire che ci propone con l’eloquente titolo.
Tenerissima espressione di affettuosa familiarità è, invece, la rappresentazione di due bambine (forse sorelline?) sedute sul sentiero di un bosco autunnale. Con la grande assorta nei suoi pensieri mentre la piccolina le si avvicina e la invita ad ascoltare il ripetersi dell’atteso verso del cuculo. Del bosco non vediamo gli alberi ma solo l’ombra delle chiome, un tronco caduto (proprio nel punto giusto!), l’accenno della luce di una chiaria sullo sfondo ed a terra il letto di foglie punteggiato di fiori dai colori vivaci.
In primo piano, sebbene laterali, sono ben riconoscibili sulla destra le grandi foglie verdi del gigaro, che indicano pioggia quando si arrotolano, ed a sinistra, nell’angolo racchiuso fra il vestito bianco della grande ed il margine della tela, il curatissimo dettaglio di una realistica foglia secca di quercia.
 Osservazione che ci riporta ad uno dei temi ricorrenti nelle opere giovanili di Millais: l’attenzione naturalistica. Attenzione che in dipinti come Ofelia (il tragico personaggio Shakespeariano dell’Amleto), del 1881 e presentato alla Royal Academy nel 1852, era arrivata ad eccezionali livelli di dettaglio. Per raggiungere un tale traguardo l’autore si era infatti trasferito per alcuni mesi in campagna dove aveva potuto studiare dal vero la vegetazione ripariale del Tamigi. Cosicché la cornice floreale che circonda la bellissima Ofelia (per la quale, immersa in una vasca da bagno, aveva posato Elizabeth Siddal) è restituita con un naturalismo quasi scientifico. Fatto che, comunque non preclude significati simbolici, i Preraffaelliti, infatti possono essere con ragione ascritti al più ampio movimento culturale del Simbolismo. Nello specifico di questo dipinto il salice, l’ortica e le margherite, associati all’innocenza, discendono direttamente da Shakespeare, mentre il papavero, simbolo della morte, e le olmarie appassite, allusive alla vanità della vita, sono un’aggiunta del pittore.
Osservazione che ci riporta ad uno dei temi ricorrenti nelle opere giovanili di Millais: l’attenzione naturalistica. Attenzione che in dipinti come Ofelia (il tragico personaggio Shakespeariano dell’Amleto), del 1881 e presentato alla Royal Academy nel 1852, era arrivata ad eccezionali livelli di dettaglio. Per raggiungere un tale traguardo l’autore si era infatti trasferito per alcuni mesi in campagna dove aveva potuto studiare dal vero la vegetazione ripariale del Tamigi. Cosicché la cornice floreale che circonda la bellissima Ofelia (per la quale, immersa in una vasca da bagno, aveva posato Elizabeth Siddal) è restituita con un naturalismo quasi scientifico. Fatto che, comunque non preclude significati simbolici, i Preraffaelliti, infatti possono essere con ragione ascritti al più ampio movimento culturale del Simbolismo. Nello specifico di questo dipinto il salice, l’ortica e le margherite, associati all’innocenza, discendono direttamente da Shakespeare, mentre il papavero, simbolo della morte, e le olmarie appassite, allusive alla vanità della vita, sono un’aggiunta del pittore.
 Di gusto classicheggiante, tratto caratteristico del suo autore, è invece la Venere al bagno, del 1867, di Albert Joseph Moore (York, 1841 - Londra, 1893). Dono di Charles Mr. Rube alla JAG nel 1920, è dipinta sui toni tenui del rosa, con giri di collane viola, una pelle di leopardo come tappeto mentre in alto sulla destra si apre una mezza finestrella che tuttavia non vale a dare profondità all’insieme.
Di gusto classicheggiante, tratto caratteristico del suo autore, è invece la Venere al bagno, del 1867, di Albert Joseph Moore (York, 1841 - Londra, 1893). Dono di Charles Mr. Rube alla JAG nel 1920, è dipinta sui toni tenui del rosa, con giri di collane viola, una pelle di leopardo come tappeto mentre in alto sulla destra si apre una mezza finestrella che tuttavia non vale a dare profondità all’insieme.
Dello stesso anno, il 1867, è Otello, Desdemona ed Emilia di Daniel Maclise (Cork, Irlanda, 25 gennaio 1806, - Chelsea, Londra, Regno Unito, 25 aprile 1870). Irlandese, letterato, storico e pittore. Lavora a Londra ed ha successo come pittore di genere storico.
E Shakespeare è un’infinita fonte di soggetti per gli artisti vittoriani.
Qui con i principali protagonisti della tragedia vediamo, in atteggiamento riservato, Emilia, la moglie dell’infido Iago ed involontaria complice del suo piano per screditare Cassio, luogotenente del Moro: il capo dell’esercito di Venezia contro i turchi.
Sarà uccisa dal marito quando svelerà l’inganno e la falsità delle accuse a Desdemona.
 Rispetto alla resa un po’ formale ed artificiosa dei sentimenti, nel dipinto risultano più interessanti le riproduzioni floreali. Sia quelle che vorrebbero essere realistiche, come gli oleandri nel vaso in primo piano, sia quelle ricamate: come le fragole sul fazzoletto di Desdemona, i fiori e le foglie sulla manica della sua veste e la composizione sul petto di Otello: richiamata anche sulla manica del braccio che porta al volto in un gesto tanto teatralmente plateale quanto poco credibile.
Rispetto alla resa un po’ formale ed artificiosa dei sentimenti, nel dipinto risultano più interessanti le riproduzioni floreali. Sia quelle che vorrebbero essere realistiche, come gli oleandri nel vaso in primo piano, sia quelle ricamate: come le fragole sul fazzoletto di Desdemona, i fiori e le foglie sulla manica della sua veste e la composizione sul petto di Otello: richiamata anche sulla manica del braccio che porta al volto in un gesto tanto teatralmente plateale quanto poco credibile.
Decorazioni, queste ultime, che fanno pensare (molto da lontano) ai tessuti rinascimentali di Foppa, Boltraffio e degli altri Leonardeschi che abbiamo visto, ad esempio, al Poldi Pezzoli di Milano (e descritto in Sotto il segno di Leonardo. La magnificenza della corte sforzesca nelle collezioni del Museo Poldi Pezzoli leggi di più in >>>).
Nell’insieme, per quanto siamo riusciti a vederne a causa del problema dell’inopportuna collocazione evidenziato in apertura, seppure a suo modo interessante, Maclise, ci ricorda Hayez: ma 100 anni dopo ed in minore.
Più interessanti, sotto il profilo storico e della formazione della collezione, sono il fatto che quest’opera è la prima in mostra fra quelle donate dall’industriale Otto Beit nel 1910, come recita la didascalia in alto.
Sul lato basso della cornice sono invece riportati, sempre al modo già descritto, 1’autore, con indicazione delle date di nascita e morte introdotte dalle iniziali puntate B. (Born, nato) e D. (Dead, morto), titolo e datazione dell’opera, e sua classificazione. In questo caso “British School” perché la suddivisione della JAG era impostata sulle Scuole nazionali.
In chiusura della prima sezione, dopo i dipinti ad olio fin qui descritti, troviamo tre esempi di altre tecniche.
 Un acquerello di Arthur Winter Moore (1840-1913), La cripta, firmato A.W.M. 1911. Anch’esso poco visibile a causa dei riflessi delle finestre aperte sul vetro di protezione, è comunque piacevole a vedersi e ricorda le cripte teatro delle vicende più o meno fosche narrate dalle opere teatrali e musicali.
Un acquerello di Arthur Winter Moore (1840-1913), La cripta, firmato A.W.M. 1911. Anch’esso poco visibile a causa dei riflessi delle finestre aperte sul vetro di protezione, è comunque piacevole a vedersi e ricorda le cripte teatro delle vicende più o meno fosche narrate dalle opere teatrali e musicali.
Infine, postposte rispetto ad una successione esattamente cronologica, sono un acquerello (a lato) ed un’incisione di Joseph Mallord William Turner (Covent Garden, Londra, 1775 - Cheyne Walk, Londra, 19 dicembre 1851). La collocazione è però giustificata per il fatto che le sue rupi ed i suoi castelli, che vediamo anche qui, sono emblematici del suo stile appartenente al romanticismo inglese, nel quale la natura diventa protagonista e che pone le basi dell’Impressionismo che ci attende nelle sale successive.
II - REALISMO E PRE-IMPRESSIONISTI
Il nuovo approccio al vero in pittura tratta infatti la natura non più come un semplice sfondo ma come soggetto autonomo e con una sua propria personalità, come avveniva per i ritratti.
Ed il più significativo esponente del movimento realista, Gustave Courbet (Ornans, Francia 10 giugno 1819 - La Tour-de-Peilz, Svizzera 31 dicembre 1877) ci appare in mostra con La scogliera à Etretat. Un’imponente, monumentale, falesia in Normandia (dipinta anche da Monet ed altri) che fa da quinta ad un cielo ed un mare dipinti con un’“imperfetta” stesura del colore che fa sembrare “concreta” la spiaggia sulla quale, accanto alle barche tirate a riva, l’autore appone la sua geometrica firma.
 Sempre catalogati dalla JAG come “French School” chiudono la sezione dei Pre-Impressionisti un piccolo paesaggio di Jean-Baptiste Camille Corot (Parigi,16 luglio 1796 - 22 febbraio 1875), considerato fra i più sensibili paesaggisti dell’Ottocento, ed un carboncino del 1840 c.a. di Jean-François Millet (Gréville-Hague, 4 ottobre 1814 - Barbizon, 20 gennaio 1875), sempre sensibile ai temi sociali che tanto ascendente ebbero anche su Van Gogh, come qui dimostra in Un contadino, disegnato mentre si riposa appoggiato alla sua vanga.
Sempre catalogati dalla JAG come “French School” chiudono la sezione dei Pre-Impressionisti un piccolo paesaggio di Jean-Baptiste Camille Corot (Parigi,16 luglio 1796 - 22 febbraio 1875), considerato fra i più sensibili paesaggisti dell’Ottocento, ed un carboncino del 1840 c.a. di Jean-François Millet (Gréville-Hague, 4 ottobre 1814 - Barbizon, 20 gennaio 1875), sempre sensibile ai temi sociali che tanto ascendente ebbero anche su Van Gogh, come qui dimostra in Un contadino, disegnato mentre si riposa appoggiato alla sua vanga.
III - GLI IMPRESSIONISTI
A volte i donatori sono più d’uno, come nel caso di Mr. and Mrs. R. W. Schumacher che, nel 1910, offrono alla JAG il primo degli Impressionisti che incontriamo in mostra. Curiosamente non si tratta di un francese, ma di un pittore che per le sue origini, è catalogato come “Dutch School”, ovvero Scuola Olandese: Johan Barthold Jongkind, nato nei pressi di Rotterdam (Lattrop, 3 giugno 1819 – La Côte-Saint-André, 9 febbraio 1891) e trasferitosi in Francia, naturalmente a Parigi, nel 1843.
Nella capitale conobbe e frequentò Manet, Monet e Boudin con i quali si intratteneva in discussioni che avranno ripercussioni sulle rispettive esperienze artistiche, ed anche se nel 1863 partecipò al Salon des Refusés, rimase sempre quasi del tutto isolato dal gruppo degli Impressionisti non partecipando a nessuna delle loro otto mostre. Invece nel 1848 i suoi dipinti furono accettati al Salon Officiel, dove vinse la medaglia del primo premio nel 1852. Faticava tuttavia a trovare acquirenti nonostante proprio in quegli anni la sua arte acquistò una sicurezza stilistica che gli permise di realizzare, senza difficoltà, scorci arditi e complessi: come si è recentemente visto anche nel suo Notre Dame e Senna del 1864 esposto in questi stessi giorni nella mostra dedicata a Manet ed alla Parigi moderna.
 Ma Jongkind era in particolare attratto dai paesaggi costieri della Francia settentrionale, la cui natura selvaggia lo affascinava e che, fino al 1865, lo indusse a recarsi più volte in Normandia, ed oltre. È questo il periodo in cui dipinge l’opera in mostra: La foce del fiume Scheldt, del 1854. Un dipinto che lo riassume anche geograficamente, visto che la Schelda ha la sorgente nel nord della Francia ma poi entra in Belgio e sfocia nel Mare del Nord dopo aver lambito Anversa.
Ma Jongkind era in particolare attratto dai paesaggi costieri della Francia settentrionale, la cui natura selvaggia lo affascinava e che, fino al 1865, lo indusse a recarsi più volte in Normandia, ed oltre. È questo il periodo in cui dipinge l’opera in mostra: La foce del fiume Scheldt, del 1854. Un dipinto che lo riassume anche geograficamente, visto che la Schelda ha la sorgente nel nord della Francia ma poi entra in Belgio e sfocia nel Mare del Nord dopo aver lambito Anversa.
Il pittore ce la propone focalizzando la sua attenzione sul vento che sferza la costa: materializzato nelle vele tese che inclinano gli alberi del vascello in primo piano e fanno correre le nubi in un cielo dipinto con l’azzurro di lunghe pennellate trasversali che attraversano la tela e che una sottile linea di terra all’orizzonte - sulla quale si intravedono sagome di edifici a servizio delle attività portuali - separa dal mare: fatto di pennellate sinuose che intrecciano onde brune, per i materiali di fondo che le correnti sollevano portano in sospensione.
 Il merito di aver indotto Florence Phillips a cambiare il suo punto di vista sull’arte, facendole scoprire la scena artistica di fine secolo, in particolare quella impressionista, spetta a Sir Hugh Percy Lane: esperto d’arte e mercante anglo-irlandese è un appassionato mecenate che seleziona ed acquista opere per la Municipal Gallery of Modern Art di Dublino (oggi Dublin City Gallery the Hugh Lane).
Il merito di aver indotto Florence Phillips a cambiare il suo punto di vista sull’arte, facendole scoprire la scena artistica di fine secolo, in particolare quella impressionista, spetta a Sir Hugh Percy Lane: esperto d’arte e mercante anglo-irlandese è un appassionato mecenate che seleziona ed acquista opere per la Municipal Gallery of Modern Art di Dublino (oggi Dublin City Gallery the Hugh Lane).
A differenza di Lady Phillips, Lane (a lato in un ritratto di Sargent) ha gusti ben più aggiornati ed un notevole intuito: la sua passione per la scena francese della metà dell’Ottocento lo porta a diventare uno dei più strenui difensori dell’Impressionismo, che valorizza a Londra prima di altri. Sono di sua proprietà alcuni tra i capolavori più noti e amati di quel movimento, ad esempio Gli ombrelli di Renoir, oggi alla National Gallery di Londra.
I due si conoscono a Londra nel 1909 e Lane ha buon fiuto nello spinge Lady Phillips a superare il confine del XVIII secolo, facendole acquistare alcuni lavori più recenti, come quelli di Philip Wilson Steer, visto assieme durante una mostra di Goupil. Per trovare i fondi per comprare i tre dipinti dell’allora molto noto paesaggista inglese seguace dell’Impressionismo, Florence vende un diamante azzurro che le aveva regalato il marito.
Altre successive importanti acquisizioni su questo versante precedono le scelte dei musei britannici, ancora poco inclini ad apprezzare la pittura dell’Ottocento francese, anche a causa dello storico antagonismo culturale tra Londra e Parigi. Cosicché, nel 1910, è grande l’interesse suscitato dall’esposizione londinese del nucleo di arte francese destinato al museo sudafricano. La collezione di Johannesburg, così, finisce con l’anticipare (e forse in qualche modo condizionare) le tendenze museali che negli anni seguenti caratterizzeranno anche il territorio britannico.
Come già rilevato, accanto agli acquisti diretti, la JAG beneficia della generosità di donatori fra i quali troviamo, a più riprese fra il 1910 ed il 1913, l’industriale Otto Beit, che già abbiamo conosciuto per l’Otello e che ha un ruolo di spicco fra i benefattori della Phillips. Almeno in mostra, visto che sono suoi ben sei dei dipinti esposti: cinque dei quali, e fra i più importanti, degli Impressionisti.
 Il primo di essi è Henri-Joseph Harpignies (Valenciennes, 28 giugno 1819 – Saint-Privé, 28 agosto 1916) con Il burrone. Un bel dipinto di una piccola valle, selvaggia ma non troppo (!), tutta realizzata sui toni del verde dei grandi alberi che seminascondono i dirupi di un orrido al fondo del quale scorre un torrente.
Il primo di essi è Henri-Joseph Harpignies (Valenciennes, 28 giugno 1819 – Saint-Privé, 28 agosto 1916) con Il burrone. Un bel dipinto di una piccola valle, selvaggia ma non troppo (!), tutta realizzata sui toni del verde dei grandi alberi che seminascondono i dirupi di un orrido al fondo del quale scorre un torrente.
Una donna, elegante nell’abito e nel portamento, passeggia in primo piano in questo paesaggio che giustifica la considerazione di cui godeva Harpignies: ritenuto tra i paesaggisti più fecondi del suo tempo. All’Impressionismo aderì soltanto negli ultimi anni della sua vita, mentre prima fu più forte nella sua arte l’influenza di Corot e della Scuola di Barbizon: denominazione con la quale si identifica il gruppo di pittori paesaggisti del realismo francese (quali Théodore Rousseau, Jean-François Millet, Jean-Baptiste Camille Corot, Albert Charpin ed altri) che, tra il 1830 e il 1870, si ritrovarono a dipingere in questa località nella regione dell’Île-de-France e dalla quale perciò presero il nome.
Dopo averlo citato fra gli interlocutori artistici di Jongkind, incontriamo con due sue opere Louis Eugène Boudin (Honfleur, 12 luglio 1824 - Deauville, 8 agosto 1898). Autore sottovalutato dagli appassionati degli Impressionisti, prima ancora di Monet, Pissaro e Sisley, è proprio lui a sfidare la tradizione pittorica spostando il cavalletto dal chiuso dello studio all’aria aperta dei paesaggi della Normandia ed, in particolare, di Le Havre e dintorni.
 Di questi luoghi, e più precisamente della costa atlantica opposta a Le Havre, a sud della foce della Senna, abbiamo in mostra due vedute di Trouville firmate e datate ’93.
Di questi luoghi, e più precisamente della costa atlantica opposta a Le Havre, a sud della foce della Senna, abbiamo in mostra due vedute di Trouville firmate e datate ’93.
Il porto di Trouville (col nome della cittadina indicato anche sulla tela), visto dal mare, con le barche ormeggiate a riva ed un filo di fumo che è sempre presente (come le bandiere di Francia che sventolano sui pennoni delle imbarcazioni) e sale al cielo da qualche parte.
 Ed Il molo di Trouville inquadrato dalla costa, con le piccole figure delle persone sul molo, i cavalloni delle onde che fanno il loro mestiere e “cavalcano”, le vele triangolari, in studiata progressione decrescente nelle dimensioni fino all’orizzonte per dare profondità al dipinto, l’acqua verde ed il cielo azzurrissimo dietro i cumulonembi.
Ed Il molo di Trouville inquadrato dalla costa, con le piccole figure delle persone sul molo, i cavalloni delle onde che fanno il loro mestiere e “cavalcano”, le vele triangolari, in studiata progressione decrescente nelle dimensioni fino all’orizzonte per dare profondità al dipinto, l’acqua verde ed il cielo azzurrissimo dietro i cumulonembi.
Dettagli ai quali non ha evidentemente fatto caso chi ha montato la mostra (né chi l’ha curata) visto che la posizione delle due opere è risultata invertita rispetto alle rispettive didascalie, e nonostante sia possibile leggerne il titolo in francese sulla cornice!
 In questo stesso luogo, nel 1864, Boudin aveva dipinto Plage aux environs de Trouville: emblematico esempio di “ripetitività” della sua pittura. Ovvero del suo interesse a dipingere sempre gli stessi soggetti dei quali coglie le variazioni in relazione alle diverse ore del giorno, al clima o alle stagioni. Se, infatti, già la Scuola di Barbizon aveva promosso la pittura “en plein air”, nella quale il soggetto principale è lo spazio paesaggistico con le campagne popolate da contadini e animali da pascolo, Boudin non si orienta verso questa forma di espressione realista/romantica ma verso i cangianti effetti della luce su di essi al suo mutare.
In questo stesso luogo, nel 1864, Boudin aveva dipinto Plage aux environs de Trouville: emblematico esempio di “ripetitività” della sua pittura. Ovvero del suo interesse a dipingere sempre gli stessi soggetti dei quali coglie le variazioni in relazione alle diverse ore del giorno, al clima o alle stagioni. Se, infatti, già la Scuola di Barbizon aveva promosso la pittura “en plein air”, nella quale il soggetto principale è lo spazio paesaggistico con le campagne popolate da contadini e animali da pascolo, Boudin non si orienta verso questa forma di espressione realista/romantica ma verso i cangianti effetti della luce su di essi al suo mutare.
 Le meraviglie della natura, le campagne, le spiagge… sulla sua tela prendono dunque vita abbandonando quanto fino a metà Ottocento era regola condivisa e seguita: contorni logici e ben delineati, rassicuranti pennellate applicate con precisione, strato dopo strato, asciugatura dopo asciugatura, per mantenere la brillantezza del colore e la resa di dettagli minuti e ben proporzionati.
Le meraviglie della natura, le campagne, le spiagge… sulla sua tela prendono dunque vita abbandonando quanto fino a metà Ottocento era regola condivisa e seguita: contorni logici e ben delineati, rassicuranti pennellate applicate con precisione, strato dopo strato, asciugatura dopo asciugatura, per mantenere la brillantezza del colore e la resa di dettagli minuti e ben proporzionati.
Il risultato del distacco da questo approccio consiste quindi in un mondo che non è più quello catturato nell’immagine statica del preciso momento raffigurato. Viceversa diventa il mondo dello spazio in movimento percepito intorno all’osservatore, che il pittore traccia con linee scomposte e dinamiche, pennellate accennate e sbavature di colore denso applicato su altri strati di pittura ancora fresca. Di conseguenza si trascura la precisione nella restituzione dei dettagli fisici, sostituiti da lineamenti approssimati: perché sono diventati la luce ed il suo effetto ottico prodotto sulla materia, il vero soggetto delle tele. E per riuscire a renderli occorre dipingerli molto velocemente.
 A questo traguardo Boudin era arrivato dopo un percorso che l’aveva visto partire dall’osservazione semi-ravvicinata della classe abbiente, che troviamo in mostra in un altro dono di Otto Beit: Regate a Argenteuil, del 1866.
A questo traguardo Boudin era arrivato dopo un percorso che l’aveva visto partire dall’osservazione semi-ravvicinata della classe abbiente, che troviamo in mostra in un altro dono di Otto Beit: Regate a Argenteuil, del 1866.
Dal colore delle foglie degli alberi e dall’abbigliamento del pubblico assiepato a seguire le gare di barche a vela dalle rive della Senna di questa celebre località a nord ovest di Parigi, sembra che siamo in una soleggiata giornata primaverile che la ricca borghesia trascorre in appuntamenti mondani ed il pittore ama ritrarre.
 E sempre in presenza dell’acqua. Cosa c’è, infatti, di più adatto dell’acqua per evidenziare le variazioni della luce? Considerazione che, stando a quanto ci risulta, addirittura portò più d’uno degli Impressionisti ad allestire il proprio atelier su una barca. Ne è testimonianza il quadro di Manet del 1874 che ritrae l’amico Monet mentre dipinge sulla sua barca in compagnia della moglie.
E sempre in presenza dell’acqua. Cosa c’è, infatti, di più adatto dell’acqua per evidenziare le variazioni della luce? Considerazione che, stando a quanto ci risulta, addirittura portò più d’uno degli Impressionisti ad allestire il proprio atelier su una barca. Ne è testimonianza il quadro di Manet del 1874 che ritrae l’amico Monet mentre dipinge sulla sua barca in compagnia della moglie.
Tornando a Boudin, negli anni aveva preso le distanze dal soggetto umano, ampliando il suo raggio di osservazione ed abbassando al tempo stesso la linea dell’orizzonte. Col risultato che sembra allontanare il punto di vista e spostare lo sguardo leggermente verso l’alto. Verso quei cieli che, qualche anno dopo la sua morte, gli valsero il titolo di “re dei cieli”. Corona attribuitagli da Monet, che lo considerava il suo maestro: essendo stato proprio Bodin a spingerlo verso lo stile degli impressionisti convincendolo, giovanissimo, a dipingere Le Havre en plein air.
 Sempre grazie a Otto Beit, eccoci quindi arrivati, con un frutteto in fioritura, La primavera, del 1875, a Claude Monet (IX arrondissement di Parigi, 14 novembre 1840 - Giverny, 5 dicembre 1926), considerato uno dei fondatori dell’Impressionismo francese e certamente il più coerente e prolifico esponente del movimento.
Sempre grazie a Otto Beit, eccoci quindi arrivati, con un frutteto in fioritura, La primavera, del 1875, a Claude Monet (IX arrondissement di Parigi, 14 novembre 1840 - Giverny, 5 dicembre 1926), considerato uno dei fondatori dell’Impressionismo francese e certamente il più coerente e prolifico esponente del movimento.
Di esso, come sin qui già visto e si vedrà più avanti, sebbene non abbiamo in mostra i più noti capolavori assoluti, abbiamo comunque i nomi di riferimento.
Il suo anno di avvio viene individuato nel 1863, con Déjeuner sur l’herbe, di Manet, che crea scandalo anche al Salon des Refusés, opposto al Salon Officiel il cui riconoscimento al tempo era il lasciapassare per la carriera di un artista.
 Fino a quel momento, infatti, “andavano” (di moda) tele monumentali, come quelle di David (Il Primo Console supera le Alpi al Gran San Bernardo, del 1801, celebrativo dell'impresa compiuta da Napoleone dopo Annibale e Carlo Magno, come risulta dalle incisioni sulla pietra sotto le zampe del suo cavallo impennato), Gèricault (La zattera della Medusa, 1818-19) e Delacroix (La Libertà guida il popolo, 1830), permeate di impegno politico-civile attento all’attualità e romantiche nel modo di esprimere i sentimenti. Il tutto reso con grande cura per la qualità della stesura pittorica e nella definizione, minuziosamente realistica e quasi fotografica, dei più piccoli dettagli.
Fino a quel momento, infatti, “andavano” (di moda) tele monumentali, come quelle di David (Il Primo Console supera le Alpi al Gran San Bernardo, del 1801, celebrativo dell'impresa compiuta da Napoleone dopo Annibale e Carlo Magno, come risulta dalle incisioni sulla pietra sotto le zampe del suo cavallo impennato), Gèricault (La zattera della Medusa, 1818-19) e Delacroix (La Libertà guida il popolo, 1830), permeate di impegno politico-civile attento all’attualità e romantiche nel modo di esprimere i sentimenti. Il tutto reso con grande cura per la qualità della stesura pittorica e nella definizione, minuziosamente realistica e quasi fotografica, dei più piccoli dettagli.
IL SALON (Officiel)
Periodica esposizione di pittura e scultura, il Salon si svolse al Louvre di Parigi dal XVII al XIX secolo. La sua prima edizione, organizzata dall’Accademia reale e riservata ai suoi membri, risale al 1667. Le successive furono biennali sino al 1675 dopodiché, per il loro elevato costo, ebbero luogo solo nel 1699, nel 1704 e nel 1706, quando durò soltanto un giorno. Negli anni seguenti la sua cadenza si alternò più volte da annuale e biennale e viceversa, fino al 13 novembre 1863, quando divenne definitivamente annuale per decreto imperiale. Invece fino al 1791 venne sempre inaugurato il giorno di san Luigi, onomastico del re.
La sua prima sede fu la galleria del Palais-Royal, da dove si spostò nel cortile dell’hôtel Richelieu. Dopo le due edizioni del 1699 e del 1704, ospitate nella Grande Galerie, dal 1725, occupando talvolta anche la galleria detta dell’Apollo, prese definitivamente posto nel Salon Carré, da qui il nome Salon.
Sin dall’origine l’allestimento venne affidato ad un artista detto le Tapissier o le Décorateur e, nel 1748, venne istituita una commissione incaricata di salvaguardare la tradizione della “grande pittura” ed esercitare un controllo sulla moralità delle opere proposte.
Ma con la Rivoluzione, nel 1788, al regolamento vennero apportate una serie di modifiche radicali: nel 1791 l’esposizione divenne libera ed accessibile a tutti e, dal 1798, venne istituita una giuria di ammissione eletta a suffragio universale. Che però ben presto assunse una veste di conformistica ufficialità.
Sotto l’Impero fu composta da tre artisti e due amatori presieduti dal barone Dominique Vivant Denon. Soppressa nel 1848, ma reintrodotta l’anno seguente, la giuria mostrò un indirizzo sempre più rigido rifiutando molti candidati e qualsiasi opera non conforme ai gusti accademici.
Nel 1863 la scelta di escludere quasi 3.000 quadri suscitò un tale clamore da indurre lo stesso Imperatore Napoleone III ad organizzare una libera esposizione dei dipinti esclusi, poi chiamato Salon des Refusés e che successivamente vide altre tre edizioni nel 1874, 1875 e 1886.
In seguito la sua struttura organizzativa viene riformata permettendo l’ingresso in giuria anche di artisti già premiati con medaglia. In questo modo l’esposizione si apre anche alle nuove tendenze dell’arte impressionista.
Poiché il governo francese aveva smesso di farlo, col compito principale di continuare ad organizzare il Salon, nel 1881 venne fondata la Société des Artistes Français: associazione dei pittori e degli scultori francesi, che riuniva tutti gli artisti francesi ed aveva un pittore come presidente ed uno scultore come suo vice.
Nel dicembre del 1890, l’allora presidente William-Adolphe Bouguereau suggerì di trasformare il Salon in un’esposizione senza premi che potesse promuovere i giovani artisti non ancora conosciuti. La proposta, nonostante la fuoriuscita dall’associazione di importanti artisti dissenzienti, non portò tuttavia alla fine del Salon originale che continua ad essere organizzato ancora oggi con il nome di Salon de Champs-Élysées o, più semplicemente, Salon des artistes français.IL SALON DU CHAMP DE MARS
Nello stesso anno, fra coloro che, stanchi per l’autoritarismo accademico del Salon des artistes français, respinsero l’idea di Bouguereau, venne rapidamente costituita la Société Nationale des Beaux-Arts, con Ernest Meissonier come presidente, coadiuvato da un comitato segnatamente composto da Pierre Puvis de Chavannes, Carolus-Duran, Félix Bracquemond, Jules Dalou e Auguste Rodin.
A dire il vero, con la stessa denominazione, ed inizialmente presieduta dallo scrittore, ma anche pittore, Théophile Gautier, nel 1862 era già stata creata un’analoga organizzazione. Nel suo comitato direttivo, assieme ad Eugène Delacroix ed altri, era già presente Pierre Puvis de Chavannes (Lione, 14 dicembre 1824 - Parigi, 24 ottobre 1898) che avrebbe aderito alla corrente del Simbolismo. Fra gli artisti più noti al pubblico di cui promosse le opere troviamo Gustave Doré ed Édouard Manet. Tuttavia aveva cessato la propria attività nel 1864, proprio dopo la morte di Delacroix e dopo avergli dedicato una grande retrospettiva con 248 suoi quadri e litografie.
La ricostituita società si affretta dunque ad organizzare un nuovo Salon, più aperto alle nuove idee e che rapidamente ottiene il favore di numerosi critici d’arte e di illustri appassionati d’arte.
Ufficialmente chiamato Salon de la Société Nationale des Beaux–Arts, abbreviato in Salon du Champs de Mars, è tuttora esistente.IL SALON DES INDÉPENDANTS
Intanto, il 30 giugno 1884, sempre a Parigi, Paul Signac, con con Odilon Redon e Georges-Pierre Seurat, fonda la Société des artistes indépendants per organizzare un annuale Salon des Indépendants: caratterizzato dall’assenza di una giuria e di qualsiasi premio, nella sua prima edizione ospita le opere di circa 400 artisti rifiutati dal Salon officiel ed anch’esso è arrivato fino ai nostri giorni e continua a riunire le opere di tutti gli artisti che rivendicano indipendenza nella loro espressione artistica.
IL SALON D'AUTOMNE
Infine, nel 1903, per iniziativa del belga Frantz Jourdain insieme a George Desvallières, Hector Guimard, Eugène Carrière, Félix Vallotton ed Édouard Vuillard venne ideata un’altra esposizione d’arte annuale: il Salon d’Automne.
Sin dalle sue origini si propose come manifestazione di rottura nei riguardi delle esposizioni più ufficiali, compreso il Salon des Indépendants.
Nel 1905 lanciò il fenomeno del Fauvisme e fu un momento chiave nel percorso intrapreso dall’arte in Francia con la retrospettiva su Cézanne del 1907.
Nacque come Société du Salon d’Automne, Reconnue d’Utilité Publique e la sua denominazione con riferimento all’autunno metteva in risalto il fatto che questo salone artistico veniva organizzato nella stagione autunnale per non sovrapporre le mostre al Salon e al Salon des Indépendants.
Fra le mostre che ospitò nel primo decennio del Novecento si possono citare quella in memoria di Van Gogh, per la sua attitudine a dipingere in maniera pre - espressionista, le successive dedicate a Gauguin e Cezànne e quella del 1905 con artisti espressionisti francesi come Henri Matisse (che ne fu il principale esponente) e Kees van Dongen, lo scultore Pier-Albert Marquet ed Henri Rousseau (che prenderà il nome d’arte di Rousseau il Doganiere) con l’opera Le lion ayant faim se jette sur l’antilope, definito primitivista in quanto rappresentante di una pittura istintiva con segno e gesti espressionisti.
Seconda data essenziale per l’Impressionismo è il 1874. Alla ricerca di opportunità per esporre le proprie opere, anche autofinanziandosi (considerazione che fa effetto se pensiamo alla loro attuale quotazione economica!), trovano ospitalità nello studio del fotografo Nadar.
NADAR
Gaspard-Félix Tournachon (Parigi, 6 aprile 1820 – 21 marzo 1910), noto soprattutto come pioniere della fotografia, adottò lo pseudonimo di Nadar, con il quale si sarebbe consegnato alla storia, nel 1839, un anno per lui particolarmente significativo in quanto, constatato il proprio fallimento come giornalista, scoprì la propria vena di caricaturista che lo portò, nel 1846, ad iniziare una collaborazione col giornale satirico Le Corsair-Satan.
A partire dal 1854 iniziò poi a dedicarsi alla sua prima opera fotografica significativa: il Panthéon Nadar, un’imponente galleria di foto che includeva le maggiori personalità del tempo, come Charles Baudelaire, Gioacchino Rossini ed Édouard Manet.
Nel 1860 Nadar aveva ormai acquisito notorietà nazionale, non solo per l’impresa titanica del Panthéon, ma anche grazie ad altre sue spettacolari iniziative. Fra queste, nel 1858, percorse su una mongolfiera i cieli di Parigi sperimentando le potenzialità della fotografia aerea. Appassionato di aerostatica, costruì un enorme pallone ad aria calda del volume di 6.000 m³: Le Géant (Il gigante), che ispirò all’amico Jules Verne il romanzo Cinque settimane in pallone.
Il suo primo atelier, al n° 35 di Boulevard des Capucines, lasciato nel 1872 per il meno prestigioso ma più economico n° 51 di Rue d’Anjou St. Honoré, è celeberrimo perché, gestito dalla moglie Ernestine Costance Lefèvre (sposata nel 1854) e dal figlio Paul, veniva utilizzato da Nadar per manifestazioni culturali e artistiche di rilievo. La più importante delle quali risulterà essere, come si è sopra anticipato, la prima mostra collettiva dei pittori Impressionisti organizzata il 15 aprile 1874. Come attestato di stima verso il loro modo di dipingere così innovativo, Nadar lo mise gratuitamente a disposizione del gruppo di giovani artisti che includeva nomi che sarebbero passati alla storia come Claude Monet, Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Paul Cézanne ed altri.
Nell’occasione, queste personalità, che allora erano semplicemente i membri della «società anonima di artisti, pittori, scultori, incisori» avevano esposto i dipinti che ritenevano più rappresentativi del loro modo di fare pittura. Monet partecipò con un’opera di piccole dimensioni, una delle sei vedute del porto di Le Havre che volle ritrarre, nel 1872, seguendo gli insegnamenti ricevuti da Boudin ovvero, come dichiarò egli stesso, da realizzarsi «con l’alba, col giorno, col crepuscolo, e di notte, oltre che da vari punti di vista: alcune, infatti, le eseguirò dal livello dell’acqua ed altre dalla stanza di un albergo che sovrasta le infrastrutture portuali».
 Dipinta, come tutte le altre, con una tecnica che riassume quelle saranno le maggiori peculiarità stilistiche dell’Impressionismo, proprio in occasione della mostra all’opera venne assegnato il titolo con cui oggi è universalmente nota, Impression: soleil levant (Impressione di un sole che sorge) come ci testimonia lo stesso Monet: «Il paesaggio non è altro che un’impressione, ed istantanea, e per questo ci si diede quell’etichetta a causa mia. Avevo mandato una mia cosa fatta a Le Havre, dalla mia finestra, col sole in mezzo alla nebbia e qualche albero di nave che si innalzava sullo sfondo… Mi avevano chiesto un titolo per il catalogo e non poteva certo essere preso per una veduta di Le Havre, quindi ho detto: 'Metta Impressione'».
Dipinta, come tutte le altre, con una tecnica che riassume quelle saranno le maggiori peculiarità stilistiche dell’Impressionismo, proprio in occasione della mostra all’opera venne assegnato il titolo con cui oggi è universalmente nota, Impression: soleil levant (Impressione di un sole che sorge) come ci testimonia lo stesso Monet: «Il paesaggio non è altro che un’impressione, ed istantanea, e per questo ci si diede quell’etichetta a causa mia. Avevo mandato una mia cosa fatta a Le Havre, dalla mia finestra, col sole in mezzo alla nebbia e qualche albero di nave che si innalzava sullo sfondo… Mi avevano chiesto un titolo per il catalogo e non poteva certo essere preso per una veduta di Le Havre, quindi ho detto: 'Metta Impressione'».
Curiosamente, durante la Seconda Guerra Mondiale, la tela fu temporaneamente custodita nel castello di Chambord ed identificata come Coucher de soleil, Calar del sole!
Ad ogni modo la stampa ne riprese il titolo, in senso dispregiativo, definendo la mostra Exposition Impressioniste, volendo sottolineare l’incompletezza delle opere, secondo i detrattori poco più che abbozzi dai colori sfarfallanti, rispetto ai canoni della pittura accademica vigente.
Ma come si vedrà per i Fauves, anche in questo caso, nonostante la loro prima esposizione si risolverà in un fallimento, per i suoi 3-4.000 visitatori rispetto ai 400.000 del Salon ufficiale, gli Impressionisti adottano con favore la denominazione sotto la quale in breve diventeranno uno dei più celebrati movimenti della storia dell’arte.
Infatti la pittura che promuovono, in opposizione a quella accademica ed ufficiale, è la pittura del momento nella quale si riconosce la nuova società dinamica che sta cambiando. Una società che offre loro anche nuovi strumenti che ne facilitano la tecnica: fatta di piccole, frenetiche e vibranti pennellate.
Per riprendere le luci che cambiano e dipingere un quadro in poco più di una decina di minuti, saltando il lavoro di bozza e preparazione dei colori, si rivelò determinante la disponibilità dei colori a olio in tubetti di stagno. Invenzione solo all’apparenza banale, il tubetto di metallo morbido, commercializzato a partire dal 1841 dal ritrattista americano John Rand, sostituì i pacchetti di vescica di maiale, in cui fino ad allora venivano conservati i colori ad olio, evitando che seccassero troppo velocemente nella loro confezione.
Fu questa un’innovazione rivelatasi determinante per gli Impressionisti che amavano dipingere all’aperto. Lo ammisero essi stessi. Renoir osservò che “senza i tubetti di colore non ci sarebbero stati Cézanne, Monet, Sisley o Pissarro, niente di ciò che i giornalisti avrebbero chiamato Impressionismo… e probabilmente neppure Renoir”.
D’aiuto furono anche i nuovi pennelli, dotati in punta di fascette in metallo per tenere assieme più strette le setole e dar loro anche diverse forme, rettangolari o cilindriche, che permettevano di dipingere con più precisione le virgolette veloci dei colpi di pennello caratteristici della pittura Impressionista.
Da non dimenticare, infine, la comodità offerta alla pittura all’aperto da un altro nuovo ed utile supporto quale fu il cavalletto portatile.
Che sarà stato senz’altro apprezzato anche da Alfred Sisley (Parigi, 30 ottobre 1839 - Moret-sur-Loin, 29 gennaio 1899) quando si sarà recato a dipingere Sulla riva del fiume a Veneux, del 1881.
Nonostante la sua nazionalità inglese, il fatto che nacque, visse e lavorò sempre in Francia, porta spesso a considerare Sisley un artista francese. Appellativo legittimato anche dal fatto che aderì al movimento degli Impressionisti di cui fu uno degli esponenti più di rilievo partecipando alle loro esposizioni fino alla la settima mostra impressionista del 1882, che vide per l’ultima volta la ricostituzione dell’iniziale gruppo fondatore. Questo riaccostamento fu però l’ultimo: nella mostra seguente, l’ottava e conclusiva, mancarono le opere Monet, Renoir, Cézanne e dello stesso Sisley.
 Ennesimo dono alla JAG del munifico Otto Beit, questa sua opera in mostra è un paesaggio fluviale dipinto a Veneux-Les Sablons, località a ridosso del limite orientale della Foresta di Fontainebleau.
Ennesimo dono alla JAG del munifico Otto Beit, questa sua opera in mostra è un paesaggio fluviale dipinto a Veneux-Les Sablons, località a ridosso del limite orientale della Foresta di Fontainebleau.
Con una personale interpretazione del toponimo, lo ipotizziamo dovuto al fatto che in sua corrispondenza la Senna rallenti la corrente depositando i materiali portati in sospensione e formando nell’alveo, sul lato interno dell’ansa che vi descrive, gli isolotti che Sisley pone a confinare l’imponente massa d’acqua che occupa gran parte della metà inferiore del dipinto. Isolotti consolidati al punto che, davanti alle montagne viola lontane all’orizzonte, vi sorge una casa colonica e su di essi crescono alti alberi.
E proprio gli alberi, con in fiume e il cielo sul quale si stagliano i loro rami spogli, sembrano essere i protagonisti del dipinto. In particolare i tre in primo piano, due più grandi ed il terzo dal tronco più esile e sinuoso radicato fuori scena al di sotto del margine inferiore del dipinto.
Alberi le cui lunghissime ombre, disegnate a terra dalla luce intensa del sole, portano, chissà con quale significato (semmai ve n'è uno), ad individuare tre contadini, fra i quali una donna, sotto il boschetto sulla sinistra ed in riva al fiume. Ombre che, per quanto crediamo di aver individuato dell’effettivo punto di vista del pittore, con la loro lunghezza ci fanno pensare ad un sole basso sull’orizzonte e dalla luce limpida ed intensa come può essere all’alba o al tramonto. Propendendo per la prima visto che la direzione dalla quale arriva sembra essere l’oriente.
La, seppure seminascosta, presenza umana appena vista in Sisley testimonia che, dopo la prevalenza della natura, come soggetto preferito degli inizi, gli Impressionisti cominciano a dipingere anche persone, ritratti ed architetture. In mostra lo vediamo particolarmente con John Singer Sargent (Firenze, 12 gennaio 1856 - Londra, 14 aprile 1925), pittore statunitense, considerato fra i più significativi ritrattisti dell’Ottocento.
Suo padre, Fitzwilliam (nato nel 1820 a Gloucester, nel Massachusetts), era un chirurgo presso il Wills Eye Hospital di Philadelphia ma, dopo la morte prematura della primogenita (di due anni), la madre, Mary (nata Singer), subì un violento tracollo fisico che indusse la coppia a compiere frequenti viaggi all’estero per farle ritrovare la salute. Facendo base a Parigi, visitarono Francia, Germania, Svizzera ed Italia.
John venne alla luce a Firenze, dove la famiglia si era momentaneamente fermata a causa dello scoppio di un’epidemia di colera, seguito un anno dopo da Mary ed altri quattro bambini, solo due dei quali sopravvissero.
Fin da piccolo John Sargent si dimostrò di carattere vivace: amava stare all’aperto ed era un «accorto osservatore della natura», come rilevò il padre. E poiché la madre riteneva che viaggiare in Europa, visitando ininterrottamente musei, gallerie d’arte e chiese, fosse il modo migliore per educarlo, la sua giovinezza non trascorse al chiuso delle aule scolastiche ma fu itinerante, seguendo gli spostamenti della famiglia tra le varie città europee. Da adulto egli stesso ironizzò su questa sua formazione definendosi «un americano nato in Italia, educato in Francia, che guarda come un tedesco, parla come un inglese e dipinge come uno spagnolo».
In relazione a questa mostra, nell’ambito della quale ci viene proposto, non si può mancare di rilevare che a Capri incontrò la pittura di Antonio Mancini (il ritrattista di Lady Phillips conosciuto in apertura), restandone affascinato ed instaurando con lui un rapporto di amicizia che favorì il reciproco scambio artistico.
 Senza qui analizzarne l’intera opera, occorre anche ricordare che, nella sua tarda maturità, i soggetti più ricorrenti quali ruscelli, valli, parchi, statue e fontane, sono tutti riproposti con grande fedeltà e cura dei dettagli denotando un ritorno «[al]l’energia e [al]la sincerità dei suoi primi anni» (Delphine Fitz Darby).
Senza qui analizzarne l’intera opera, occorre anche ricordare che, nella sua tarda maturità, i soggetti più ricorrenti quali ruscelli, valli, parchi, statue e fontane, sono tutti riproposti con grande fedeltà e cura dei dettagli denotando un ritorno «[al]l’energia e [al]la sincerità dei suoi primi anni» (Delphine Fitz Darby).
Ne abbiamo dimostrazione in Il ghiacciaio della Brenva, del 1909 c.a., dove gli speroni rocciosi che contengono questa la massa glaciale valdostana sul Monte Bianco sono resi a “botte” di spatolate.  Ciononostante le malghe in legno, e soprattutto i loro tetti di assi, stabilizzate con tronchi trasversali e pietre, sono di un realismo tridimensionale che sorprende. Forse Sargent è consapevole di questo effetto che farà su chi osserverà il suo dipinto, e perciò pone in viso al montanaro in primo piano, intento a caricare un sacco di fieno assieme ad un ragazzino, un sorriso compiaciuto tanto evidente quanto impercettibile: il suo proprio sorriso!
Ciononostante le malghe in legno, e soprattutto i loro tetti di assi, stabilizzate con tronchi trasversali e pietre, sono di un realismo tridimensionale che sorprende. Forse Sargent è consapevole di questo effetto che farà su chi osserverà il suo dipinto, e perciò pone in viso al montanaro in primo piano, intento a caricare un sacco di fieno assieme ad un ragazzino, un sorriso compiaciuto tanto evidente quanto impercettibile: il suo proprio sorriso!
Personalmente però preferiamo l’opera che gli è accanto. Una stupefacente veduta architettonica, del 1900 -1909, di un particolare della facciata della monumentale chiesa di Santa Maria della Salute che, dalla Punta della Dogana, vigila sullo sbocco in Laguna del Canal Grande di Venezia.
 In questo caso la luce esterna, sebbene arrivi esattamente dalla parte opposta rispetto a quella del dipinto, rinforza la credibilità dei colpi di luce del sole basso nel tardo pomeriggio sui marmi dell’edificio sacro.
In questo caso la luce esterna, sebbene arrivi esattamente dalla parte opposta rispetto a quella del dipinto, rinforza la credibilità dei colpi di luce del sole basso nel tardo pomeriggio sui marmi dell’edificio sacro.
Specialmente se guardato dalla giusta distanza (cioè non troppo da vicino), questo lavoro diventa bellissimo ed inaspettatamente realistico grazie alla capacità dell’artista di non perdersi più nella didascalicità del disegno ma di dimostrare la sua abilità nel creare la forma con i colori nei punti sui quali batte la luce.
E siccome gli Impressionisti rivendicavano la convinzione dell’inesistenza in natura del bianco e del nero, allora le ombre possono anche essere blu, come avviene qui per quelle disegnate dagli elementi architettonici, o come quelle degli alberi piantati lungo le nuove urbanizzazioni di fine Ottocento alla Periferia di Parigi che abbiamo visto in La strada di Gennevilliers, del 1883, di Paul Signac, esposta alla già citata mostra Manet e la Parigi moderna.
Contraddicendo il favore di fama che gli è universalmente riconosciuto, personalmente non ci sentiamo in grande sintonia con le Due ballerine, del 1898, che il pittore e scultore Hilaire German Edgar Degas (Parigi, 19 luglio 1834 - 27 settembre 1917) offre al nostro sguardo tagliando l’inquadratura con la quale le dipinge: la più piccola, sulla sinistra, addirittura esce dal campo visivo.
Più interessante è considerare la relazione dell’autore con questo tema, che Degas amava rappresentare e che a tutt’oggi è quello che gode di maggiore popolarità di tutta la sua produzione pittorica.
 Ma anche alla sua epoca i dipinti raffiguranti giovani danzatrici erano molto di moda e, di conseguenza, si vendevano meglio di altri soggetti perché i collezionisti «volevano soltanto ballerine», come riferisce il mercante d’arte Durand-Ruel. Di ciò Degas era pienamente consapevole e per questo, chiamandole con affettuoso sarcasmo «i miei articoli», frequentò assiduamente il genere. Anche per sopravvivere al tracollo finanziario della sua famiglia alla morte del padre, nel 1874.
Ma anche alla sua epoca i dipinti raffiguranti giovani danzatrici erano molto di moda e, di conseguenza, si vendevano meglio di altri soggetti perché i collezionisti «volevano soltanto ballerine», come riferisce il mercante d’arte Durand-Ruel. Di ciò Degas era pienamente consapevole e per questo, chiamandole con affettuoso sarcasmo «i miei articoli», frequentò assiduamente il genere. Anche per sopravvivere al tracollo finanziario della sua famiglia alla morte del padre, nel 1874.
Così come anche per i cavalli, Degas è molto interessato alle pose assunte dalle giovani danzatrici quando sono in movimento. Perciò, nelle sue prime opere che ne contemplano la presenza, le indaga in maniera anche eccessivamente canonica, scegliendo di raffigurarle nei momenti più spettacolari del balletto. Ben presto, tuttavia, abbandona questa linea e comincia ad interpretarne i corpi più “scientificamente” e perciò, come nel dipinto in mostra, non le dipinge in scena, ma sempre o prima o dopo lo spettacolo.
Vivamente interessato alle attitudini dei corpi femminili, non intendeva però edulcorarli o idealizzarli, come insegnava la visione tradizionale dell’arte consolidata nei secoli. Al contrario, decide di coglierli con realismo, nascondendone la grazia ed, anzi, facendone spesso risaltare goffaggine e limiti fisici. Ecco perché non dipinge le ballerine mentre si muovono con leggiadria e grazia a passo di danza, ma quando i loro arti si «assestano», componendo posizioni disarmoniche e persino grottesche.
Chi osservatori i quadri di Degas può dunque ben capire perché, riferendosi al balletto, Hippolyte Taine parlasse di un «mercato di fanciulle». Fanciulle spesso di bassa estrazione sociale che si logorano, si avviliscono, si affaticano e si esauriscono in una difficile arte nella prospettiva di un’ascesa sociale che non sarà per tutte. Degas, dunque, non soltanto desacralizza materialisticamente il corpo femminile, ma descrive impietosamente anche il vero mondo del balletto d’opera.In questo senso analizzato in modo esemplare da Paul Valéry:
«Non donne, ma esseri di una sostanza incomparabile, traslucida e sensibile, carni di vetro follemente irritabili, cupole di seta ondeggiante, corone trasparenti, lunghi nastri vivi percorsi tutti da rapide onde, frange e increspature che esse piegano e spiegano; e intanto si voltano, si deformano, fuggono via, fluide quanto il fluido massiccio che le comprime, le sposa, le sostiene da ogni parte, fa loro posto alla minima inflessione e le sostituisce nella forma. Là, nella pienezza irriducibile dell’acqua che sembra non opporre alcuna resistenza, queste creature dispongono di una mobilità ideale, vi distendono e raccolgono la loro raggiante simmetria. Niente suolo, niente solidi per queste ballerine assolute: niente palcoscenico, ma un centro dove appoggiarsi in tutti i punti che cedono dove si voglia. Niente solidi, nei loro corpi di cristallo elastico, niente ossa, niente articolazioni, giunture invariabili, segmenti che si possano contare [...] Mai nessuna ballerina umana, donna ardente, ebbra di movimento, del veleno delle sue forze eccedenti, della presenza infuocata di sguardi carichi di desiderio, mai ha saputo esprimere l’offerta imperiosa del sesso, l’appello mimico del bisogno di prostituzione, come questa grande medusa che, con gli scatti ondulatori del suo flutto di gonne e festoni, che alza e rialza con insistenza strana e impudica, si trasforma in sogni di Eros».
 Questa volta dono nel 1919 di Mr. Max Michaelis, che cede alla JAG anche la sua collezione di Fiamminghi ed Olandesi del XVII secolo, è Un mazzo di fiori, del 1902, di Ignace Henri Jean Théodore Fantin-Latour (Grenoble, 14 gennaio 1836 – Buré, 25 agosto 1904). Contemporaneo ed ammiratore di Édouard Manet, si distinse dagli Impressionisti rifiutandone il modo di fare arte e sviluppando uno stile autonomo: liricamente realista ed intimista, capace di mettere in risalto il carattere costruttivo della composizione.
Questa volta dono nel 1919 di Mr. Max Michaelis, che cede alla JAG anche la sua collezione di Fiamminghi ed Olandesi del XVII secolo, è Un mazzo di fiori, del 1902, di Ignace Henri Jean Théodore Fantin-Latour (Grenoble, 14 gennaio 1836 – Buré, 25 agosto 1904). Contemporaneo ed ammiratore di Édouard Manet, si distinse dagli Impressionisti rifiutandone il modo di fare arte e sviluppando uno stile autonomo: liricamente realista ed intimista, capace di mettere in risalto il carattere costruttivo della composizione.
Anche per questa ragione i suoi soggetti preferiti sono i ritratti di molti artisti del tempo, dei quali era amico, e le nature morte, in particolare fiori, come quella in mostra. Nella quale risulta evidente anche la sua attività di litografo: se infatti da vicino si vede che la tecnica usata non è così lontana come sembrerebbe da quella dei più “moderni” artisti del suo tempo, allontanandosi dal dipinto, il suo mazzo di fiori sembra essere una riproduzione quasi fotografica.
 Con Jean Baptiste Armand Guillaumin (Parigi, 16 febbraio 1841 - Orly, 26 giugno 1927) si chiude, infine, la sezione degli Impressionisti in mostra. Come è giusto, a Parigi, con La Senna al ponte di Sully, del 1869, in cui sembra di intravedere sullo sfondo la cupola del Sacre-Coeur a Montmartre. È proprio dopo aver visto alcune sue prove in riva alla Senna, che lo stesso Cézanne tentò alcuni dei suoi lavori più innovativi. Di Cézanne, come di Camille Pissarro, Guillaimin era infatti diventato amico ed aveva profondamente influenzato l’arte di entrambi dopo averli conosciuti all’Académie Suisse, dove si era iscritto nel 1861 grazie ad una vincita alla lotteria che gli permise di lasciare il lavoro come commesso in una merceria al quale era stato costretto dalle sue umili origini.
Con Jean Baptiste Armand Guillaumin (Parigi, 16 febbraio 1841 - Orly, 26 giugno 1927) si chiude, infine, la sezione degli Impressionisti in mostra. Come è giusto, a Parigi, con La Senna al ponte di Sully, del 1869, in cui sembra di intravedere sullo sfondo la cupola del Sacre-Coeur a Montmartre. È proprio dopo aver visto alcune sue prove in riva alla Senna, che lo stesso Cézanne tentò alcuni dei suoi lavori più innovativi. Di Cézanne, come di Camille Pissarro, Guillaimin era infatti diventato amico ed aveva profondamente influenzato l’arte di entrambi dopo averli conosciuti all’Académie Suisse, dove si era iscritto nel 1861 grazie ad una vincita alla lotteria che gli permise di lasciare il lavoro come commesso in una merceria al quale era stato costretto dalle sue umili origini.
Nel 1863 espose al Salon des Refusés e divenne amico di Vincent van Gogh, il cui fratello Theo si occupò spesso della vendita di alcuni suoi quadri. Apprezzato per l’intensità dei suoi colori, fu ricercato da molti musei, anche all’estero: le sue opere più note sono le vedute di Parigi, della zona di Creuse e della regione presso Les Adrets-de-l'Estérel, vicino alle coste della Provenza.
IV - IL POST IMPRESSIONISMO
Guillemin è inoltre l’anello di congiunzione che, superato il vallo del lungo corridoio che attraversa tutto il piano della Villa Reale, ci porta alla stagione del post Impressionismo. La incontriamo con gli studi di ottica applicata scientificamente alla pittura da parte di Paul Signac (Parigi, 11 novembre 1863 - 15 agosto 1935).
Nel suo percorso di avvicinamento alla pittura, sono infatti le opere degli Impressionisti, ed in particolare proprio quelle di Guillaumin, che Signac studia frequentando esposizioni e gallerie ed alla scuola del libero atelier di Émile Bin, un pittore di Montmartre.
La folgorazione che gli fece scoprire la vocazione di pittore fu una mostra di Claude Monet vista nel 1880, anno in cui interrompe gli studi di architettura appena prima di ottenere la maturità e aderisce ad un cenacolo di giovani letterati che manifestano il loro anticonformismo in primo luogo nella denominazione che si attribuiscono: “Le aringhe affumicate epilettiche baudelairiane e anti-filistee”. Confessiamo che ci incuriosisce molto l’attività che intendevano svolgere ma al momento non ne abbiamo trovata alcuna informazione.
Risulta invece l’esistenza di una lettera che Signac indirizzò a Monet con richiesta di consigli per il suo percorso artistico.
I suoi primi dipinti sono vedute di Asnières-sur-Seine, località a sud di Argenteuil ed all’interno del primo grande meandro che la Senna descrive appena a nord di Parigi. Lì la sua famiglia risiede e possiede una barca. Dettaglio importante da riferire perché, a quella per la pittura, Signac accosta la passione per la navigazione. Ad introdurlo a questa pratica, che lo porterà a possedere quasi tre decine di imbarcazioni, fu il pittore Gustave Caillebotte.
Della sua attività nella Societé des artistes indépendants e sul relativo primo Salon del 1884 si è già detto. Qui ci limitiamo perciò a ricordare che nell’occasione espone anche sue opere e, soprattutto, incontra Georges Seurat (Parigi, 2 dicembre 1859 - 29 marzo 1891), di quattro anni maggiore di lui, col quale fa amicizia e dal quale si lascia guidare nella sperimentazione della sua innovativa tecnica pittorica, il Puntinismo (o Pointillisme, come lo definì il critico d’arte francese Félix Fénéon (Torino, 22 giugno 1861 - Châtenay-Malabry, Francia 29 febbraio 1944), che presuppone la giustapposizione di piccoli punti di colore puro.
Si tratta di un’evoluzione della tecnica degli Impressionisti ispirata agli studi scientifici sulla percezione dei colori del chimico Michel Eugène Chevreul (Angers, 31 agosto 1786 - Parigi, 9 aprile 1889): contempla infatti che non vengano più mescolati sulla tavolozza, ma stesi sulla tela distinti in modo che sia la retina ad unire i colori puri direttamente nell’occhio di chi li guarda.
Nella primavera del 1886 vengono esposte a New York opere di Signac e Seurat ed è dello stesso anno la prima serie di tele “divise” dipinte nei dintorni di Les Andelys.
Oltre che con Seurat, Signac lavora anche con Camille Pissarro, convertito al metodo divisionista, ed i tre costituiscono il gruppo dei cosiddetti “impressionisti scientifici”.
 Nel 1892 lascia la Bretagna per Saint-Tropez, allora piccolo porto di pescatori sul Mediterraneo che è il primo artista a scoprire. Vi trascorre alcuni mesi con la moglie e la madre e questo periodo è importante per lui perché segna una svolta nella sua opera: infatti scopre la tecnica dell’acquerello e, dal 1894, rinuncia alla pittura en plein air.
Nel 1892 lascia la Bretagna per Saint-Tropez, allora piccolo porto di pescatori sul Mediterraneo che è il primo artista a scoprire. Vi trascorre alcuni mesi con la moglie e la madre e questo periodo è importante per lui perché segna una svolta nella sua opera: infatti scopre la tecnica dell’acquerello e, dal 1894, rinuncia alla pittura en plein air.
La sua pittura, fatta di tocchi separati e molto colorati, e fin dalle origini influenzata da quella di Monet, diventa ancora più colorata mentre le pennellate si allargano sempre di più. Di tutto ciò in mostra abbiamo appunto due esempi emblematici.
Un bellissimo acquerello su carta (sopra) del 1922, Barche a Locmalo (in Bretagna), nel quale si riconoscono l’abbozzo del disegno a matita, forse schizzato dal vero, sul quale si notano gli appunti con l’indicazione dei colori da usare nelle campiture per completarlo in studio. Colori indicati con le sigle delle iniziali - R. (rouge), Ve (vert), J (jaune), B (blanc) - o per esteso: Crème, per il passepartout sul quale scrive anche luogo e data.
 Invece in La Rochelle (località affacciata sull’Atlantico nel Golfo di Biscaglia, a sud di Nantes,), del 1912, il suo Pointillisme geometrico ormai non è più fatto di puntini ma è quasi diventato una sorta di mosaico realizzato con colpettini di pennello da ½ cm, applicati in verticale per le architetture e le vele, o in orizzontale per il cielo e il mare. Con un effetto che, visto da lontano, fa assumere all’opera un rilievo quasi tridimensionale.
Invece in La Rochelle (località affacciata sull’Atlantico nel Golfo di Biscaglia, a sud di Nantes,), del 1912, il suo Pointillisme geometrico ormai non è più fatto di puntini ma è quasi diventato una sorta di mosaico realizzato con colpettini di pennello da ½ cm, applicati in verticale per le architetture e le vele, o in orizzontale per il cielo e il mare. Con un effetto che, visto da lontano, fa assumere all’opera un rilievo quasi tridimensionale.
Come aiuto al visitatore avremmo gradito trovare indicato sul pavimento, alla giusta distanza dall’opera, il punto dal quale guardarla per vederne e goderne al meglio l’effetto ottico.
A nostro avviso sarebbe stato un ausilio più interessante rispetto alla “realtà aumentata” di occhialini e cuffie tecnologiche. Dopo un po’, l’abbiamo verificato direttamente, stancano il visitatore che, infatti, se li toglie e continua la visita “al naturale”. Come è giusto che sia davanti a lavori che, anche nell’era dei dispositivi mobili che possono caricare sui loro schermi infinite immagini, hanno l’inarrivabile pregio di essere opere con una loro materica consistenza.
 Condividono il pannello della sala successiva due monumenti della storia dell’arte che, tuttavia, presentati in questo modo, con un’opera isolata per ciascuno, danno un po’ l’idea di voler essere un pretesto per poter affermare nella comunicazione di avere in mostra anche loro.
Condividono il pannello della sala successiva due monumenti della storia dell’arte che, tuttavia, presentati in questo modo, con un’opera isolata per ciascuno, danno un po’ l’idea di voler essere un pretesto per poter affermare nella comunicazione di avere in mostra anche loro.
Di Vincent Van Gogh (Zundert, Paesi Bassi, 30 marzo 1853 - Auvers-sur-Oise, Francia, 29 luglio 1890) troviamo un Ritratto di un uomo anziano, a carboncino. Rappresentativo della produzione meno conosciuta del pittore di cui si è scritto ampiamente in Van Gogh: genio naufragato in un campo di grano ed al quale perciò rimandiamo gli interessati (leggi di più >>>).
Lo precede, nel percorso come nella cronologia, Paul Cézanne (Aix-en-Provence, 19 gennaio 1839 - 22 ottobre 1906) con I bagnanti, litografia a colori del 1898: figure nude nel paesaggio, un suo classico, qui però privi dei colori che sono l’aspetto peculiare della pittura dell’artista e tracciati a colori smorti su bianco nei loro profili essenziali.
 Sullo sfondo, l’immancabile sagoma della Montagne Sainte Victoire, massiccio calcareo nella valle nei pressi di Aix-en-Provence, dove l’artista visse e lavorò a lungo, ed onnipresente nei suoi dipinti ci suggerisce un’improvvisa “illuminazione”.
Sullo sfondo, l’immancabile sagoma della Montagne Sainte Victoire, massiccio calcareo nella valle nei pressi di Aix-en-Provence, dove l’artista visse e lavorò a lungo, ed onnipresente nei suoi dipinti ci suggerisce un’improvvisa “illuminazione”.
Non sappiamo quanto possa essere plausibile, e tuttavia ci prendiamo il rischio di azzardarla sottoponendola al giudizio (ed alla benevolenza) dei lettori: può essere che Cezanne abbia mutuato l’idea dalle innumerevoli vedute del monte Fuji di Hokusai? (per gli interessati: Ukiyo-e, immagini del mondo fluttuante leggi di più >>> )
Non possiamo certo vantare una completa ed approfondita conoscenza di altri vedutisti, però fra quelli che conosciamo non ne abbiamo in mente altri che, come Cézanne, siano altrettanto “ossessivi” nel riproporre una specifica montagna. Per questo abbiamo pensato al monte Fuji.
 D’altro canto, nella storia della pittura occidentale ci sono innumerevoli vedutisti che hanno dipinto panorami con montagne, o una particolare montagna, sullo sfondo; per cui non è detto che Cezanne si sia rifatto a Hokusai. Però, seppure nella nostra ignoranza, non ci sentiremmo nemmeno di escludere la possibilità. Visto il periodo (inizio Novecento) e la sensibilità corrente dell’epoca, potrebbe davvero esserci una connessione.
D’altro canto, nella storia della pittura occidentale ci sono innumerevoli vedutisti che hanno dipinto panorami con montagne, o una particolare montagna, sullo sfondo; per cui non è detto che Cezanne si sia rifatto a Hokusai. Però, seppure nella nostra ignoranza, non ci sentiremmo nemmeno di escludere la possibilità. Visto il periodo (inizio Novecento) e la sensibilità corrente dell’epoca, potrebbe davvero esserci una connessione.
Per esserne certi occorrerebbe studiare gli scritti che Cezanne ci ha lasciato per vedere se in essi vi sia qualche nota che supporti tale interpretazione. Poiché una verifica di questo genere è troppo onerosa per L’Eclettico, contiamo sul possibile supporto di qualche lettore competente sull’argomento!
Per contestualizzarlo nel percorso della mostra, in relazione agli artisti che l’hanno preceduto ed a quelli che vedremo, innanzitutto ricordiamo che in vita, al pari di Van Gogh, Cézanne vendette una sola tela, solo qualche anno prima della morte, due anni prima della quale poté gioire per il successo della sua esposizione al Salon d’Automne del 1904.
Sinteticamente lo si può definire lontano dagli Impressionisti e precursore delle avanguardie del Novecento. Come si è visto venne, infatti, a contatto con gli Impressionisti della prima ora (come Pissarro, Degas, Renoir, Monet…). Così come loro si vedeva, infatti, rifiutate le opere dalla giuria del Salon e per questo partecipò alla loro prima mostra da Nadar dove espose La casa dell’impiccato a Auvers.
 La sua adesione al movimento mantenne però sempre un certo distacco perché, fin dai suoi esordi, la sua pittura seguiva un diverso percorso che la differenziava nettamente da quella di un Monet o un Renoir.
La sua adesione al movimento mantenne però sempre un certo distacco perché, fin dai suoi esordi, la sua pittura seguiva un diverso percorso che la differenziava nettamente da quella di un Monet o un Renoir.
Mentre questi ultimi erano interessati solo ai fenomeni percettivi della luce e del colore, Cezanne cerca di sintetizzare nella sua pittura anche i fenomeni della interpretazione razionale che portano a riconoscere le forme e lo spazio. Per far ciò egli tuttavia non ricorse agli strumenti tradizionali del disegno, del chiaroscuro e della prospettiva. La sua grande ambizione lo portava dove nessun pittore era mai arrivato: risolvere tutto solo con il colore, nel quale voleva sintetizzare la visione ottica e la coscienza delle cose.
In proposito, infatti, dichiarò: «nella pittura ci sono due cose: l’occhio e il cervello, ed entrambe devono aiutarsi tra loro».
Dopo la sua morte, questa sua ricerca venne ripresa soprattutto dai cubisti, che in Cézanne videro il precursore dal quale mosse la più grande rivoluzione artistica del ventesimo secolo: la pittura cubista di Picasso. Con il cubismo si perde completamente il primo termine della sintesi di Cezanne (visione-coscienza), per ricercare solo quella rappresentazione che ha la coscienza delle cose. Perdendosi il primo termine, il cubismo romperà definitivamente con il naturalismo e con la rappresentazione che imita la realtà per introdurre sempre più l’arte nei territori dell’astrazione e del non figurativo.
In Cezanne tutto ciò è però ancora assente. Sebbene, come gli Impressionisti, sia del tutto indifferente ai soggetti, che utilizza solo per i suoi esperimenti sul colore, egli non perde mai di vista la realtà e il suo aspetto visivo, nonostante la riduca a poche tipologie: i paesaggi, le nature morte, i ritratti a figura intera.
Sul retro del pannello ci aspetta un autore a noi sconosciuto Aristide Joseph-Bonaventure Maillol (Banyuls-sur-Mer, 8 dicembre 1861 - 27 settembre 1944). Un suo pastello su carta, Testa di donna di profilo, è molto piacevole a vedersi e vicino ai Nabis per bidimensionalità e purezza dei colori, mentre le due litografie del 1944 che lo affiancano sono rappresentative del suo tema preferito, in quanto visto come ideale di bellezza plastica: Nudo di donna di fronte e Nudo di donna di spalle.
Queste sue donne sono sode, massicce, robuste, di forma classica, suggestione dovuta anche al suo viaggio in Grecia del 1908, e rispecchiano la sua attività artistica esercitata in prevalenza dopo i quarant’anni: quella di scultore dallo stile che, per il formalismo e la staticità delle sue figure, si può definire contrapposto a quello di Rodin.
Di fronte, fuori della finestra sul fronte parco della Villa Reale, il quadro della realtà di un caldissimo pomeriggio di luglio ci mostra persone distese sul prato come fossero in spiaggia, fra una gingko biloba e una sequoia. E sorge la domanda se la vita sia meglio viverla, guardandola dal vero, o guardarla dipinta da chi l’ha vissuta. Risposta non facile ma, almeno per questa occasione, la natura che si vede dalla finestra sembra più “piatta” di quella dipinta, che acquista spessore e colori grazie agli occhi, al cuore e alle mani di chi, con la sua arte, l’ha tradotta per renderla disponibile anche a chi non possiede il dono di un analogo talento.
È questo senz’altro il caso di Henri Eugène Augustin Le Sidaner (Port Louis, Mauritius, 7 agosto 1862 - Parigi, 16 luglio 1939) che troviamo, appena svoltato il corridoio, con il suo dipinto scelto come immagine-manifesto della mostra: Finestra sul fiume, ultimo “regalo” di Otto Beit alla JAG, ed a noi.
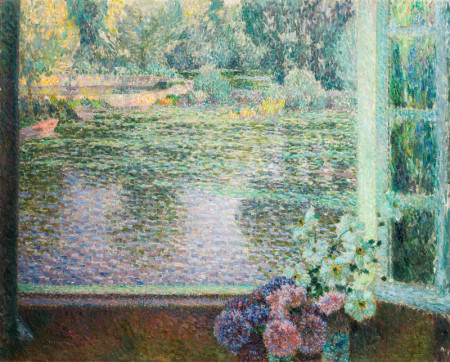 Confrontandola con la biografia dell’autore, verifichiamo che l’opera appartiene alla fase artistica del pittore, cominciata all’incirca con l’inizio del nuovo secolo, nella quale la figura umana, nonostante vi sia evocata, è di fatto esclusa dalla sua pittura intimista.
Confrontandola con la biografia dell’autore, verifichiamo che l’opera appartiene alla fase artistica del pittore, cominciata all’incirca con l’inizio del nuovo secolo, nella quale la figura umana, nonostante vi sia evocata, è di fatto esclusa dalla sua pittura intimista.
Così come i giardini sono deserti, le tavole sono imbandite per ipotetici ospiti e la campagna appare solitaria, la presenza di una finestra, inquadrata dall’interno di un’abitazione, presuppone qualcuno che la abiti, che ne abbia aperto il vetro e che attraverso di essa guardi all’esterno, verso il fiume e la rigogliosa vegetazione sullo sfondo. Anche i fiori, nel vaso vicino al suo angolo destro, qualcuno li avrà pur messi per godere della loro vista.
È l’espressione di una concezione silente e quieta, quasi placata, per certi versi addirittura inquietante, come sono inquietanti le acque del fiume, dal colore molto vicino a quello degli infissi, e che sembra siano prossime ad arrivare al livello della finestra e ad inondare la casa.
Realizzata con una tecnica neo-impressionista e un cromatismo assai contenuto, dalle sfumature calde e dalle tonalità raffinate e dolci, tutte intonate sul verde, la tela si pone in diretta contiguità con Signac, come osserva trionfante la mamma in visita rivolta al ragazzino che accompagna: “… Vedi Alessandro? È un altro esempio di Pointillisme, come La Rochelle di Signac!”. Purtroppo lui vi passa accanto velocemente, a testa bassa senza degnarla di uno sguardo: “Lo so, lo so…!!!”.
Comprensibile difficoltà di genitori che vogliano educare i figli al bello come faceva la mamma di Seurat!
Ma quel che si semina non mancherà di dare frutto. Personalmente ricordiamo ancora i nostri, immobili davanti ad un camino in marmo nel Palazzo Ducale di Urbino del quale invece noi eravamo ansiosi di trovare la via per uscirne. O quando in Brera, anni dopo, guardavamo in alto sulle architravi delle porte i numeri delle sale calcolando quanti ne mancassero per lasciare la Pinacoteca assieme agli amici che, a nostro avviso, vi si stavano intrattenendo un po’ troppo a lungo.
Invece ora siamo noi a poter sostare ore ad ammirare un dipinto, ed passare intere giornate a casa a ristudiarlo. Signora mamma di Alessandro: abbia fiducia!
Per chiudere la parentesi, ed il discorso su quest’opera, spiace dover osservare che sembra un po’ “piazzata” più dove c’era posto anziché con maggiore attenzione alla successione stilistica del percorso espositivo. Oltretutto un po’ sacrificandola in una collocazione non adeguata ad apprezzarne al meglio l’effetto ottico che avrebbe potuto fare ad un occhio che avesse avuto spazio sufficiente per distanziarsene quanto ci sembra che sarebbe stato necessario.
Successione che riprende correttamente con altri due rappresentanti del movimento Nabis, al quale già faceva riferimento Maillol, visto poco addietro.
I NABIS
L’autoproclamata “confraternita dei Nabis”, un piccolo gruppo dissidente di giovani artisti parigini usciti dall’Académie Julian e dall’École des Beaux-Arts, costituitosi con l’intento di rinnovare la pittura e che realizzava opere improntate al simbolismo e alla spiritualità, nasce ufficialmente nell’ottobre 1888: quando Paul Sérusier (1864-1927) mostra al consesso un piccolo olio dipinto a Pont-Aven, in Bretagna [(conservato oggi al Musée d’Orsay di Parigi)], seguendo i consigli di Paul Gauguin che lì viveva e che era appositamente andato ad incontrare per trovare finalmente, grazie a lui, il modo di dipingere che gli corrispondesse.
Appena dietro la pensione che ospitava gli artisti c’era un boschetto frequentato da coppiette e perciò ribattezzato Bois d’Amour. Non appena vi giunge, Sérusier sente di essere arrivato a quel che cerca e ricorda le parole di Gauguin “Ė solo l’occhio dell’ignorante che assegna un colore fisso e immutabile a ogni oggetto” e: “Come vedi questi alberi? Sono gialli. Ebbene, mettici del giallo. Quest’ombra decisamente blu, colorala con una tonalità oltremare. Queste foglie rosse, dipingile di vermiglio”.
Ora sa cosa deve fare e si sente “liberato da tutti gli ostacoli che si frapponevano al suo istinto di pittore”. Desidera talmente dipingere da cominciare a stendere i colori su quel che ha immediatamente sottomano: il coperchio della sua scatola di sigari. Qui il “suo” paesaggio prende forma diventando puro colore, in masse variopinte che ne fanno intuire tutti gli elementi ma senza prospettiva né profondità. Sérusier ha trovato un modo nuovo di guardare e dipingere la natura: non gli interessa presentare la realtà così com’è, ma interpretarla e trasformarla come le sue sensazioni gli dettano.
Pochi giorni dopo l’incontro, Gauguin raggiunge Van Gogh ad Arles e Sérusier torna a Parigi, custodendo il suo quadretto come fosse un tesoro. Non appena lo vedono, i compagni della confraternita, ne sono entusiasti scoprendovi le potenzialità della pittura libera che hanno sempre sognato e trovano conferma alla loro idea “che un quadro, ancora prima di essere un cavallo, una donna nuda, o un qualsiasi episodio, non è che una superficie piana ricoperta di colori messi insieme con un certo ordine”.
Non sembrerebbe granché, ma si tratta di una tappa fondamentale nel passaggio tra pittura figurativa e pittura astratta. La sintesi fra l’esperienza di Gauguin, il desiderio di libertà di Sérusier e l’atmosfera di Pont-Aven contribuirà a cambiare per sempre il modo di rappresentare la realtà.
Intanto il dipinto di Pont-Aven diventa un prezioso “talismano”, come lo ribattezzano con un titolo felice che subito si diffonde: modello e simbolo dei Nabis dei quali fecero parte i pittori Paul Sérusier, Aristide Maillol, Édouard Vuillard, Pierre Bonnard, Maurice Denis, Émile Bernard, Félix Vallotton, Henri-Gabriel Ibels, Paul Ranson, Jan Verkade, il poeta Auguste Cazalis e il musicista Pierre Hermant.
La denominazione di Nabis, o Le Nabis, che si diedero fu coniata dal Nabi Cazalis, esperto di ebraico e lingue orientali, al quale fu suggerita dalla parola ebraica nabiim (e dalla corrispondente araba: nabī) che significa profeti, ispirati.
In questi artisti dell’avanguardia post-impressionista, Sérusier, che ne era il catalizzatore, sviluppò un amore per il metodo sintetista che verteva sulla memoria e l’immaginazione più che sull’osservazione diretta.
Attivi negli anni ‘90 del XIX secolo, nel 1889, al caffè Volpini di Parigi organizzarono un’esposizione per presentare le opere di Sérusier, Bernard e Gauguin. Attenti a tutte le declinazioni della cultura, si interessavano anche di musica e di letteratura, leggendo Baudelaire e Mallarmé, e si concepivano come una confraternita unita nella diffusione di una nuova sensibilità pittorica e nella ricerca delle vere fonti dell’arte. Che per loro non consiste nella descrizione di un paesaggio o di un avvenimento, ma nell’espressione interiore, quindi il tema passa in secondo piano rispetto alla disposizione dei colori, che, posti in rapporto l’uno rispetto all’altro, determinano un accordo rivolto ad esprimere un significato unico e irripetibile.
I Nabis non cercavano la forza espressiva, ma la purezza, la bidimensionalità, la sintesi formale, la flessuosità della linea e la morbidezza del colore, utilizzato per evocare un mondo lontano e mistico nonostante i temi delle loro opere fossero quelli della quotidianità.
Fin dal 1891 pubblicarono sulla “Revue blanche” i loro lavori: litografie e manifesti ispirati alle decorazioni simboliste di Puvis de Chavannes, agli affreschi italiani del Quattrocento ed alle stampe giapponesi.
Nel 1895 furono profondamente colpiti dalla mostra che il mercante d’arte Ambroise Vollard ospitò nella sua galleria: dedicata a Cézanne che, a loro modo di vedere, aveva voluto trasformare l’Impressionismo in una corrente pittorica “solida e duratura”.
Infine, sebbene condividessero la volontà di superare il realismo impressionista e di creare un linguaggio capace di rappresentare le emozioni allo stato puro, nel gruppo si svilupparono diverse tendenze finché, tra il 1896 ed il 1897, cominciò a sfaldarsi. E dopo l’ultima mostra del 1900, ognuno proseguì su strade autonome.
 A questo movimento dunque appartenne Édouard Vuillard (Cuiseaux, 11 novembre 1868 - La Baule-Escoublac, 21 giugno 1940) che abbiamo già conosciuto come cofondatore del Salon d’Automne e fu convinto ad unirsi al gruppo da Maurice Denis nel 1889.
A questo movimento dunque appartenne Édouard Vuillard (Cuiseaux, 11 novembre 1868 - La Baule-Escoublac, 21 giugno 1940) che abbiamo già conosciuto come cofondatore del Salon d’Automne e fu convinto ad unirsi al gruppo da Maurice Denis nel 1889.
In principio Vuillard fu riluttante all’idea che il pittore non dovesse cercare di riprodurre realisticamente quello che vedeva, ma finì, verso il 1890, per cimentarsi nelle sue prime opere sintetiste.
In mostra, l’influsso dei Nabis è presente nella sintesi e bidimensionalità di Pasticceria del 1898/9 (immagine inclusa nell'approfondimento). Mentre si allontana da questa scuola la più tarda e formalmente semplificata Lampada in un interno, del 1908 (qui sopra).
Sempre indistintamente catalogato dalla JAG come esponente della “French School”, ma è comprensibile la necessità di semplificare la proposta per il pubblico della punta estrema dell’Africa, è l’ultimo Nabis in mostra, colui che all’interno del gruppo aveva il titolo di Nabi japonard: Pierre Bonnard (Fontenay-aux-Roses, 3 ottobre 1867 - Le Cannet, 23 gennaio 1947). del quale vediamo una litografia: Il bagno, del 1925 e Tramonto primaverile, del 1909.
Figlio di un funzionario ministeriale, sceglie di dedicarsi alla pittura dopo il diploma in legge e, dal 1891, espone con i Nabis al Salon des Indépendants. Al pari degli altri Nabis, trae costante ispirazione dalle scienze occulte e dalla magia: le ricerche esoteriche lo allontanano progressivamente dal realismo e dal naturalismo impressionista e lo avvicinano ad una pittura simbolista che viene ammirata da Guillaume Apollinaire.
 Suoi modelli stilistici sono le opere del periodo bretone di Paul Gauguin e le stampe giapponesi, da cui assimila il tentativo di deformare la realtà enfatizzando gli elementi suggestivi e carichi di significati simbolici; mentre la sua reazione all’Impressionismo si basa su una pittura più meditata ma con un uso più incisivo del colore.
Suoi modelli stilistici sono le opere del periodo bretone di Paul Gauguin e le stampe giapponesi, da cui assimila il tentativo di deformare la realtà enfatizzando gli elementi suggestivi e carichi di significati simbolici; mentre la sua reazione all’Impressionismo si basa su una pittura più meditata ma con un uso più incisivo del colore.
Il linguaggio pittorico di Bonnard è totalmente diverso da quello delle avanguardie storiche rappresentate dai suoi coetanei Matisse e Kandinskij: sulla scia dei grandi esponenti dell’Impressionismo, Bonnard dichiara in uno scritto di voler proseguire e sviluppare la loro ricerca per «superarli nelle loro impressioni naturalistiche del colore».
Dal 1900 in poi Bonnard continua a esporre con crescente successo e compie numerosi viaggi alla ricerca di nuovi soggetti. In questo periodo attraversa un nuovo ripensamento dell’Impressionismo: alla presa diretta della realtà si affianca un’atmosfera di malinconica lontananza. Anche i temi centrali della sua arte, fra i quali continuano ad essere i paesaggi, si fanno ora più gioiosi ma, al tempo stesso, strazianti.
Chissà se vediamo bene identificando una traccia di ciò nella sedia vuota accanto alla donna nel quadro in mostra. Che ci appare caratterizzato da preminenti rapporti di luce fra figure e oggetti e da colori estremamente variegati attorno al madreperla.
V - IL PRIMO NOVECENTO: ESPRESSIONISMO, FAUVES, CUBISMO
 Il mondo, anche artistico, sta dunque cambiando e nei primi decenni del XX secolo si stanno già affermando le avanguardie i cui venti già soffiano in Europa dal 1909: Picasso aveva dipinto due anni prima Les Demoiselles d’Avignon e si stava accingendo con Braque alle prime sperimentazioni cubiste, Matisse aveva già da tempo esposto con i Fauves, Marinetti pubblicava proprio in quell’anno il suo Manifesto del Futurismo e la ricerca di van Gogh, Gauguin, Cézanne e Seurat era ormai entrata nella letteratura artistica e sentita come modello dalle nuove generazioni. Ma ancora c’è chi dipinge al modo degli Impressionisti e chi ad essi è ancora affezionato.
Il mondo, anche artistico, sta dunque cambiando e nei primi decenni del XX secolo si stanno già affermando le avanguardie i cui venti già soffiano in Europa dal 1909: Picasso aveva dipinto due anni prima Les Demoiselles d’Avignon e si stava accingendo con Braque alle prime sperimentazioni cubiste, Matisse aveva già da tempo esposto con i Fauves, Marinetti pubblicava proprio in quell’anno il suo Manifesto del Futurismo e la ricerca di van Gogh, Gauguin, Cézanne e Seurat era ormai entrata nella letteratura artistica e sentita come modello dalle nuove generazioni. Ma ancora c’è chi dipinge al modo degli Impressionisti e chi ad essi è ancora affezionato.
È così anche per la JAG. Se il ruolo di Lane è infatti notevole nel diffondere il gusto Impressionista, non si può dire che sia stato altrettanto attento alla scena più strettamente contemporanea.
Come riconosce la curatrice della mostra “egli, infatti, non sembra sapersi spingere oltre l’ottava decade dell’Ottocento, ignorando, o comunque non sostenendo né apprezzando, i linguaggi più attuali”. Non è un caso che “la più recente delle opere francesi presenti nella collezione continuava a essere un paesaggio di Monet del 1873” e “Bisognerà attendere ancora qualche anno perché questo limite venga superato”. Peraltro, almeno stando a quanto si è visto a Monza, non proprio con opere rappresentative della migliore produzione degli artisti in collezione.
Per l’Espressionismo troviamo alcuni disegni.
 Di Edvard Munch (Ådalsbruk, Norvegia 12 dicembre 1863 - Oslo, 23 gennaio 1944) Due figure, del 1898, ci proietta immediatamente nel nuovo secolo.
Di Edvard Munch (Ådalsbruk, Norvegia 12 dicembre 1863 - Oslo, 23 gennaio 1944) Due figure, del 1898, ci proietta immediatamente nel nuovo secolo.
Un decennio prima l’autore era arrivato a Parigi e nel 1893, a Berlino, aveva già dipinto L’urlo. Ed anche su questo foglio, in contrasto con l’ordinata firma dell’artista, traspare tutta la sua visione macabra del mondo, determinata dall’interminabile serie di disgrazie familiari che provarono Edvard sin dalla fanciullezza. Che una visitatrice riconosce esclamando: “sono tutti così in Norvegia, sempre la stessa faccia dell’Urlo!”.
 Accade lo stesso per i pochi segni di matita del Ritratto di Mme (Georges) Van Muyden che Amedeo Clemente Modigliani (Livorno, 12 luglio 1884 - Parigi, 24 gennaio 1920), traccia nel 1915 e nei quali, oltre a vedervi già nel bianco e nero quello che sarà il ritratto finito, troviamo tutta l’essenza dell’artista italiano, a sua volta trasferitosi a Parigi dal 1906.
Accade lo stesso per i pochi segni di matita del Ritratto di Mme (Georges) Van Muyden che Amedeo Clemente Modigliani (Livorno, 12 luglio 1884 - Parigi, 24 gennaio 1920), traccia nel 1915 e nei quali, oltre a vedervi già nel bianco e nero quello che sarà il ritratto finito, troviamo tutta l’essenza dell’artista italiano, a sua volta trasferitosi a Parigi dal 1906.
L’interesse per l’arte africana e la suggestione da questa esercitata su di lui e che riscontriamo nei volti stilizzati e nei colli affusolati che caratterizzano i suoi ritratti femminili. Ritratti nei quali riesce magistralmente a catturare attitudini e personalità dei suoi modelli come si è ampiamente documentato in Modigliani, Soutine e gli artisti di Montparnasse (leggi di più >>>) alla cui lettura rinviamo gli interessati ad approfondire la conoscenza dell’artista.
 Fra i due disegni porta colori, e che colori, Andrè Derain (Chatou,10 giugno 1880 - Garches, 8 settembre 1954) Con Giovane donna dai capelli rossi del 1928 e, soprattutto, con la dirompente vivacità di colori dei petali carnosi, che sembrano voler emergere dal quadro, delle sue Dalie.
Fra i due disegni porta colori, e che colori, Andrè Derain (Chatou,10 giugno 1880 - Garches, 8 settembre 1954) Con Giovane donna dai capelli rossi del 1928 e, soprattutto, con la dirompente vivacità di colori dei petali carnosi, che sembrano voler emergere dal quadro, delle sue Dalie.
A conferma del giudizio che diede di lui Guillaume Apollinaire, per il quale illustrò un libro di poesie, quando lo definì “personaggio tormentato, innamorato della forma e del colore”.
Introdotto alla pittura da De Vlaminck e Matisse, espose nel 1905 al Salon d'Automne e al Salon des Indépendants collocandosi tra i Fauves. Ai quali però non aderì completamente.
Anche in seguito, seppure accostandosi allo stile di altri artisti e correnti del suo tempo, se ne tenne sempre ad una certa distanza conservando la propria riconoscibile autonomia. Una strada indipendente che mantenne anche quando, dopo il 2011, tornò all’ordine ed alle forme classiche di una pittura più tradizionale che riscopriva la prospettiva ed il chiaroscuro. La fascinazione esercitata su di lui dal “primitivismo” e dalla scultura africana furono preludio al suo periodo “gotico”, fatto di figure solenni e severe nature morte, attraversato il quale arrivò, infine, ad appassionarsi ai quadri di figura: dapprima autoritratti, poi scene di genere, ed infine ritratti.
FAUVES
Come già si è anticipato nella panoramica sui “Salon”, i Fauves ebbero l’opportunità di presentarsi con una prima mostra collettiva durante il Salon d’Automne del 1905. Il suo vicedirettore, George Desvallières, anch’egli pittore, durante un comune periodo di studio aveva conosciuto alcuni neo espressionisti francesi e pensò di amplificare l’effetto dirompente delle loro singole individualità raggruppandone le opere nell’ottava sala dell’esposizione: la sala centrale del Grand Palais di Parigi che l’ospitava.
Entrandovi, e vedendovi una statua tradizionale circondata da dipinti dai colori molto violenti e accesi, Louis Vauxcelles, uno dei più influenti critici d’arte del tempo, per la “selvaggia” violenza espressiva del colore steso in tonalità pure, sembra che abbia esclamato: “Ecco Donatello fra le belve!” definendo la sala come una “cage aux fauves” cioè una “gabbia delle belve”.
L’accezione dell’osservazione era naturalmente negativa ma, come si è visto anche per gli Impressionisti, determinò l’effetto opposto suscitando interesse per gli artisti ai quali era stata rivolta: Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, Henry Manguin e Charles Camoin.
Donna con cappello (Femme au chapeau), di Matisse fu uno dei dipinti che suscitarono il maggior clamore. L’immagine di Amélie, la moglie del pittore, vestita in modo borghese ma eccessivo, vi risulta dall’accostamento di lineei e macchie gialle, verdi, blu e viola. I tratti ordinati di Van Gogh, accostati alle pennellate libere di Turner dimostrano come l’origine del movimento vada ricercata nell’inserimento di spinte dagli accenti romantici e nordici, come quelli proposti da Munch, all’interno della tradizione impressionista francese di fine Ottocento.
Questo movimento artistico d’avanguardia in realtà non fu mai un vero gruppo di artisti che condividessero un programma ed una vera comunità d’intenti. Nelle loro discussioni l’Impressionismo era il tema più ricorrente, spesso considerato in termini negativi ma apprezzandone la novità di una luce generata dall’accostamento di colori puri.
L’Espressionismo tedesco ne riprese i temi principali: esaltazione della forza dell’arte primitiva e libertà dell’artista da vecchie convenzioni e formalismi obsoleti. Da esso, invece, i Fauves si distinsero perché meno esistenzialmente angosciati e meno critici e polemici verso la società e, viceversa, sulla scia di Van Gogh e di Gauguin, più interessati all’uso del colore libero e con funzione non solo costruttiva ma anche emotiva.
Furono i primi ad interessarsi di arte africana e ciò si rispecchia nella loro arte: basata su forme semplificate, abolizione di prospettiva e chiaroscuro, uso di colori vivaci e innaturali, uso incisivo del colore puro, spesso spremuto direttamente dal tubetto sulla tela, e di netta e marcate linee di contorno.
Diversamente dall’arte accademica, il significato dell’opera non aveva più importanza, soppiantato da forma, colore, immediatezza. La loro arte innovativa cercava nuove modalità espressive, fondate sull’autonomia del quadro, muovendo da suggestioni e stimoli diversi: il rapporto con la realtà visibile non era più naturalistico, perché la natura era intesa semplicemente come un repertorio di segni al quale attingere per una loro libera trascrizione.
L’esperienza dei Fauves ebbe breve durata temporale ma fu di grande importanza nell’evoluzione dell’arte. Furono infatti attivi soltanto fino al 1907 quando la grande retrospettiva su Cézanne contribuì a rompere la già debole unità del movimento indirizzandone alcuni esponenti verso nuove destinazioni favorì la repentina ascesa del cubismo. Paradossale reazione all’eccesso dei Fauves e visto come desiderio di forma e di maggiore organizzazione. Esigenza di porre un freno all’assoluta libertà del colore: all’esaltazione della “pittura pura” e del “colore esplosivo” che dovevano da soli creare la forma e diventare realtà.
 Esponente di spicco dei Fauves, Henry Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 31 dicembre 1869 - Nizza, 3 novembre 1954) introduce la sezione del pieno Novecento della JAG con tre litografie (in nero). Donna seduta con mani dietro la testa, e Ballerina di spalle allo specchio che si inchina, o forse prova l’inchino, ed intanto dallo specchio guarda l’osservatore. A furia di tornarvi davanti più e più volte ci è parso di percepire, attraverso lo specchio, lo sguardo di Matisse stesso guardare noi visitatori!
Esponente di spicco dei Fauves, Henry Matisse (Le Cateau-Cambrésis, 31 dicembre 1869 - Nizza, 3 novembre 1954) introduce la sezione del pieno Novecento della JAG con tre litografie (in nero). Donna seduta con mani dietro la testa, e Ballerina di spalle allo specchio che si inchina, o forse prova l’inchino, ed intanto dallo specchio guarda l’osservatore. A furia di tornarvi davanti più e più volte ci è parso di percepire, attraverso lo specchio, lo sguardo di Matisse stesso guardare noi visitatori!
Uno sguardo che ritroviamo nella Donna con fiori che “sentiamo” di conoscere avendolo già visto in altri volti incontrati a Palazzo Reale di Milano nella mostra il Volto del Novecento (leggi di più >>>). Di questa opera ci interessano anche le geometrie. La donna è, infatti, seduta col gomito appoggiato ad un tavolino in disequilibrio, quasi verticale, al punto da darci l’impressione che il vaso con i fiori stia per caderci addosso in sala, in evidente contrasto con lo sfondo a linee orizzontali sulla sinistra.
 Primo alfiere del Cubismo è, naturalmente, Pablo Picasso (Malaga, 25 ottobre 1881 - 8 aprile 1973, Mougins, Francia) del quale la JAG ci offre due opere in bianco e nero: Donna con collana, del 1947, e Busto in stile moderno, del 1949, accostati al vivace, e non avrebbe potuto essere diversamente, Arlecchino II del 1971.
Primo alfiere del Cubismo è, naturalmente, Pablo Picasso (Malaga, 25 ottobre 1881 - 8 aprile 1973, Mougins, Francia) del quale la JAG ci offre due opere in bianco e nero: Donna con collana, del 1947, e Busto in stile moderno, del 1949, accostati al vivace, e non avrebbe potuto essere diversamente, Arlecchino II del 1971.
Di quest’ultimo l’autore risulta abbia dichiarato che costituisce l’apice dalla sua ricercata regressione: il desiderio di disimparare tutto quel che la sua esperienza gli ha insegnato per ritrovare l’immediatezza della creatività infantile.
 Confessiamo la lesa maestà di non trovare l’opera così significativa, apprezzando molto di più il Ritratto di donna del 1910 di Albert Leon Gleizes (Parigi, 8 dicembre 1881 – Avignone, 24 giugno 1953) caratterizzato dalla tavolozza scura dei suoi primi dipinti.
Confessiamo la lesa maestà di non trovare l’opera così significativa, apprezzando molto di più il Ritratto di donna del 1910 di Albert Leon Gleizes (Parigi, 8 dicembre 1881 – Avignone, 24 giugno 1953) caratterizzato dalla tavolozza scura dei suoi primi dipinti.
Nella prima metà del Novecento Gleizes è esponente e fondatore di altri movimenti come la Section d’Or (Sezione Aurea) e Abstraction Création e Guillaume Apollinaire, fra i pochi esponenti della cultura del tempo a prendere le parti del Cubismo, lo colloca fra i Cubisti “eretici” per via del suo sguardo, diverso da quelli di Picasso e Bracque, che sottopone a sintesi geometrica il soggetto ed è attento al suo lato luminoso ed al colore.
 Ancor più ci piacciono gli evanescenti profili delle Tre donne nude, del 1925, di Ossip Zadkine (Vicebsk, Bielorussia, 4 luglio 1890 - Parigi, 25 novembre 1967).
Ancor più ci piacciono gli evanescenti profili delle Tre donne nude, del 1925, di Ossip Zadkine (Vicebsk, Bielorussia, 4 luglio 1890 - Parigi, 25 novembre 1967).
I loro corpi sembrano costituiti da una pellicola trasparente riempita di fumo variamente colorato, per distinguerle, in tenui cromie grigio, rosa ed arancio. Sulle quali l’artista, sempre usando abilmente i colori, evidenzia due mani: una bianca su grigio e l’altra nera.
VI - SECONDO NOVECENTO E POP ART
Anch’essa eccessivamente compressa, specialmente volendola considerare rappresentativa di un’epoca, è la penultima sezione della mostra, dedicata al Secondo Novecento.
 Più appariscente è naturalmente la Pop Art. C’è Roy Lichtenstein (Manhattan, New York, 27 ottobre 1923 - 29 settembre 1997) che dipinge scene come se fossero una tavola di una striscia di fumetto. Lo è senz'altro CRAK! Sparo, del 1964, che ci lascia col dubbio amletico su cosa mai avrà voluto rappresentate e, soprattutto, da appassionati di fumetti: quale sarà stata la scena precedente? Chi sono i “Petits” chiamati al combattimento dalla giovane donna che sta sparando? Ed ancora: chi è? Contro chi sta combattendo? Come sarà finita la storia? Troppe domande. Che restano senza risposta o forse, chi lo sa, sarà perduta nel vento.
Più appariscente è naturalmente la Pop Art. C’è Roy Lichtenstein (Manhattan, New York, 27 ottobre 1923 - 29 settembre 1997) che dipinge scene come se fossero una tavola di una striscia di fumetto. Lo è senz'altro CRAK! Sparo, del 1964, che ci lascia col dubbio amletico su cosa mai avrà voluto rappresentate e, soprattutto, da appassionati di fumetti: quale sarà stata la scena precedente? Chi sono i “Petits” chiamati al combattimento dalla giovane donna che sta sparando? Ed ancora: chi è? Contro chi sta combattendo? Come sarà finita la storia? Troppe domande. Che restano senza risposta o forse, chi lo sa, sarà perduta nel vento.
 E non può mancare Andy Warhol (Pittsburgh, Pennsylvania, 6 agosto 1928 - Manhattan, New York, 22 febbraio 1987).
E non può mancare Andy Warhol (Pittsburgh, Pennsylvania, 6 agosto 1928 - Manhattan, New York, 22 febbraio 1987).
Tutto sommato più rassicurante e meno problematico nel ritratto in fotografia di Joseph Beuys (Krefeld, Germania, 12 maggio 1921 - Düsseldorf, 23 gennaio 1986).
“Era un grande fotografo”, commenta una visitatrice, apprezzando l’abilità del Newyorkese, davanti all’ingrandimento a tutta parete del pittore e scultore tedesco, “anche in bianco e nero riesce a farcene vedere gli occhi azzurri”.
In fin dei conti sono secondarie (superflue?) le serigrafie dei negativi che lo affiancano a sinistra ed a destra, variate in rosso ed in bianco fra effimeri bagliori scintillanti come paillettes: ben rappresentative della nostra personale opinione su Warhol (leggi di più >>> Andy Warhol: profeta della decadenza del nostro tempo?)
 Un altro rimando al sopra citato Il volto del Novecento ci corre l’obbligo di segnalarlo anche per Francis Bacon (Dublino, 28 ottobre 1909, - Madrid, 28 aprile 1992) di cui la JAG ci propone in mostra le forme corrose e deturpate che scompaginano i lineamenti del viso che l’artista irlandese ha elaborato in Studio per ritratto di un uomo, del 1969.
Un altro rimando al sopra citato Il volto del Novecento ci corre l’obbligo di segnalarlo anche per Francis Bacon (Dublino, 28 ottobre 1909, - Madrid, 28 aprile 1992) di cui la JAG ci propone in mostra le forme corrose e deturpate che scompaginano i lineamenti del viso che l’artista irlandese ha elaborato in Studio per ritratto di un uomo, del 1969.
Visione che (chissà come mai!? - quando si dice che a volte l’inconscio induce pensieri dal significato ambivalente), ci porta alla memoria il visitatore che circolava in mostra facendo scricchiolare in continuazione la bottiglietta d’acqua vuota che aveva portato con sé.
Ma perché non te ne vai? Cercavamo di fargli capire telepaticamente. Invano. Non c’è stato verso di seminarlo e ci è rimasto attaccato per buona parte del percorso. Disperazione!
Rispetto ai tre più noti autori appena citati, abbiamo invece maggiormente apprezzato due figure meno celebrate dai mezzi di comunicazione di massa ed a noi in precedenza sconosciute (ma, del resto, chi frequenta le mostre d’arte non è tenuto ad essere un esperto della materia).
L’oscuro e sfumato Figure in piedi, carboncino ed inchiostro del 1938 di Henry Spencer Moore (Castleford, Regno Unito, 30 luglio 1898 - Much Hadham, 31 agosto 1986) forse più conosciuto come scultore. Sua qualifica appresa studiandone poi a casa la biografia, con la soddisfazione di averlo “intuito”, avendo notato, sulla sinistra delle figure scheletriche da lui dipinte, un oggetto nel quale abbiamo creduto di individuare una scultura di Boccioni. Forse indotti al pensiero dal fatto che, non soltanto per l’analogo verde alga che li pervade entrambi, il dipinto ci ha ricordato Stati d’animo - quelli che restano, del 1911, esposto al Museo del Novecento di Milano nella sezione dedicata all’artista italiano, e che calamita sempre la nostra attenzione ogni volta che la rivediamo per le sue ombre che sembrano fluttuare fra gli enormi steli d’erba di prato gigantesco dal quale vengono “assorbiti”.
 Così come una donna, la sua fondatrice, l’aveva aperta, è ancora una donna a chiude la sezione europea della JAG in mostra a Monza. Ed ancora si tratta di una donna di carattere: Vanessa Bell (Londra, 30 maggio 1879 - Charleston Farmhouse, Firle, 7 aprile 1961) esponente dell’esclusivo Cenacolo di Bloomsbury che dà scandalo nell’Inghilterra di inizio Novecento. Un gruppo di artisti che, dal 1905 circa alla Seconda guerra mondiale, si ritrovava con assiduità nel quartiere londinese di Bloomsbury e del quale fecero parte la sorella della Bell, Virginia Woolf, oltre a, fra gli altri, Duncan Grant, Dora Carrington, Roger Fry e via dicendo. Riecheggiando lo stile di Matisse, che amava, Vanessa Bell dipingeva ritratti e nature morte rese, come quella in mostra, con una tavolozza vivace a tonalità forti.
Così come una donna, la sua fondatrice, l’aveva aperta, è ancora una donna a chiude la sezione europea della JAG in mostra a Monza. Ed ancora si tratta di una donna di carattere: Vanessa Bell (Londra, 30 maggio 1879 - Charleston Farmhouse, Firle, 7 aprile 1961) esponente dell’esclusivo Cenacolo di Bloomsbury che dà scandalo nell’Inghilterra di inizio Novecento. Un gruppo di artisti che, dal 1905 circa alla Seconda guerra mondiale, si ritrovava con assiduità nel quartiere londinese di Bloomsbury e del quale fecero parte la sorella della Bell, Virginia Woolf, oltre a, fra gli altri, Duncan Grant, Dora Carrington, Roger Fry e via dicendo. Riecheggiando lo stile di Matisse, che amava, Vanessa Bell dipingeva ritratti e nature morte rese, come quella in mostra, con una tavolozza vivace a tonalità forti.
VII - IN SUDAFRICA
Come si è detto in principio, i primi fondatori e curatori della JAG non pensavano che l’arte africana fosse all’altezza della loro iniziativa e perciò acquistavano in Europa. Paradossalmente proprio negli stessi anni in cui, come si è visto, le avanguardie parigine si interessavano all’arte primitiva ed africana!
 Nonostante questa apparente incongruenza, Lady Phillips era consapevole (ed i suoi sforzi lo dimostrano) che un museo non è solo uno spazio nel quale raccogliere ed esporre opere d’arte; ma è anche un luogo prezioso per la società civile, dove fare e promuovere cultura, ed è comunque un riferimento per chi all’arte non è appassionato. Spinta dai suoi nobili ideali, Florence vedeva la nascita di una galleria pubblica come un’opportunità di crescita culturale per tutta la popolazione, oltre che un fattore di prestigio per l’alta società locale.
Nonostante questa apparente incongruenza, Lady Phillips era consapevole (ed i suoi sforzi lo dimostrano) che un museo non è solo uno spazio nel quale raccogliere ed esporre opere d’arte; ma è anche un luogo prezioso per la società civile, dove fare e promuovere cultura, ed è comunque un riferimento per chi all’arte non è appassionato. Spinta dai suoi nobili ideali, Florence vedeva la nascita di una galleria pubblica come un’opportunità di crescita culturale per tutta la popolazione, oltre che un fattore di prestigio per l’alta società locale.
E questo la JAG lo è diventata. Inaugurata l’11 ottobre 1910 con 196 opere, la sua interessante struttura, col timpano neoclassico aggettante sull’ingresso, oggi è arrivata ad ospitarne un migliaio: fra le quali anche numerosi ed importanti artisti africani, oltre ad un archivio ed una biblioteca dedicati a questo particolare filone artistico. Un’attualità ben sintetizzata dalla foto del 1986 che ce ne mostra l’architettura di inizio Novecento circondata dagli edifici moderni che ne caratterizzano il contesto odierno, nel Joubert Park, al centro di Johannesburg.
 Se un rimpianto possiamo dichiarare, è che quest’ultima sezione sia stata sacrificata in corridoio, e peccato non sapere nulla su chi fosse la Kalie ritratta nel 1925 da Maggie Lauber (1886 -1973) in Ritratto di Kalie del 1925.
Se un rimpianto possiamo dichiarare, è che quest’ultima sezione sia stata sacrificata in corridoio, e peccato non sapere nulla su chi fosse la Kalie ritratta nel 1925 da Maggie Lauber (1886 -1973) in Ritratto di Kalie del 1925.
Che, significativamente, come altri fra i dipinti Sudafricani in mostra, è un olio su... cartone.
Quanto all'autrice, i motori di ricerca sul web ci restituiscono i profili social di alcune sue odierne omonime!
 Di Maude Francis Eyston Sumner, nata a Joannesburg il 16 settembre 1902, sappiamo invece che era bianca e si era formata artisticamente alla scuola europea, conosciuta avendo vissuto anche in Francia ed a Londra prima di tornare in Sudafrica, dove morì nel 1985, ancora a Johannesburg.
Di Maude Francis Eyston Sumner, nata a Joannesburg il 16 settembre 1902, sappiamo invece che era bianca e si era formata artisticamente alla scuola europea, conosciuta avendo vissuto anche in Francia ed a Londra prima di tornare in Sudafrica, dove morì nel 1985, ancora a Johannesburg.
Nel suo Ritratto dell’artista, con la modella semisvestita sullo sfondo, crediamo di riconoscere lei stessa, oltre allo sguardo delle donne di Matisse.
Curiosamente esotica è la cornice, che sugli angoli ha disegni geometrici in stile africano e sulle fasce è verniciata in blu, sopra l’originario oro che emerge dove la ridipintura si sta scrostando!
Anche George Pemba (Port Elizabeth, Sudafrica, 1912 - Motherwell, Eastern Cape, 2001) ha l’onore di una pagina sulla planetaria enciclopedia libera.
 È un Afrikaans, non scappa dal Sudafrica, come altri artisti, per fare fortuna (peraltro più che legittima) dove può trovare maggiori opportunità per vedere valorizzato il proprio talento.
È un Afrikaans, non scappa dal Sudafrica, come altri artisti, per fare fortuna (peraltro più che legittima) dove può trovare maggiori opportunità per vedere valorizzato il proprio talento.
Sceglie invece di restare in patria dove conduce la sua resistenza di artista “militante” attento alle istanze sociali del suo tempo e della sua terra.
Categoria che dalle nostre parti è in declinante disarmo.
Del resto è africano il proverbio che dice: “Fiorisci dove sei piantato, e poi vai dove vuoi!”.
Tutto questo lo vediamo in I’m sorry madam, acquerello e matita del 1945, un’opera bella per come è dipinta, a colori vivaci, e per la muta fierezza con la quale la donna che ne è protagonista reagisce al diniego appena ricevuto: “mi dispiace signora” le viene detto, ma il dolore che le spezza il cuore resta chiuso in lei.
Kwa Stemele, altro olio su cartone del 1981, ancora di Pemba, è ancora una storia socio culturale che sembra arrivi dalle baracche degli schiavi sulle sponde del Mississippi al tempo delle origini della musica blues.
 Ed invece siamo negli anni ’80, a proposito dei quali soprassediamo su quel che succedeva in Italia (ed a Milano in particolare) ed il pianista con basco Rasta, occhiali ed orecchino è un jazzista che si curva sul pianoforte verticale al modo di Glenn Gould e suona per far ballare la gente del popolo in una piccola stanza, di notte, al lume di candela… nonostante il divieto imposto dalle autorità.
Ed invece siamo negli anni ’80, a proposito dei quali soprassediamo su quel che succedeva in Italia (ed a Milano in particolare) ed il pianista con basco Rasta, occhiali ed orecchino è un jazzista che si curva sul pianoforte verticale al modo di Glenn Gould e suona per far ballare la gente del popolo in una piccola stanza, di notte, al lume di candela… nonostante il divieto imposto dalle autorità.
Un quadro che per tante ragioni, che lasciamo ai lettori di condividere o smentire, ci fa pensare ai Mangiatori di patate di Van Gogh (leggi di più >>>).
Per finire, dopo il post Impressionismo con tendenza Espressionista, di nuovo con alcuni decenni di ritardo segue, naturalmente, anche il Cubismo Africano: con Selby Mvusi (Edendale, Kwa Zulu Natal, 1929 –Nairobi, 1967) e la sua Misura della città, del 1962.
 Diversamente da Pemba, sconvolto dalle asprezze dello scontro politico in Sudafrica, Mvusi abbandona fisicamente il campo di battaglia emigrando definitivamente all’estero.
Diversamente da Pemba, sconvolto dalle asprezze dello scontro politico in Sudafrica, Mvusi abbandona fisicamente il campo di battaglia emigrando definitivamente all’estero.
Ma vi resta con la sua arte ben sintetizzata da un commento non firmato “pescato” nella rete proprio in relazione al dipinto in mostra: “Tre personaggi, un ragazzino timido accanto a due uomini dall’aria severa, quasi minacciosa. Non sono in posa: ci guardano, guardano noi spettatori dall’altra parte della tela, dall’altra parte della barricata. Questa è la nostra città, la nostra gente, il nostro popolo. Gli sguardi dei tre personaggi sono più loquaci di mille parole. Venite, venite a scoprire le nostre vite, la nostra terra, il nostro paese. Venite a scoprire la nostra Africa”.
Anche per rispondere positivamente a questo appello, sarebbe forse stato più interessante sviluppare maggiormente quest’ultima sezione della mostra, e presentarla come testimonianza storica di una encomiabile iniziativa culturale anziché con nomi altisonanti come richiamo (nel 2015, a Pavia, il suo titolo era “Capolavori della Johannesburg Art Gallery – da Degas a Picasso”, e nel 2004 a Belluno “da Corot a Monet”, non sappiamo se e con quali eventuali variazioni nelle opere in catalogo). Ma in questo - diciamocelo, ed autodenunciamoci! - un po’ di colpa la ha anche il pubblico: in quanti saremmo venuti in Villa Reale se non fossimo stati attratti da Monet o da un altro suo pari?
APPENDICE 1
LA SORPRESA CHE NON TI ASPETTI
Possibile che una galleria d’arte della capitale di uno stato non abbia un proprio sito internet? Ricercando sulla rete immagini con le quali corredare questo articolo infatti, con nostra grande sorpresa non siamo riusciti a trovare un sito ufficiale della Johannesburg Art Gallery (JAG) ma soltanto un paio di indirizzi sui “social” ed il sito dell’Associazione Amici del museo di Joahnnesburg, che cerca di raccogliere fondi per sostenerne l’attività. L’indirizzo del sito non è reperibile per varie ragioni:
- non è un’istituzione indipendente ma un museo municipale (ad ingresso gratuito come è uso nel mondo anglosassone) e la sua gestione è sotto la responsabilità del City Council, il Consiglio Comunale, di Johannesburg e delle sue varie agencies (assessorati);
- attualmente è in riallestimento;
- ha subìto un allagamento delle cantine che ha messo a rischio la sopravvivenza delle opere in deposito; e lavori di rifacimento del tetto sono stati interrotti a causa di furti e danneggiamenti;
- la giunta municipale si è macchiata di pratiche sistematiche di corruzione e il management ha dato pure le dimissioni.
In pratica, la precedente Amministrazione Comunale ha fatto fallire la JAG ed ha letteralmente sperperato a favore degli “amici degli amici”, secondo la tipica mentalità tribalista e del familismo amorale tanto caro all’Africa nera, le risorse economiche ad essa destinate cosicché due appalti per rifare il tetto sono finiti peggio della nostra autostrada Salerno - Reggio Calabria.
L’attuale staff della Galleria così spiega la vicenda: dapprima i lavori sono stati affidati ad una ditta che non aveva i requisiti necessari per svolgerli, così sono stati interrotti. Poi è stata incaricata un’altra azienda, anch’essa “ammanicata” e che non aveva esperienza in gestione di Beni Culturali. Quest’ultima ha assunto manovalanza a basso costo, la quale, invece che lavorare, rubava il rame dai tetti.
In queste condizioni il tetto non ha retto alle piogge dell’ultimo fine settimana di gennaio 2017, che sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso obbligando la Direzione della JAG a chiudere il museo lunedì 30 gennaio 2017 “fino a nuovo avviso”!
Infatti la pioggia cadeva direttamente negli spazi della Galleria nel seminterrato, nello studio di conservazione a nel magazzino di arte contemporanea ben presto allagandoli.
Ai ragguagli sulla situazione richiesti da alcuni affezionati, lo staff ha così risposto:
“Ciao ***** invero nessuna opera d’arte è stata danneggiata e tutte sono state spostate in spazi sicuri. Non c’è più spazio nei depositi e, come si vede nelle immagini, una parte della collezione ha dovuto essere spostata alle sale di esposizione. Il governo precedente della città sapeva bene come drenare i fondi a favore dei propri amici. Ed ha raggiunto un grado di corruzione davvero sorprendente. La nuova amministrazione sembra invece avere un’autentica preoccupazione per il ruolo che l’arte può svolgere nella nostra città e nella società. Allora marchiamoli stretti e responsabilizziamoli affinché la JAG possa essere riportata alla sua piena gloria!”
Un visitatore ha così commentato:
“Oggi era la mia prima volta alla JAG ed era tutto così cupo. Tutti gli ingressi erano chiusi, tranne uno, sembrava deserta e triste da fuori e dentro non c’era niente da vedere. Molti spazi erano chiusi perché stanno allestendo una nuova mostra. Ma le aree aperte sono spoglie e minime. Non c’è niente da vedere. Stanze completamente vuote e muri nudi. Abbiamo anche incontrato altre due persone che passeggiavano e ci hanno chiesto “Dunque, c'è qualcosa da vedere qui?” E noi non abbiamo potuto fare altro che... scrollare le spalle. Nessuna collezione permanente sul display o niente. Dovrebbe essere chiusa finché è in questo stato, così deludente :( ”
In sostanza, visto che la JAG è vista come un simbolo dell’apartheid e della cultura bianca, la collezione permanente è stata spazzata via ed il museo (che in tutto e per tutto appare come un museo della “periferia” europea) continua ad ospitare mostre temporanee sugli artisti africani contemporanei. Roba da far rimpiangere ciò che, naturalmente, non si può rimpiangere.
È inoltre curioso che, in tempi di post-apartheid, la direzione non abbia avuto idea migliore che inviare il meglio della collezione in tournée Europa per mostre che, anche soltanto per quanto ne sappiamo noi, girano in Italia da qualche anno.
Occorre anche ammettere, però, che qualcosa di simile è successo con l’Accademia Carrara di Bergamo: che ha spedito per diversi mesi i capolavori in giro per il mondo (per esempio in Australia!), durante i suoi pluriennali lavori di ristrutturazione e riallestimento...
APPENDICE 2
E come se tutto ciò non bastasse...
ORRIBILIA KULTURALIA (vedi anche >>>)
Sempre girovagando sulla rete alla ricerca di immagini da utilizzare a corredo di questo racconto della mostra, scopriamo (per la verità con ben poco sollievo) che l’ignoranza culturale non è solo italiana.
Dopo la Palla di Pomodoro (nel senso dell'artista) del lungomare di Pesaro, che su alcune guide turistiche anglofone è citata come Tomato’s Ball (nel senso dell'ortaggio), apprendiamo che alla JAG possiedono ed espongono fra le loro collezioni nientemeno che le, sconosciute fuori dall'Africa, prove figurative del Sommo poeta Dante Alighieri: quando si dice di fare attenzione alle virgole (chi ha letto questa recensione dall'inizio capirà!).
Purtroppo è tutto vero e documentato: nel testo e relativa immagine sotto riportati.
"The Johannesburg Art Gallery's incredible collection of art includes sculpture, multi-media displays, painting, etching and photography. Discover works by Rodin, Dante, Gabriel Rossetti, Picasso, Monet and Moore sitting alongside work by South Africa's Gerard Sekoto, Alexis Preller, Maud Sumner, Sydney Kumalo and Ezrom Legae."

Dal sito internet >
http://www.southafrica.net/za/it/articles/entry/article-southafrica.net-the-johannesburg-art-gallery